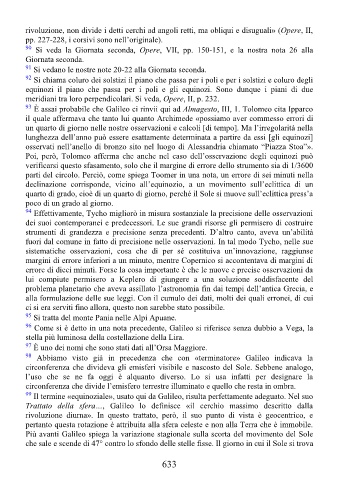Page 633 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 633
rivoluzione, non divide i detti cerchi ad angoli retti, ma obliqui e disuguali» (Opere, II,
pp. 227-228, i corsivi sono nell’originale).
90 Si veda la Giornata seconda, Opere, VII, pp. 150-151, e la nostra nota 26 alla
Giornata seconda.
91
Si vedano le nostre note 20-22 alla Giornata seconda.
92
Si chiama coluro dei solstizi il piano che passa per i poli e per i solstizi e coluro degli
equinozi il piano che passa per i poli e gli equinozi. Sono dunque i piani di due
meridiani tra loro perpendicolari. Si veda, Opere, II, p. 232.
93
È assai probabile che Galileo ci rinvii qui ad Almagesto, III, 1. Tolomeo cita Ipparco
il quale affermava che tanto lui quanto Archimede «possiamo aver commesso errori di
un quarto di giorno nelle nostre osservazioni e calcoli [di tempo]. Ma l’irregolarità nella
lunghezza dell’anno può essere esattamente determinata a partire da essi [gli equinozi]
osservati nell’anello di bronzo sito nel luogo di Alessandria chiamato “Piazza Stoa”».
Poi, però, Tolomeo afferma che anche nel caso dell’osservazione degli equinozi può
verificarsi questo sfasamento, solo che il margine di errore dello strumento sia di 1/3600
parti del circolo. Perciò, come spiega Toomer in una nota, un errore di sei minuti nella
declinazione corrisponde, vicino all’equinozio, a un movimento sull’eclittica di un
quarto di grado, cioè di un quarto di giorno, perché il Sole si muove sull’eclittica press’a
poco di un grado al giorno.
94
Effettivamente, Tycho migliorò in misura sostanziale la precisione delle osservazioni
dei suoi contemporanei e predecessori. Le sue grandi risorse gli permisero di costruire
strumenti di grandezza e precisione senza precedenti. D’altro canto, aveva un’abilità
fuori dal comune in fatto di precisione nelle osservazioni. In tal modo Tycho, nelle sue
sistematiche osservazioni, cosa che di per sé costituiva un’innovazione, raggiunse
margini di errore inferiori a un minuto, mentre Copernico si accontentava di margini di
errore di dieci minuti. Forse la cosa importante è che le nuove e precise osservazioni da
lui compiute permisero a Keplero di giungere a una soluzione soddisfacente del
problema planetario che aveva assillato l’astronomia fin dai tempi dell’antica Grecia, e
alla formulazione delle sue leggi. Con il cumulo dei dati, molti dei quali erronei, di cui
ci si era serviti fino allora, questo non sarebbe stato possibile.
95
Si tratta del monte Pania nelle Alpi Apuane.
96
Come si è detto in una nota precedente, Galileo si riferisce senza dubbio a Vega, la
stella più luminosa della costellazione della Lira.
97 È uno dei nomi che sono stati dati all’Orsa Maggiore.
98 Abbiamo visto già in precedenza che con «terminatore» Galileo indicava la
circonferenza che divideva gli emisferi visibile e nascosto del Sole. Sebbene analogo,
l’uso che se ne fa oggi è alquanto diverso. Lo si usa infatti per designare la
circonferenza che divide l’emisfero terrestre illuminato e quello che resta in ombra.
99
Il termine «equinoziale», usato qui da Galileo, risulta perfettamente adeguato. Nel suo
Trattato della sfera…, Galileo lo definisce «il cerchio massimo descritto dalla
rivoluzione diurna». In questo trattato, però, il suo punto di vista è geocentrico, e
pertanto questa rotazione è attribuita alla sfera celeste e non alla Terra che è immobile.
Più avanti Galileo spiega la variazione stagionale sulla scorta del movimento del Sole
che sale e scende di 47° contro lo sfondo delle stelle fisse. Il giorno in cui il Sole si trova
633