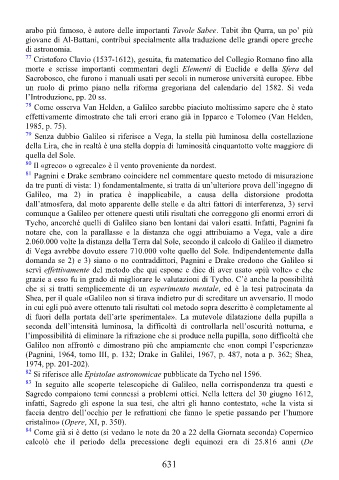Page 631 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 631
arabo più famoso, è autore delle importanti Tavole Sabee. Tabit ibn Qurra, un po’ più
giovane di Al-Battani, contribuì specialmente alla traduzione delle grandi opere greche
di astronomia.
77
Cristoforo Clavio (1537-1612), gesuita, fu matematico del Collegio Romano fino alla
morte e scrisse importanti commentari degli Elementi di Euclide e della Sfera del
Sacrobosco, che furono i manuali usati per secoli in numerose università europee. Ebbe
un ruolo di primo piano nella riforma gregoriana del calendario del 1582. Si veda
l’Introduzione, pp. 20 ss.
78
Come osserva Van Helden, a Galileo sarebbe piaciuto moltissimo sapere che è stato
effettivamente dimostrato che tali errori erano già in Ipparco e Tolomeo (Van Helden,
1985, p. 75).
79
Senza dubbio Galileo si riferisce a Vega, la stella più luminosa della costellazione
della Lira, che in realtà è una stella doppia di luminosità cinquantotto volte maggiore di
quella del Sole.
80
Il «greco» o «grecale» è il vento proveniente da nordest.
81
Pagnini e Drake sembrano coincidere nel commentare questo metodo di misurazione
da tre punti di vista: 1) fondamentalmente, si tratta di un’ulteriore prova dell’ingegno di
Galileo, ma 2) in pratica è inapplicabile, a causa della distorsione prodotta
dall’atmosfera, dal moto apparente delle stelle e da altri fattori di interferenza, 3) servì
comunque a Galileo per ottenere questi utili risultati che correggono gli enormi errori di
Tycho, ancorché quelli di Galileo siano ben lontani dai valori esatti. Infatti, Pagnini fa
notare che, con la parallasse e la distanza che oggi attribuiamo a Vega, vale a dire
2.060.000 volte la distanza della Terra dal Sole, secondo il calcolo di Galileo il diametro
di Vega avrebbe dovuto essere 710.000 volte quello del Sole. Indipendentemente dalla
domanda se 2) e 3) siano o no contraddittori, Pagnini e Drake credono che Galileo si
servì effettivamente del metodo che qui espone e dice di aver usato «più volte» e che
grazie a esso fu in grado di migliorare le valutazioni di Tycho. C’è anche la possibilità
che si si tratti semplicemente di un esperimento mentale, ed è la tesi patrocinata da
Shea, per il quale «Galileo non si tirava indietro pur di screditare un avversario. Il modo
in cui egli può avere ottenuto tali risultati col metodo sopra descritto è completamente al
di fuori della portata dell’arte sperimentale». La mutevole dilatazione della pupilla a
seconda dell’intensità luminosa, la difficoltà di controllarla nell’oscurità notturna, e
l’impossibilità di eliminare la rifrazione che si produce nella pupilla, sono difficoltà che
Galileo non affrontò e dimostrano più che ampiamente che «non compì l’esperienza»
(Pagnini, 1964, tomo III, p. 132; Drake in Galilei, 1967, p. 487, nota a p. 362; Shea,
1974, pp. 201-202).
82
Si riferisce alle Epistolae astronomicae pubblicate da Tycho nel 1596.
83
In seguito alle scoperte telescopiche di Galileo, nella corrispondenza tra questi e
Sagredo compaiono temi connessi a problemi ottici. Nella lettera del 30 giugno 1612,
infatti, Sagredo gli espone la sua tesi, che altri gli hanno contestato, «che la vista si
faccia dentro dell’occhio per le refrattioni che fanno le spetie passando per l’humore
cristalino» (Opere, XI, p. 350).
84
Come già si è detto (si vedano le note da 20 a 22 della Giornata seconda) Copernico
calcolò che il periodo della precessione degli equinozi era di 25.816 anni (De
631