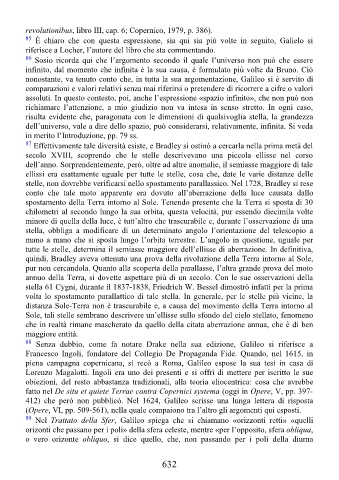Page 632 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 632
revolutionibus, libro III, cap. 6; Copernico, 1979, p. 386).
85
È chiaro che con questa espressione, sia qui sia più volte in seguito, Galielo si
riferisce a Locher, l’autore del libro che sta commentando.
86 Sosio ricorda qui che l’argomento secondo il quale l’universo non può che essere
infinito, dal momento che infinita è la sua causa, è formulato più volte da Bruno. Ciò
nonostante, va tenuto conto che, in tutta la sua argomentazione, Galileo si è servito di
comparazioni e valori relativi senza mai riferirsi o pretendere di ricorrere a cifre o valori
assoluti. In questo contesto, poi, anche l’espressione «spazio infinito», che non può non
richiamare l’attenzione, a mio giudizio non va intesa in senso stretto. In ogni caso,
risulta evidente che, paragonata con le dimensioni di qualsivoglia stella, la grandezza
dell’universo, vale a dire dello spazio, può considerarsi, relativamente, infinita. Si veda
in merito l’Introduzione, pp. 79 ss.
87 Effettivamente tale diversità esiste, e Bradley si ostinò a cercarla nella prima metà del
secolo XVIII, scoprendo che le stelle descrivevano una piccola ellisse nel corso
dell’anno. Sorprendentemente, però, oltre ad altre anomalie, il semiasse maggiore di tale
ellissi era esattamente uguale per tutte le stelle, cosa che, date le varie distanze delle
stelle, non dovrebbe verificarsi nello spostamento parallassico. Nel 1728, Bradley si rese
conto che tale moto apparente era dovuto all’aberrazione della luce causata dallo
spostamento della Terra intorno al Sole. Tenendo presente che la Terra si sposta di 30
chilometri al secondo lungo la sua orbita, questa velocità, pur essendo diecimila volte
minore di quella della luce, è tutt’altro che trascurabile e, durante l’osservazione di una
stella, obbliga a modificare di un determinato angolo l’orientazione del telescopio a
mano a mano che si sposta lungo l’orbita terrestre. L’angolo in questione, uguale per
tutte le stelle, determina il semiasse maggiore dell’ellisse di aberrazione. In definitiva,
quindi, Bradley aveva ottenuto una prova della rivoluzione della Terra intorno al Sole,
pur non cercandola. Quanto alla scoperta della parallasse, l’altra grande prova del moto
annuo della Terra, si dovette aspettare più di un secolo. Con le sue osservazioni della
stella 61 Cygni, durante il 1837-1838, Friedrich W. Bessel dimostrò infatti per la prima
volta lo spostamento parallattico di tale stella. In generale, per le stelle più vicine, la
distanza Sole-Terra non è trascurabile e, a causa del movimento della Terra intorno al
Sole, tali stelle sembrano descrivere un’ellisse sullo sfondo del cielo stellato, fenomeno
che in realtà rimane mascherato da quello della citata aberrazione annua, che è di ben
maggiore entità.
88 Senza dubbio, come fa notare Drake nella sua edizione, Galileo si riferisce a
Francesco Ingoli, fondatore del Collegio De Propaganda Fide. Quando, nel 1615, in
piena campagna copernicana, si recò a Roma, Galileo espose la sua tesi in casa di
Lorenzo Magalotti. Ingoli era uno dei presenti e si offrì di mettere per iscritto le sue
obiezioni, del resto abbastanza tradizionali, alla teoria eliocentrica: cosa che avrebbe
fatto nel De situ et quiete Terrae contra Copernici systema (oggi in Opere, V, pp. 397-
412) che però non pubblicò. Nel 1624, Galileo scrisse una lunga lettera di risposta
(Opere, VI, pp. 509-561), nella quale compaiono tra l’altro gli argomenti qui esposti.
89
Nel Trattato della Sfer, Galileo spiega che si chiamano «orizzonti retti» «quelli
orizonti che passano per i poli» della sfera celeste, mentre «per l’opposito, sfera obliqua,
o vero orizonte obliquo, si dice quello, che, non passando per i poli della diurna
632