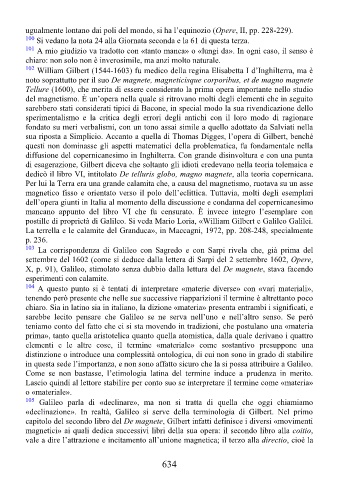Page 634 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 634
ugualmente lontano dai poli del mondo, si ha l’equinozio (Opere, II, pp. 228-229).
100
Si vedano la nota 24 alla Giornata seconda e la 61 di questa terza.
101
A mio giudizio va tradotto con «tanto manca» o «lungi da». In ogni caso, il senso è
chiaro: non solo non è inverosimile, ma anzi molto naturale.
102 William Gilbert (1544-1603) fu medico della regina Elisabetta I d’Inghilterra, ma è
noto soprattutto per il suo De magnete, magneticisque corporibus, et de magno magnete
Tellure (1600), che merita di essere considerato la prima opera importante nello studio
del magnetismo. È un’opera nella quale si ritrovano molti degli elementi che in seguito
sarebbero stati considerati tipici di Bacone, in special modo la sua rivendicazione dello
sperimentalismo e la critica degli errori degli antichi con il loro modo di ragionare
fondato su meri verbalismi, con un tono assai simile a quello adottato da Salviati nella
sua riposta a Simplicio. Accanto a quella di Thomas Digges, l’opera di Gilbert, benché
questi non dominasse gli aspetti matematici della problematica, fu fondamentale nella
diffusione del copernicanesimo in Inghilterra. Con grande disinvoltura e con una punta
di esagerazione, Gilbert diceva che soltanto gli idioti credevano nella teoria tolemaica e
dedicò il libro VI, intitolato De telluris globo, magno magnete, alla teoria copernicana.
Per lui la Terra era una grande calamita che, a causa del magnetismo, ruotava su un asse
magnetico fisso e orientato verso il polo dell’eclittica. Tuttavia, molti degli esemplari
dell’opera giunti in Italia al momento della discussione e condanna del copernicanesimo
mancano appunto del libro VI che fu censurato. È invece integro l’esemplare con
postille di proprietà di Galileo. Si veda Mario Loria, «William Gilbert e Galileo Galilei.
La terrella e le calamite del Granduca», in Maccagni, 1972, pp. 208-248, specialmente
p. 236.
103 La corrispondenza di Galileo con Sagredo e con Sarpi rivela che, già prima del
settembre del 1602 (come si deduce dalla lettera di Sarpi del 2 settembre 1602, Opere,
X, p. 91), Galileo, stimolato senza dubbio dalla lettura del De magnete, stava facendo
esperimenti con calamite.
104
A questo punto si è tentati di interpretare «materie diverse» con «vari materiali»,
tenendo però presente che nelle sue successive riapparizioni il termine è altrettanto poco
chiaro. Sia in latino sia in italiano, la dizione «materia» presenta entrambi i significati, e
sarebbe lecito pensare che Galileo se ne serva nell’uno e nell’altro senso. Se però
teniamo conto del fatto che ci si sta movendo in tradizioni, che postulano una «materia
prima», tanto quella aristotelica quanto quella atomistica, dalla quale derivano i quattro
elementi e le altre cose, il termine «materiale» come sostantivo presuppone una
distinzione o introduce una complessità ontologica, di cui non sono in grado di stabilire
in questa sede l’importanza, e non sono affatto sicuro che la si possa attribuire a Galileo.
Come se non bastasse, l’etimologia latina del termine induce a prudenza in merito.
Lascio quindi al lettore stabilire per conto suo se interpretare il termine come «materia»
o «materiale».
105 Galileo parla di «declinare», ma non si tratta di quella che oggi chiamiamo
«declinazione». In realtà, Galileo si serve della terminologia di Gilbert. Nel primo
capitolo del secondo libro del De magnete, Gilbert infatti definisce i diversi «movimenti
magnetici» ai quali dedica successivi libri della sua opera: il secondo libro alla coitio,
vale a dire l’attrazione e incitamento all’unione magnetica; il terzo alla directio, cioè la
634