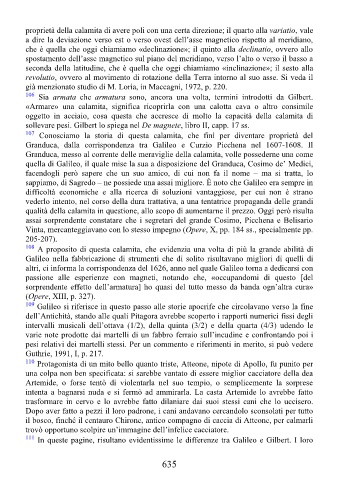Page 635 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 635
proprietà della calamita di avere poli con una certa direzione; il quarto alla variatio, vale
a dire la deviazione verso est o verso ovest dell’asse magnetico rispetto al meridiano,
che è quella che oggi chiamiamo «declinazione»; il quinto alla declinatio, ovvero allo
spostamento dell’asse magnetico sul piano del meridiano, verso l’alto o verso il basso a
seconda della latitudine, che è quella che oggi chiamiamo «inclinazione»; il sesto alla
revolutio, ovvero al movimento di rotazione della Terra intorno al suo asse. Si veda il
già menzionato studio di M. Loria, in Maccagni, 1972, p. 220.
106
Sia armata che armatura sono, ancora una volta, termini introdotti da Gilbert.
«Armare» una calamita, significa ricoprirla con una calotta cava o altro consimile
oggetto in acciaio, cosa questa che accresce di molto la capacità della calamita di
sollevare pesi. Gilbert lo spiega nel De magnete, libro II, capp. 17 ss.
107 Conosciamo la storia di questa calamita, che finì per diventare proprietà del
Granduca, dalla corrispondenza tra Galileo e Curzio Picchena nel 1607-1608. Il
Granduca, messo al corrente delle meraviglie della calamita, volle possederne una come
quella di Galileo, il quale mise la sua a disposizione del Granduca, Cosimo de’ Medici,
facendogli però sapere che un suo amico, di cui non fa il nome – ma si tratta, lo
sappiamo, di Sagredo – ne possiede una assai migliore. È noto che Galileo era sempre in
difficoltà economiche e alla ricerca di soluzioni vantaggiose, per cui non è strano
vederlo intento, nel corso della dura trattativa, a una tentatrice propaganda delle grandi
qualità della calamita in questione, allo scopo di aumentarne il prezzo. Oggi però risulta
assai sorprendente constatare che i segretari del grande Cosimo, Picchena e Belisario
Vinta, mercanteggiavano con lo stesso impegno (Opere, X, pp. 184 ss., specialmente pp.
205-207).
108
A proposito di questa calamita, che evidenzia una volta di più la grande abilità di
Galileo nella fabbricazione di strumenti che di solito risultavano migliori di quelli di
altri, ci informa la corrispondenza del 1626, anno nel quale Galileo torna a dedicarsi con
passione alle esperienze con magneti, notando che, «occupandomi di questo [del
sorprendente effetto dell’armatura] ho quasi del tutto messo da banda ogn’altra cura»
(Opere, XIII, p. 327).
109 Galileo si riferisce in questo passo alle storie apocrife che circolavano verso la fine
dell’Antichità, stando alle quali Pitagora avrebbe scoperto i rapporti numerici fissi degli
intervalli musicali dell’ottava (1/2), della quinta (3/2) e della quarta (4/3) udendo le
varie note prodotte dai martelli di un fabbro ferraio sull’incudine e confrontando poi i
pesi relativi dei martelli stessi. Per un commento e riferimenti in merito, si può vedere
Guthrie, 1991, I, p. 217.
110
Protagonista di un mito bello quanto triste, Atteone, nipote di Apollo, fu punito per
una colpa non ben specificata: si sarebbe vantato di essere miglior cacciatore della dea
Artemide, o forse tentò di violentarla nel suo tempio, o semplicemente la sorprese
intenta a bagnarsi nuda e si fermò ad ammirarla. La casta Artemide lo avrebbe fatto
trasformare in cervo e lo avrebbe fatto dilaniare dai suoi stessi cani che lo uccisero.
Dopo aver fatto a pezzi il loro padrone, i cani andavano cercandolo sconsolati per tutto
il bosco, finché il centauro Chirone, antico compagno di caccia di Atteone, per calmarli
trovò opportuno scolpire un’immagine dell’infelice cacciatore.
111 In queste pagine, risultano evidentissime le differenze tra Galileo e Gilbert. I loro
635