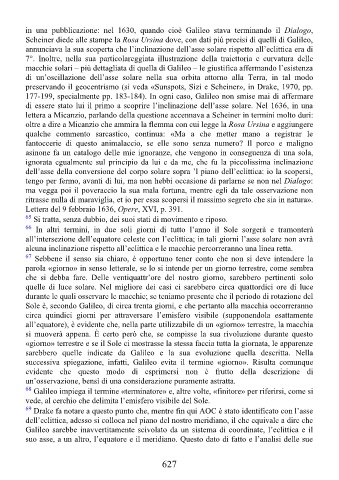Page 627 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 627
in una pubblicazione: nel 1630, quando cioè Galileo stava terminando il Dialogo,
Scheiner diede alle stampe la Rosa Ursina dove, con dati più precisi di quelli di Galileo,
annunciava la sua scoperta che l’inclinazione dell’asse solare rispetto all’eclittica era di
7°. Inoltre, nella sua particolareggiata illustrazione della traiettoria e curvatura delle
macchie solari – più dettagliata di quella di Galileo – le giustifica affermando l’esistenza
di un’oscillazione dell’asse solare nella sua orbita attorno alla Terra, in tal modo
preservando il geocentrismo (si veda «Sunspots, Sizi e Scheiner», in Drake, 1970, pp.
177-199, specialmente pp. 183-184). In ogni caso, Galileo non smise mai di affermare
di essere stato lui il primo a scoprire l’inclinazione dell’asse solare. Nel 1636, in una
lettera a Micanzio, parlando della questione accennava a Scheiner in termini molto duri:
oltre a dire a Micanzio che ammira la flemma con cui legge la Rosa Ursina e aggiungere
qualche commento sarcastico, continua: «Ma a che metter mano a registrar le
fantoccerie di questo animalaccio, se elle sono senza numero? Il porco e maligno
asinone fa un catalogo delle mie ignoranze, che vengono in conseguenza di una sola,
ignorata egualmente sul principio da lui e da me, che fu la piccolissima inclinazione
dell’asse della conversione del corpo solare sopra ’l piano dell’eclittica: io la scopersi,
tengo per fermo, avanti di lui, ma non hebbi occasione di parlarne se non nel Dialogo:
ma vegga poi il poveraccio la sua mala fortuna, mentre egli da tale osservazione non
ritrasse nulla di maraviglia, et io per essa scopersi il massimo segreto che sia in natura».
Lettera del 9 febbraio 1636, Opere, XVI, p. 391.
65 Si tratta, senza dubbio, dei suoi stati di movimento e riposo.
66 In altri termini, in due soli giorni di tutto l’anno il Sole sorgerà e tramonterà
all’intersezione dell’equatore celeste con l’eclittica; in tali giorni l’asse solare non avrà
alcuna inclinazione rispetto all’eclittica e le macchie percorreranno una linea retta.
67 Sebbene il senso sia chiaro, è opportuno tener conto che non si deve intendere la
parola «giorno» in senso letterale, se lo si intende per un giorno terrestre, come sembra
che si debba fare. Delle ventiquattr’ore del nostro giorno, sarebbero pertinenti solo
quelle di luce solare. Nel migliore dei casi ci sarebbero circa quattordici ore di luce
durante le quali osservare le macchie; se teniamo presente che il periodo di rotazione del
Sole è, secondo Galileo, di circa trenta giorni, e che pertanto alla macchia occorreranno
circa quindici giorni per attraversare l’emisfero visibile (supponendola esattamente
all’equatore), è evidente che, nella parte utilizzabile di un «giorno» terrestre, la macchia
si muoverà appena. È certo però che, se compisse la sua rivoluzione durante questo
«giorno» terrestre e se il Sole ci mostrasse la stessa faccia tutta la giornata, le apparenze
sarebbero quelle indicate da Galileo e la sua evoluzione quella descritta. Nella
successiva spiegazione, infatti, Galileo evita il termine «giorno». Risulta comunque
evidente che questo modo di esprimersi non è frutto della descrizione di
un’osservazione, bensì di una considerazione puramente astratta.
68
Galileo impiega il termine «terminatore» e, altre volte, «finitore» per riferirsi, come si
vede, al cerchio che delimita l’emisfero visibile del Sole.
69 Drake fa notare a questo punto che, mentre fin qui AOC è stato identificato con l’asse
dell’eclittica, adesso si colloca nel piano del nostro meridiano, il che equivale a dire che
Galileo sarebbe inavvertitamente scivolato da un sistema di coordinate, l’eclittica e il
suo asse, a un altro, l’equatore e il meridiano. Questo dato di fatto e l’analisi delle sue
627