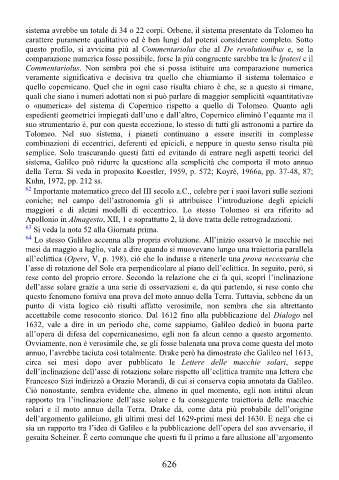Page 626 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 626
sistema avrebbe un totale di 34 o 22 corpi. Orbene, il sistema presentato da Tolomeo ha
carattere puramente qualitativo ed è ben lungi dal potersi considerare completo. Sotto
questo profilo, si avvicina più al Commentariolus che al De revolutionibus e, se la
comparazione numerica fosse possibile, forse la più congruente sarebbe tra le Ipotesi e il
Commentariolus. Non sembra poi che si possa istituire una comparazione numerica
veramente significativa e decisiva tra quello che chiamiamo il sistema tolemaico e
quello copernicano. Quel che in ogni caso risulta chiaro è che, se a questo si rimane,
quali che siano i numeri adottati non si può parlare di maggior semplicità «quantitativa»
o «numerica» del sistema di Copernico rispetto a quello di Tolomeo. Quanto agli
espedienti geometrici impiegati dall’uno e dall’altro, Copernico eliminò l’equante ma il
suo strumentario è, pur con questa eccezione, lo stesso di tutti gli astronomi a partire da
Tolomeo. Nel suo sistema, i pianeti continuano a essere inseriti in complesse
combinazioni di eccentrici, deferenti ed epicicli, e neppure in questo senso risulta più
semplice. Solo trascurando questi fatti ed evitando di entrare negli aspetti teorici del
sistema, Galileo può ridurre la questione alla semplicità che comporta il moto annuo
della Terra. Si veda in proposito Koestler, 1959, p. 572; Koyré, 1966a, pp. 37-48, 87;
Kuhn, 1972, pp. 212 ss.
62
Importante matematico greco del III secolo a.C., celebre per i suoi lavori sulle sezioni
coniche; nel campo dell’astronomia gli si attribuisce l’introduzione degli epicicli
maggiori e di alcuni modelli di eccentrico. Lo stesso Tolomeo si era riferito ad
Apollonio in Almagesto, XII, 1 e soprattutto 2, là dove tratta delle retrogradazioni.
63 Si veda la nota 52 alla Giornata prima.
64 Lo stesso Galileo accenna alla propria evoluzione. All’inizio osservò le macchie nei
mesi da maggio a luglio, vale a dire quando si muovevano lungo una traiettoria parallela
all’eclittica (Opere, V, p. 198), ciò che lo indusse a ritenerle una prova necessaria che
l’asse di rotazione del Sole era perpendicolare al piano dell’eclittica. In seguito, però, si
rese conto del proprio errore. Secondo la relazione che ci fa qui, scoprì l’inclinazione
dell’asse solare grazie a una serie di osservazioni e, da qui partendo, si rese conto che
questo fenomeno forniva una prova del moto annuo della Terra. Tuttavia, sebbene da un
punto di vista logico ciò risulti affatto verosimile, non sembra che sia altrettanto
accettabile come resoconto storico. Dal 1612 fino alla pubblicazione del Dialogo nel
1632, vale a dire in un periodo che, come sappiamo, Galileo dedicò in buona parte
all’opera di difesa del copernicanesimo, egli non fa alcun cenno a questo argomento.
Ovviamente, non è verosimile che, se gli fosse balenata una prova come questa del moto
annuo, l’avrebbe taciuta così totalmente. Drake però ha dimostrato che Galileo nel 1613,
circa sei mesi dopo aver pubblicato le Lettere delle macchie solari, seppe
dell’inclinazione dell’asse di rotazione solare rispetto all’eclittica tramite una lettera che
Francesco Sizi indirizzò a Orazio Morandi, di cui si conserva copia annotata da Galileo.
Ciò nonostante, sembra evidente che, almeno in quel momento, egli non istituì alcun
rapporto tra l’inclinazione dell’asse solare e la conseguente traiettoria delle macchie
solari e il moto annuo della Terra. Drake dà, come data più probabile dell’origine
dell’argomento galileiano, gli ultimi mesi del 1629-primi mesi del 1630. E nega che ci
sia un rapporto tra l’idea di Galileo e la pubblicazione dell’opera del suo avversario, il
gesuita Scheiner. È certo comunque che questi fu il primo a fare allusione all’argomento
626