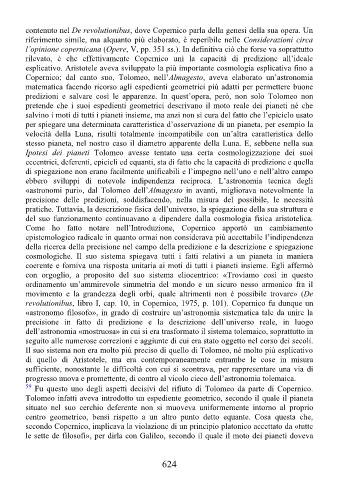Page 624 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 624
contenuto nel De revolutionibus, dove Copernico parla della genesi della sua opera. Un
riferimento simile, ma alquanto più elaborato, è reperibile nelle Considerazioni circa
l’opinione copernicana (Opere, V, pp. 351 ss.). In definitiva ciò che forse va soprattutto
rilevato, è che effettivamente Copernico unì la capacità di predizione all’ideale
esplicativo. Aristotele aveva sviluppato la più importante cosmologia esplicativa fino a
Copernico; dal canto suo, Tolomeo, nell’Almagesto, aveva elaborato un’astronomia
matematica facendo ricorso agli espedienti geometrici più adatti per permettere buone
predizioni e salvare così le apparenze. In quest’opera, però, non solo Tolomeo non
pretende che i suoi espedienti geometrici descrivano il moto reale dei pianeti né che
salvino i moti di tutti i pianeti insieme, ma anzi non si cura del fatto che l’epiciclo usato
per spiegare una determinata caratteristica d’osservazione di un pianeta, per esempio la
velocità della Luna, risulti totalmente incompatibile con un’altra caratteristica dello
stesso pianeta, nel nostro caso il diametro apparente della Luna. E, sebbene nella sua
Ipotesi dei pianeti Tolomeo avesse tentato una certa cosmologizzazione dei suoi
eccentrici, deferenti, epicicli ed equanti, sta di fatto che la capacità di predizione e quella
di spiegazione non erano facilmente unificabili e l’impegno nell’uno e nell’altro campo
ebbero sviluppi di notevole indipendenza reciproca. L’astronomia tecnica degli
«astronomi puri», dal Tolomeo dell’Almagesto in avanti, migliorava notevolmente la
precisione delle predizioni, soddisfacendo, nella misura del possibile, le necessità
pratiche. Tuttavia, la descrizione fisica dell’universo, la spiegazione della sua struttura e
del suo funzionamento continuavano a dipendere dalla cosmologia fisica aristotelica.
Come ho fatto notare nell’Introduzione, Copernico apportò un cambiamento
epistemologico radicale in quanto ormai non considerava più accettabile l’indipendenza
della ricerca della precisione nel campo della predizione e la descrizione e spiegazione
cosmologiche. Il suo sistema spiegava tutti i fatti relativi a un pianeta in maniera
coerente e forniva una risposta unitaria ai moti di tutti i pianeti insieme. Egli affermò
con orgoglio, a proposito del suo sistema eliocentrico: «Troviamo così in questo
ordinamento un’ammirevole simmetria del mondo e un sicuro nesso armonico fra il
movimento e la grandezza degli orbi, quale altrimenti non è possibile trovare» (De
revolutionibus, libro I, cap. 10, in Copernico, 1975, p. 101). Copernico fu dunque un
«astronomo filosofo», in grado di costruire un’astronomia sistematica tale da unire la
precisione in fatto di predizione e la descrizione dell’universo reale, in luogo
dell’astronomia «mostruosa» in cui si era trasformato il sistema tolemaico, soprattutto in
seguito alle numerose correzioni e aggiunte di cui era stato oggetto nel corso dei secoli.
Il suo sistema non era molto più preciso di quello di Tolomeo, né molto più esplicativo
di quello di Aristotele, ma era contemporaneamente entrambe le cose in misura
sufficiente, nonostante le difficoltà con cui si scontrava, per rappresentare una via di
progresso nuova e promettente, di contro al vicolo cieco dell’astronomia tolemaica.
59 Fu questo uno degli aspetti decisivi del rifiuto di Tolomeo da parte di Copernico.
Tolomeo infatti aveva introdotto un espediente geometrico, secondo il quale il pianeta
situato nel suo cerchio deferente non si muoveva uniformemente intorno al proprio
centro geometrico, bensì rispetto a un altro punto detto equante. Cosa questa che,
secondo Copernico, implicava la violazione di un principio platonico accettato da «tutte
le sette de filosofi», per dirla con Galileo, secondo il quale il moto dei pianeti doveva
624