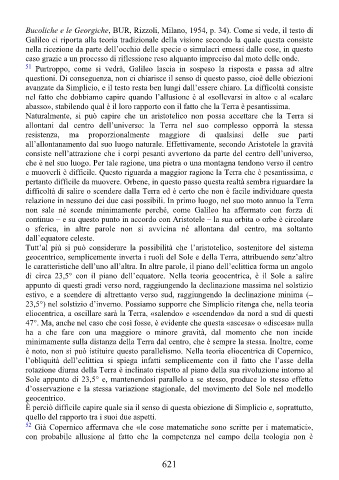Page 621 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 621
Bucoliche e le Georgiche, BUR, Rizzoli, Milano, 1954, p. 34). Come si vede, il testo di
Galileo ci riporta alla teoria tradizionale della visione secondo la quale questa consiste
nella ricezione da parte dell’occhio delle specie o simulacri emessi dalle cose, in questo
caso grazie a un processo di riflessione reso alquanto impreciso dal moto delle onde.
51 Purtroppo, come si vedrà, Galileo lascia in sospeso la risposta e passa ad altre
questioni. Di conseguenza, non ci chiarisce il senso di questo passo, cioè delle obiezioni
avanzate da Simplicio, e il testo resta ben lungi dall’essere chiaro. La difficoltà consiste
nel fatto che dobbiamo capire quando l’allusione è al «sollevarsi in alto» e al «calare
abasso», stabilendo qual è il loro rapporto con il fatto che la Terra è pesantissima.
Naturalmente, si può capire che un aristotelico non possa accettare che la Terra si
allontani dal centro dell’universo: la Terra nel suo complesso opporrà la stessa
resistenza, ma proporzionalmente maggiore di qualsiasi delle sue parti
all’allontanamento dal suo luogo naturale. Effettivamente, secondo Aristotele la gravità
consiste nell’attrazione che i corpi pesanti avvertono da parte del centro dell’universo,
che è nel suo luogo. Per tale ragione, una pietra o una montagna tendono verso il centro
e muoverli è difficile. Questo riguarda a maggior ragione la Terra che è pesantissima, e
pertanto difficile da muovere. Orbene, in questo passo questa realtà sembra riguardare la
difficoltà di salire o scendere dalla Terra ed è certo che non è facile individuare questa
relazione in nessuno dei due casi possibili. In primo luogo, nel suo moto annuo la Terra
non sale né scende minimamente perché, come Galileo ha affermato con forza di
continuo – e su questo punto in accordo con Aristotele – la sua orbita o orbe è circolare
o sferica, in altre parole non si avvicina né allontana dal centro, ma soltanto
dall’equatore celeste.
Tutt’al più si può considerare la possibilità che l’aristotelico, sostenitore del sistema
geocentrico, semplicemente inverta i ruoli del Sole e della Terra, attribuendo senz’altro
le caratteristiche dell’uno all’altra. In altre parole, il piano dell’eclittica forma un angolo
di circa 23,5° con il piano dell’equatore. Nella teoria geocentrica, è il Sole a salire
appunto di questi gradi verso nord, raggiungendo la declinazione massima nel solstizio
estivo, e a scendere di altrettanto verso sud, raggiungendo la declinazione minima (–
23,5°) nel solstizio d’inverno. Possiamo supporre che Simplicio ritenga che, nella teoria
eliocentrica, a oscillare sarà la Terra, «salendo» e «scendendo» da nord a sud di questi
47°. Ma, anche nel caso che così fosse, è evidente che questa «ascesa» o «discesa» nulla
ha a che fare con una maggiore o minore gravità, dal momento che non incide
minimamente sulla distanza della Terra dal centro, che è sempre la stessa. Inoltre, come
è noto, non si può istituire questo parallelismo. Nella teoria eliocentrica di Copernico,
l’obliquità dell’eclittica si spiega infatti semplicemente con il fatto che l’asse della
rotazione diurna della Terra è inclinato rispetto al piano della sua rivoluzione intorno al
Sole appunto di 23,5° e, mantenendosi parallelo a se stesso, produce lo stesso effetto
d’osservazione e la stessa variazione stagionale, del movimento del Sole nel modello
geocentrico.
È perciò difficile capire quale sia il senso di questa obiezione di Simplicio e, soprattutto,
quello del rapporto tra i suoi due aspetti.
52
Già Copernico affermava che «le cose matematiche sono scritte per i matematici»,
con probabile allusione al fatto che la competenza nel campo della teologia non è
621