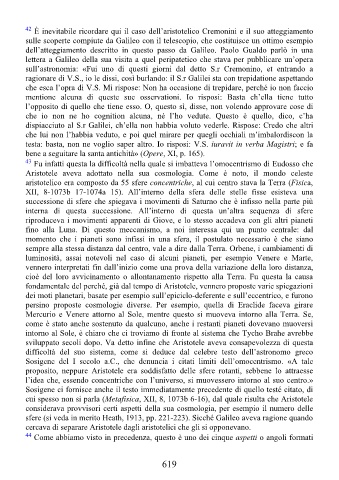Page 619 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 619
42 È inevitabile ricordare qui il caso dell’aristotelico Cremonini e il suo atteggiamento
sulle scoperte compiute da Galileo con il telescopio, che costituisce un ottimo esempio
dell’atteggiamento descritto in questo passo da Galileo. Paolo Gualdo parlò in una
lettera a Galileo della sua visita a quel peripatetico che stava per pubblicare un’opera
sull’astronomia: «Fui uno di questi giorni dal detto S.r Cremonino, et entrando a
ragionare di V.S., io le dissi, così burlando: il S.r Galilei sta con trepidatione aspettando
che esca l’opra di V.S. Mi rispose: Non ha occasione di trepidare, perché io non faccio
mentione alcuna di queste sue osservationi. Io risposi: Basta ch’ella tiene tutto
l’opposito di quello che tiene esso. O, questo sì, disse, non volendo approvare cose di
che io non ne ho cognition alcuna, né l’ho vedute. Questo è quello, dico, c’ha
dispiacciuto al S.r Galilei, ch’ella non habbia voluto vederle. Rispose: Credo che altri
che lui non l’habbia veduto, e poi quel mirare per quegli occhiali m’imbalordiscon la
testa: basta, non ne voglio saper altro. Io risposi: V.S. iuravit in verba Magistri; e fa
bene a seguitare la santa antichità» (Opere, XI, p. 165).
43
Fu infatti questa la difficoltà nella quale si imbatteva l’omocentrismo di Eudosso che
Aristotele aveva adottato nella sua cosmologia. Come è noto, il mondo celeste
aristotelico era composto da 55 sfere concentriche, al cui centro stava la Terra (Fisica,
XII, 8-1073b 17-1074a 15). All’interno della sfera delle stelle fisse esisteva una
successione di sfere che spiegava i movimenti di Saturno che è infisso nella parte più
interna di questa successione. All’interno di questa un’altra sequenza di sfere
riproduceva i movimenti apparenti di Giove, e lo stesso accadeva con gli altri pianeti
fino alla Luna. Di questo meccanismo, a noi interessa qui un punto centrale: dal
momento che i pianeti sono infissi in una sfera, il postulato necessario è che siano
sempre alla stessa distanza dal centro, vale a dire dalla Terra. Orbene, i cambiamenti di
luminosità, assai notevoli nel caso di alcuni pianeti, per esempio Venere e Marte,
vennero interpretati fin dall’inizio come una prova della variazione della loro distanza,
cioè del loro avvicinamento o allontanamento rispetto alla Terra. Fu questa la causa
fondamentale del perché, già dal tempo di Aristotele, vennero proposte varie spiegazioni
dei moti planetari, basate per esempio sull’epiciclo-deferente e sull’eccentrico, e furono
persino proposte cosmologie diverse. Per esempio, quella di Eraclide faceva girare
Mercurio e Venere attorno al Sole, mentre questo si muoveva intorno alla Terra. Se,
come è stato anche sostenuto da qualcuno, anche i restanti pianeti dovevano muoversi
intorno al Sole, è chiaro che ci troviamo di fronte al sistema che Tycho Brahe avrebbe
sviluppato secoli dopo. Va detto infine che Aristotele aveva consapevolezza di questa
difficoltà del suo sistema, come si deduce dal celebre testo dell’astronomo greco
Sosigene del I secolo a.C., che denuncia i citati limiti dell’omocentrismo. «A tale
proposito, neppure Aristotele era soddisfatto delle sfere rotanti, sebbene lo attraesse
l’idea che, essendo concentriche con l’universo, si muovessero intorno al suo centro.»
Sosigene ci fornisce anche il testo immediatamente precedente di quello testé citato, di
cui spesso non si parla (Metafisica, XII, 8, 1073b 6-16), dal quale risulta che Aristotele
considerava provvisori certi aspetti della sua cosmologia, per esempio il numero delle
sfere (si veda in merito Heath, 1913, pp. 221-223). Sicché Galileo aveva ragione quando
cercava di separare Aristotele dagli aristotelici che gli si opponevano.
44
Come abbiamo visto in precedenza, questo è uno dei cinque aspetti o angoli formati
619