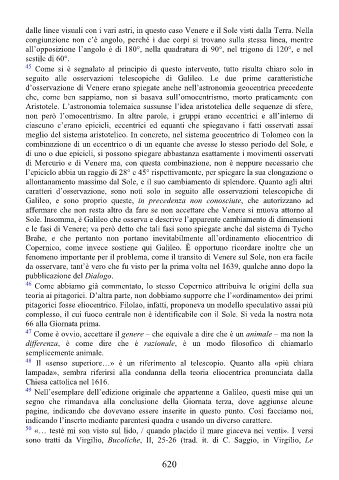Page 620 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 620
dalle linee visuali con i vari astri, in questo caso Venere e il Sole visti dalla Terra. Nella
congiunzione non c’è angolo, perché i due corpi si trovano sulla stessa linea, mentre
all’opposizione l’angolo è di 180°, nella quadratura di 90°, nel trigono di 120°, e nel
sestile di 60°.
45 Come si è segnalato al principio di questo intervento, tutto risulta chiaro solo in
seguito alle osservazioni telescopiche di Galileo. Le due prime caratteristiche
d’osservazione di Venere erano spiegate anche nell’astronomia geocentrica precedente
che, come ben sappiamo, non si basava sull’omocentrismo, morto praticamente con
Aristotele. L’astronomia tolemaica sussunse l’idea aristotelica delle sequenze di sfere,
non però l’omocentrismo. In altre parole, i gruppi erano eccentrici e all’interno di
ciascuno c’erano epicicli, eccentrici ed equanti che spiegavano i fatti osservati assai
meglio del sistema aristotelico. In concreto, nel sistema geocentrico di Tolomeo con la
combinazione di un eccentrico o di un equante che avesse lo stesso periodo del Sole, e
di uno o due epicicli, si possono spiegare abbastanza esattamente i movimenti osservati
di Mercurio e di Venere ma, con questa combinazione, non è neppure necessario che
l’epiciclo abbia un raggio di 28° e 45° rispettivamente, per spiegare la sua elongazione o
allontanamento massimo dal Sole, e il suo cambiamento di splendore. Quanto agli altri
caratteri d’osservazione, sono noti solo in seguito alle osservazioni telescopiche di
Galileo, e sono proprio queste, in precedenza non conosciute, che autorizzano ad
affermare che non resta altro da fare se non accettare che Venere si muova attorno al
Sole. Insomma, è Galileo che osserva e descrive l’apparente cambiamento di dimensioni
e le fasi di Venere; va però detto che tali fasi sono spiegate anche dal sistema di Tycho
Brahe, e che pertanto non portano inevitabilmente all’ordinamento eliocentrico di
Copernico, come invece sostiene qui Galileo. È opportuno ricordare inoltre che un
fenomeno importante per il problema, come il transito di Venere sul Sole, non era facile
da osservare, tant’è vero che fu visto per la prima volta nel 1639, qualche anno dopo la
pubblicazione del Dialogo.
46 Come abbiamo già commentato, lo stesso Copernico attribuiva le origini della sua
teoria ai pitagorici. D’altra parte, non dobbiamo supporre che l’«ordinamento» dei primi
pitagorici fosse eliocentrico. Filolao, infatti, proponeva un modello speculativo assai più
complesso, il cui fuoco centrale non è identificabile con il Sole. Si veda la nostra nota
66 alla Giornata prima.
47 Come è ovvio, accettare il genere – che equivale a dire che è un animale – ma non la
differenza, è come dire che è razionale, è un modo filosofico di chiamarlo
semplicemente animale.
48 Il «senso superiore…» è un riferimento al telescopio. Quanto alla «più chiara
lampada», sembra riferirsi alla condanna della teoria eliocentrica pronunciata dalla
Chiesa cattolica nel 1616.
49 Nell’esemplare dell’edizione originale che appartenne a Galileo, questi mise qui un
segno che rimandava alla conclusione della Giornata terza, dove aggiunse alcune
pagine, indicando che dovevano essere inserite in questo punto. Così facciamo noi,
indicando l’inserto mediante parentesi quadra e usando un diverso carattere.
50
«… testé mi son visto sul lido, / quando placido il mare giaceva nei venti». I versi
sono tratti da Virgilio, Bucoliche, II, 25-26 (trad. it. di C. Saggio, in Virgilio, Le
620