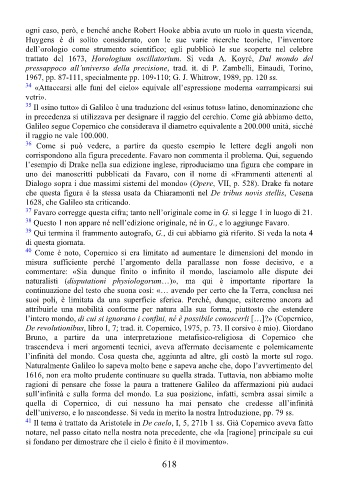Page 618 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 618
ogni caso, però, e benché anche Robert Hooke abbia avuto un ruolo in questa vicenda,
Huygens è di solito considerato, con le sue varie ricerche teoriche, l’inventore
dell’orologio come strumento scientifico; egli pubblicò le sue scoperte nel celebre
trattato del 1673, Horologium oscillatorium. Si veda A. Koyré, Dal mondo del
pressappoco all’universo della precisione, trad. it. di P. Zambelli, Einaudi, Torino,
1967, pp. 87-111, specialmente pp. 109-110; G. J. Whitrow, 1989, pp. 120 ss.
34 «Attaccarsi alle funi del cielo» equivale all’espressione moderna «arrampicarsi sui
vetri».
35
Il «sino tutto» di Galileo è una traduzione del «sinus totus» latino, denominazione che
in precedenza si utilizzava per designare il raggio del cerchio. Come già abbiamo detto,
Galileo segue Copernico che considerava il diametro equivalente a 200.000 unità, sicché
il raggio ne vale 100.000.
36 Come si può vedere, a partire da questo esempio le lettere degli angoli non
corrispondono alla figura precedente. Favaro non commenta il problema. Qui, seguendo
l’esempio di Drake nella sua edizione inglese, riproduciamo una figura che compare in
uno dei manoscritti pubblicati da Favaro, con il nome di «Frammenti attenenti al
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo» (Opere, VII, p. 528). Drake fa notare
che questa figura è la stessa usata da Chiaramonti nel De tribus novis stellis, Cesena
1628, che Galileo sta criticando.
37 Favaro corregge questa cifra; tanto nell’originale come in G. si legge 1 in luogo di 21.
38 Questo 1 non appare né nell’edizione originale, né in G., e lo aggiunge Favaro.
39 Qui termina il frammento autografo, G., di cui abbiamo già riferito. Si veda la nota 4
di questa giornata.
40
Come è noto, Copernico si era limitato ad aumentare le dimensioni del mondo in
misura sufficiente perché l’argomento della parallasse non fosse decisivo, e a
commentare: «Sia dunque finito o infinito il mondo, lasciamolo alle dispute dei
naturalisti (disputationi physiologorum…)», ma qui è importante riportare la
continuazione del testo che suona così: «… avendo per certo che la Terra, conclusa nei
suoi poli, è limitata da una superficie sferica. Perché, dunque, esiteremo ancora ad
attribuirle una mobilità conforme per natura alla sua forma, piuttosto che estendere
l’intero mondo, di cui si ignorano i confini, né è possibile conoscerli […]?» (Copernico,
De revolutionibus, libro I, 7; trad. it. Copernico, 1975, p. 73. Il corsivo è mio). Giordano
Bruno, a partire da una interpretazione metafisico-religiosa di Copernico che
trascendeva i meri argomenti tecnici, aveva affermato decisamente e polemicamente
l’infinità del mondo. Cosa questa che, aggiunta ad altre, gli costò la morte sul rogo.
Naturalmente Galileo lo sapeva molto bene e sapeva anche che, dopo l’avvertimento del
1616, non era molto prudente continuare su quella strada. Tuttavia, non abbiamo molte
ragioni di pensare che fosse la paura a trattenere Galileo da affermazioni più audaci
sull’infinità e sulla forma del mondo. La sua posizione, infatti, sembra assai simile a
quella di Copernico, di cui nessuno ha mai pensato che credesse all’infinità
dell’universo, e lo nascondesse. Si veda in merito la nostra Introduzione, pp. 79 ss.
41 Il tema è trattato da Aristotele in De caelo, I, 5, 271b 1 ss. Già Copernico aveva fatto
notare, nel passo citato nella nostra nota precedente, che «la [ragione] principale su cui
si fondano per dimostrare che il cielo è finito è il movimento».
618