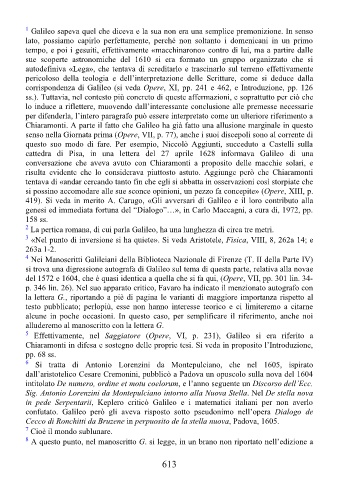Page 613 - Galileo Galilei - Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
P. 613
1 Galileo sapeva quel che diceva e la sua non era una semplice premonizione. In senso
lato, possiamo capirlo perfettamente, perché non soltanto i domenicani in un primo
tempo, e poi i gesuiti, effettivamente «macchinarono» contro di lui, ma a partire dalle
sue scoperte astronomiche del 1610 si era formato un gruppo organizzato che si
autodefiniva «Lega», che tentava di screditarlo e trascinarlo sul terreno effettivamente
pericoloso della teologia e dell’interpretazione delle Scritture, come si deduce dalla
corrispondenza di Galileo (si veda Opere, XI, pp. 241 e 462, e Introduzione, pp. 126
ss.). Tuttavia, nel contesto più concreto di queste affermazioni, e soprattutto per ciò che
lo induce a riflettere, muovendo dall’interessante conclusione alle premesse necessarie
per difenderla, l’intero paragrafo può essere interpretato come un ulteriore riferimento a
Chiaramonti. A parte il fatto che Galileo ha già fatto una allusione marginale in questo
senso nella Giornata prima (Opere, VII, p. 77), anche i suoi discepoli sono al corrente di
questo suo modo di fare. Per esempio, Niccolò Aggiunti, succeduto a Castelli sulla
cattedra di Pisa, in una lettera del 27 aprile 1628 informava Galileo di una
conversazione che aveva avuto con Chiaramonti a proposito delle macchie solari, e
risulta evidente che lo considerava piuttosto astuto. Aggiunge però che Chiaramonti
tentava di «andar cercando tanto fin che egli si abbatta in osservazioni così storpiate che
si possino accomodare alle sue sconce opinioni, un pezzo fa concepite» (Opere, XIII, p.
419). Si veda in merito A. Carugo, «Gli avversari di Galileo e il loro contributo alla
genesi ed immediata fortuna del “Dialogo”…», in Carlo Maccagni, a cura di, 1972, pp.
158 ss.
2 La pertica romana, di cui parla Galileo, ha una lunghezza di circa tre metri.
3 «Nel punto di inversione si ha quiete». Si veda Aristotele, Fisica, VIII, 8, 262a 14; e
263a 1-2.
4
Nei Manoscritti Galileiani della Biblioteca Nazionale di Firenze (T. II della Parte IV)
si trova una digressione autografa di Galileo sul tema di questa parte, relativa alla novae
del 1572 e 1604, che è quasi identica a quella che si fa qui, (Opere, VII, pp. 301 lin. 34-
p. 346 lin. 26). Nel suo apparato critico, Favaro ha indicato il menzionato autografo con
la lettera G., riportando a piè di pagina le varianti di maggiore importanza rispetto al
testo pubblicato; perlopiù, esse non hanno interesse teorico e ci limiteremo a citarne
alcune in poche occasioni. In questo caso, per semplificare il riferimento, anche noi
alluderemo al manoscritto con la lettera G.
5 Effettivamente, nel Saggiatore (Opere, VI, p. 231), Galileo si era riferito a
Chiaramonti in difesa e sostegno delle proprie tesi. Si veda in proposito l’Introduzione,
pp. 68 ss.
6 Si tratta di Antonio Lorenzini da Montepulciano, che nel 1605, ispirato
dall’aristotelico Cesare Cremonini, pubblicò a Padova un opuscolo sulla nova del 1604
intitolato De numero, ordine et motu coelorum, e l’anno seguente un Discorso dell’Ecc.
Sig. Antonio Lorenzini da Montepulciano intorno alla Nuova Stella. Nel De stella nova
in pede Serpentarii, Keplero criticò Galileo e i matematici italiani per non averlo
confutato. Galileo però gli aveva risposto sotto pseudonimo nell’opera Dialogo de
Cecco di Ronchitti da Bruzene in perpuosito de la stella nuova, Padova, 1605.
7 Cioè il mondo sublunare.
8 A questo punto, nel manoscritto G. si legge, in un brano non riportato nell’edizione a
613