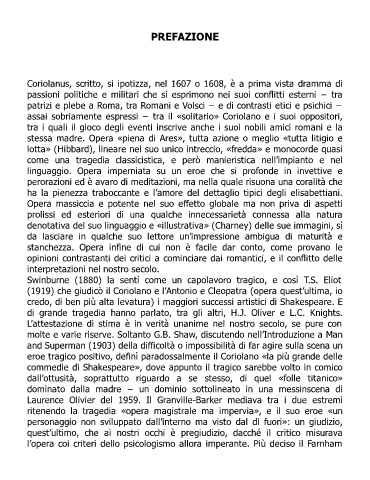Page 2579 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2579
PREFAZIONE
Coriolanus, scritto, si ipotizza, nel 1607 o 1608, è a prima vista dramma di
passioni politiche e militari che si esprimono nei suoi conflitti esterni − tra
patrizi e plebe a Roma, tra Romani e Volsci − e di contrasti etici e psichici −
assai sobriamente espressi − tra il «solitario» Coriolano e i suoi oppositori,
tra i quali il gioco degli eventi inscrive anche i suoi nobili amici romani e la
stessa madre. Opera «piena di Ares», tutta azione o meglio «tutta litigio e
lotta» (Hibbard), lineare nel suo unico intreccio, «fredda» e monocorde quasi
come una tragedia classicistica, e però manieristica nell’impianto e nel
linguaggio. Opera imperniata su un eroe che si profonde in invettive e
perorazioni ed è avaro di meditazioni, ma nella quale risuona una coralità che
ha la pienezza traboccante e l’amore del dettaglio tipici degli elisabettiani.
Opera massiccia e potente nel suo effetto globale ma non priva di aspetti
prolissi ed esteriori di una qualche innecessarietà connessa alla natura
denotativa del suo linguaggio e «illustrativa» (Charney) delle sue immagini, sì
da lasciare in qualche suo lettore un’impressione ambigua di maturità e
stanchezza. Opera infine di cui non è facile dar conto, come provano le
opinioni contrastanti dei critici a cominciare dai romantici, e il conflitto delle
interpretazioni nel nostro secolo.
Swinburne (1880) la sentì come un capolavoro tragico, e così T.S. Eliot
(1919) che giudicò il Coriolano e l’Antonio e Cleopatra (opera quest’ultima, io
credo, di ben più alta levatura) i maggiori successi artistici di Shakespeare. E
di grande tragedia hanno parlato, tra gli altri, H.J. Oliver e L.C. Knights.
L’attestazione di stima è in verità unanime nel nostro secolo, se pure con
molte e varie riserve. Soltanto G.B. Shaw, discutendo nell’Introduzione a Man
and Superman (1903) della difficoltà o impossibilità di far agire sulla scena un
eroe tragico positivo, definì paradossalmente il Coriolano «la più grande delle
commedie di Shakespeare», dove appunto il tragico sarebbe volto in comico
dall’ottusità, soprattutto riguardo a se stesso, di quel «folle titanico»
dominato dalla madre − un dominio sottolineato in una messinscena di
Laurence Olivier del 1959. Il Granville-Barker mediava tra i due estremi
ritenendo la tragedia «opera magistrale ma impervia», e il suo eroe «un
personaggio non sviluppato dall’interno ma visto dal di fuori»: un giudizio,
quest’ultimo, che ai nostri occhi è pregiudizio, dacché il critico misurava
l’opera coi criteri dello psicologismo allora imperante. Più deciso il Farnham