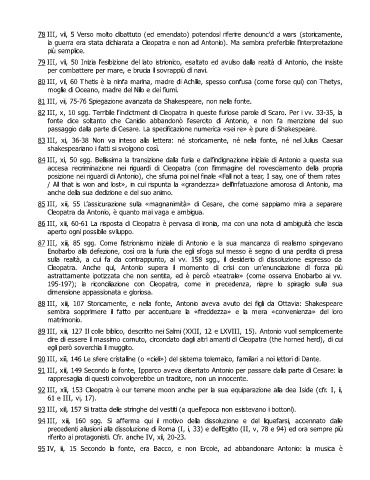Page 2574 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2574
78 III, vii, 5 Verso molto dibattuto (ed emendato) potendosi riferire denounc’d a wars (storicamente,
la guerra era stata dichiarata a Cleopatra e non ad Antonio). Ma sembra preferibile l’interpretazione
più semplice.
79 III, vii, 50 Inizia l’esibizione del lato istrionico, esaltato ed avulso dalla realtà di Antonio, che insiste
per combattere per mare, e brucia il sovrappiù di navi.
80 III, vii, 60 Thetis è la ninfa marina, madre di Achille, spesso confusa (come forse qui) con Thetys,
moglie di Oceano, madre del Nilo e dei fiumi.
81 III, vii, 75-76 Spiegazione avanzata da Shakespeare, non nella fonte.
82 III, x, 10 sgg. Terribile l’indictment di Cleopatra in queste furiose parole di Scaro. Per i vv. 33-35, la
fonte dice soltanto che Canidio abbandonò l’esercito di Antonio, e non fa menzione del suo
passaggio dalla parte di Cesare. La specificazione numerica «sei re» è pure di Shakespeare.
83 III, xi, 36-38 Non va inteso alla lettera: né storicamente, né nella fonte, né nel Julius Caesar
shakespeariano i fatti si svolgono così.
84 III, xi, 50 sgg. Bellissima la transizione dalla furia e dall’indignazione iniziale di Antonio a questa sua
accesa recriminazione nei riguardi di Cleopatra (con l’immagine del rovesciamento della propria
posizione nei riguardi di Antonio), che sfuma poi nel finale «Fall not a tear, I say, one of them rates
/ All that is won and lost», in cui rispunta la «grandezza» dell’infatuazione amorosa di Antonio, ma
anche della sua dedizione e del suo animo.
85 III, xiii, 55 L’assicurazione sulla «magnanimità» di Cesare, che come sappiamo mira a separare
Cleopatra da Antonio, è quanto mai vaga e ambigua.
86 III, xiii, 60-61 La risposta di Cleopatra è pervasa di ironia, ma con una nota di ambiguità che lascia
aperto ogni possibile sviluppo.
87 III, xiii, 85 sgg. Come l’istrionismo iniziale di Antonio e la sua mancanza di realismo spingevano
Enobarbo alla defezione, così ora la furia che egli sfoga sul messo è segno di una perdita di presa
sulla realtà, a cui fa da contrappunto, ai vv. 158 sgg., il desiderio di dissoluzione espresso da
Cleopatra. Anche qui, Antonio supera il momento di crisi con un’enunciazione di forza più
astrattamente ipotizzata che non sentita, ed è perciò «teatrale» (come osserva Enobarbo ai vv.
195-197); la riconciliazione con Cleopatra, come in precedenza, riapre lo spiraglio sulla sua
dimensione appassionata e gloriosa.
88 III, xiii, 107 Storicamente, e nella fonte, Antonio aveva avuto dei figli da Ottavia: Shakespeare
sembra sopprimere il fatto per accentuare la «freddezza» e la mera «convenienza» del loro
matrimonio.
89 III, xiii, 127 Il colle biblico, descritto nei Salmi (XXII, 12 e LXVIII, 15). Antonio vuol semplicemente
dire di essere il massimo cornuto, circondato dagli altri amanti di Cleopatra (the horned herd), di cui
egli però soverchia il muggito.
90 III, xiii, 146 Le sfere cristalline (o «cieli») del sistema tolemaico, familiari a noi lettori di Dante.
91 III, xiii, 149 Secondo la fonte, Ipparco aveva disertato Antonio per passare dalla parte di Cesare: la
rappresaglia di questi coinvolgerebbe un traditore, non un innocente.
92 III, xiii, 153 Cleopatra è our terrene moon anche per la sua equiparazione alla dea Iside (cfr. I, ii,
61 e III, vi, 17).
93 III, xiii, 157 Si tratta delle stringhe dei vestiti (a quell’epoca non esistevano i bottoni).
94 III, xiii, 160 sgg. Si afferma qui il motivo della dissoluzione e del liquefarsi, accennato dalle
precedenti allusioni alla dissoluzione di Roma (I, i, 33) e dell’Egitto (II, v, 78 e 94) ed ora sempre più
riferito ai protagonisti. Cfr. anche IV, xii, 20-23.
95 IV, iii, 15 Secondo la fonte, era Bacco, e non Ercole, ad abbandonare Antonio: la musica è