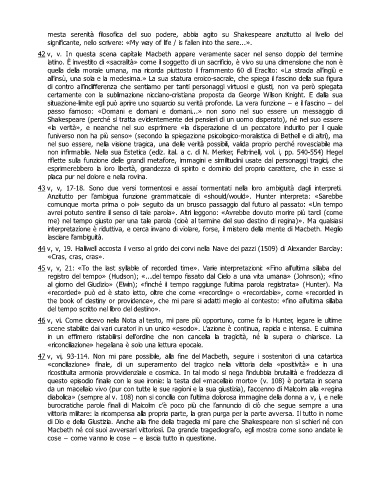Page 2189 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2189
mesta serenità filosofica del suo podere, abbia agito su Shakespeare anzitutto al livello del
significante, nello scrivere: «My way of life / is fallen into the sere...».
42 v, v. In questa scena capitale Macbeth appare veramente sacer nel senso doppio del termine
latino. È investito di «sacralità» come il soggetto di un sacrificio, è vivo su una dimensione che non è
quella della morale umana, ma ricorda piuttosto il frammento 60 di Eraclito: «La strada all’ingiù e
all’insù, una sola e la medesima.» La sua statura eroico-sacrale, che spiega il fascino della sua figura
di contro all’indifferenza che sentiamo per tanti personaggi virtuosi e giusti, non va però spiegata
certamente con la sublimazione nicciano-cristiana proposta da George Wilson Knight. E dalla sua
situazione-limite egli può aprire uno squarcio su verità profonde. La vera funzione − e il fascino − del
passo famoso: «Domani e domani e domani...» non sono nel suo essere un messaggio di
Shakespeare (perché si tratta evidentemente dei pensieri di un uomo disperato), né nel suo essere
«la verità», e neanche nel suo esprimere «la disperazione di un peccatore indurito per il quale
l’universo non ha più senso» (secondo la spiegazione psicologico-moralistica di Bethell e di altri), ma
nel suo essere, nella visione tragica, una delle verità possibili, valida proprio perché rovesciabile ma
non infirmabile. Nella sua Estetica (ediz. ital. a c. di N. Merker, Feltrinelli, vol. i, pp. 540-554) Hegel
riflette sulla funzione delle grandi metafore, immagini e similitudini usate dai personaggi tragici, che
esprimerebbero la loro libertà, grandezza di spirito e dominio del proprio carattere, che in esse si
placa pur nel dolore e nella rovina.
43 v, v, 17-18. Sono due versi tormentosi e assai tormentati nella loro ambiguità dagli interpreti.
Anzitutto per l’ambigua funzione grammaticale di «should/would». Hunter interpreta: «Sarebbe
comunque morta prima o poi» seguito da un brusco passaggio dal futuro al passato: «Un tempo
avrei potuto sentire il senso di tale parola». Altri leggono: «Avrebbe dovuto morire più tardi (come
me) nel tempo giusto per una tale parola (cioè al termine del suo destino di regina)». Ma qualsiasi
interpretazione è riduttiva, e cerca invano di violare, forse, il mistero della mente di Macbeth. Meglio
lasciare l’ambiguità.
44 v, v, 19. Halliwell accosta il verso al grido dei corvi nella Nave dei pazzi (1509) di Alexander Barclay:
«Cras, cras, cras».
45 v, v, 21: «To the last syllable of recorded time». Varie interpretazioni: «Fino all’ultima sillaba del
registro del tempo» (Hudson); «...del tempo fissato dal Cielo a una vita umana» (Johnson); «fino
al giorno del Giudizio» (Elwin); «finché il tempo raggiunge l’ultima parola registrata» (Hunter). Ma
«recorded» può ed è stato letto, oltre che come «recording» o «recordable», come «recorded in
the book of destiny or providence», che mi pare si adatti meglio al contesto: «fino all’ultima sillaba
del tempo scritto nel libro del destino».
46 v, vi. Come dicevo nella Nota al testo, mi pare più opportuno, come fa lo Hunter, legare le ultime
scene stabilite dai vari curatori in un unico «esodo». L’azione è continua, rapida e intensa. E culmina
in un effimero ristabilirsi dell’ordine che non cancella la tragicità, né la supera o chiarisce. La
«riconciliazione» hegeliana è solo una lettura epocale.
47 v, vi, 93-114. Non mi pare possibile, alla fine del Macbeth, seguire i sostenitori di una catartica
«conciliazione» finale, di un superamento del tragico nella vittoria della «positività» e in una
ricostituita armonia provvidenziale e cosmica. In tal modo si nega l’indubbia brutalità e freddezza di
questo episodio finale con le sue ironie: la testa del «macellaio morto» (v. 108) è portata in scena
da un macellaio vivo (pur con tutte le sue ragioni e la sua giustizia), l’accenno di Malcolm alla «regina
diabolica» (sempre al v. 108) non si concilia con l’ultima dolorosa immagine della donna a v, i, e nelle
burocratiche parole finali di Malcolm c’è poco più che l’annuncio di ciò che segue sempre a una
vittoria militare: la ricompensa alla propria parte, la gran purga per la parte avversa. Il tutto in nome
di Dio e della Giustizia. Anche alla fine della tragedia mi pare che Shakespeare non si schieri né con
Macbeth né coi suoi avversari vittoriosi. Da grande tragediografo, egli mostra come sono andate le
cose − come vanno le cose − e lascia tutto in questione.