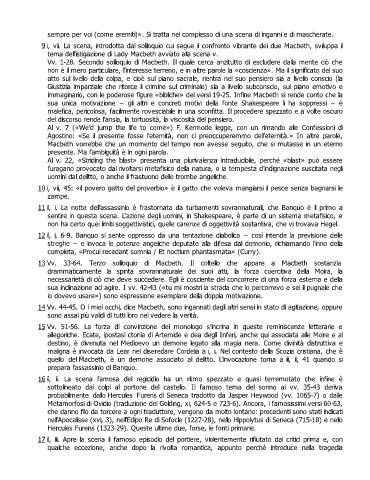Page 2185 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2185
sempre per voi (come eremiti)». Si tratta nel complesso di una scena di inganni e di mascherate.
9 i, vii. La scena, introdotta dal soliloquio cui segue il confronto vibrante dei due Macbeth, sviluppa il
tema dell’istigazione di Lady Macbeth avviato alla scena v.
Vv. 1-28. Secondo soliloquio di Macbeth. Il quale cerca anzitutto di escludere dalla mente ciò che
non è il mero particulare, l’interesse terreno, e in altre parole la «coscienza». Ma il significato del suo
atto sul livello della colpa, e cioè sul piano sacrale, rientra nel suo pensiero sia a livello conscio (la
Giustizia imparziale che ritorce il crimine sul criminale) sia a livello subconscio, sul piano emotivo e
immaginario, con le poderose figure «bibliche» dei versi 19-25. Infine Macbeth si rende conto che la
sua unica motivazione − gli altri e concreti motivi della fonte Shakespeare li ha soppressi − è
malefica, pericolosa, facilmente rovesciabile in una sconfitta. Il procedere spezzato e a volte oscuro
del discorso rende l’ansia, la tortuosità, la viscosità del pensiero.
Al v. 7 («We’d jump the life to come») F. Kermode legge, con un rimando alle Confessioni di
Agostino: «Se il presente fosse l’eternità, non ci preoccuperemmo dell’eternità.» In altre parole,
Macbeth vorrebbe che un momento del tempo non avesse seguito, che si mutasse in un eterno
presente. Ma l’ambiguità è in ogni parola.
Al v. 22, «Striding the blast» presenta una plurivalenza intraducibile, perché «blast» può essere
l’uragano provocato dal rivoltarsi metafisico della natura, o la tempesta d’indignazione suscitata negli
uomini dal delitto, o anche il frastuono delle trombe angeliche.
10 i, vii, 45: «il povero gatto del proverbio» è il gatto che voleva mangiarsi il pesce senza bagnarsi le
zampe.
11 ii, i. La notte dell’assassinio è frastornata da turbamenti sovrannaturali, che Banquo è il primo a
sentire in questa scena. L’azione degli uomini, in Shakespeare, è parte di un sistema metafisico, e
non ha certo quei limiti soggettivistici, quelle carenze di oggettività sostantiva, che vi trovava Hegel.
12 ii, i, 6-9. Banquo si sente oppresso da una tentazione diabolica − così intende la previsione delle
streghe − e invoca le potenze angeliche deputate alla difesa dal demonio, richiamando l’inno della
compieta, «Procul recedant somnia / Et noctium phantasmata» (Curry).
13 Vv. 33-64. Terzo soliloquio di Macbeth. Il coltello che appare a Macbeth sostanzia
drammaticamente la spinta sovrannaturale dei suoi atti, la forza coercitiva della Moira, la
necessarietà di ciò che deve succedere. Egli è cosciente del concorrere di una forza esterna e della
sua inclinazione ad agire. I vv. 42-43 («tu mi mostri la strada che io percorrevo e sei il pugnale che
io dovevo usare») sono espressione esemplare della doppia motivazione.
14 Vv. 44-45. O i miei occhi, dice Macbeth, sono ingannati dagli altri sensi in stato di agitazione, oppure
sono assai più validi di tutti loro nel vedere la verità.
15 Vv. 51-56. La forza di convinzione del monologo s’incrina in queste reminiscenze letterarie e
allegoriche. Ecate, ipostasi ctonia di Artemide e dea degli Inferi, anche qui associata alle Moire e al
destino, è divenuta nel Medioevo un demone legato alla magia nera. Come divinità distruttiva e
maligna è invocata da Lear nel diseredare Cordelia a i, i. Nel contesto della Scozia cristiana, che è
quello del Macbeth, è un demone associato al delitto. L’invocazione torna a iii, ii, 41 quando si
prepara l’assassinio di Banquo.
16 ii, ii. La scena famosa del regicidio ha un ritmo spezzato e quasi terremotato che infine è
sottolineato dai colpi al portone del castello. Il famoso tema del sonno ai vv. 35-43 deriva
probabilmente dallo Hercules Furens di Seneca tradotto da Jasper Heywood (vv. 1065-7) o dalle
Metamorfosi di Ovidio (traduzione del Golding, xi, 624-5 e 723-6). Ancora, i famosissimi versi 60-63,
che danno filo da torcere a ogni traduttore, vengono da molto lontano: precedenti sono stati indicati
nell’Apocalisse (xvi, 3), nell’Edipo Re di Sofocle (1227-28), nello Hippolytus di Seneca (715-18) e nello
Hercules Furens (1323-29). Queste ultime due, forse, le fonti primarie.
17 ii, iii. Apre la scena il famoso episodio del portiere, violentemente rifiutato dai critici prima e, con
qualche eccezione, anche dopo la rivolta romantica, appunto perché introduce nella tragedia