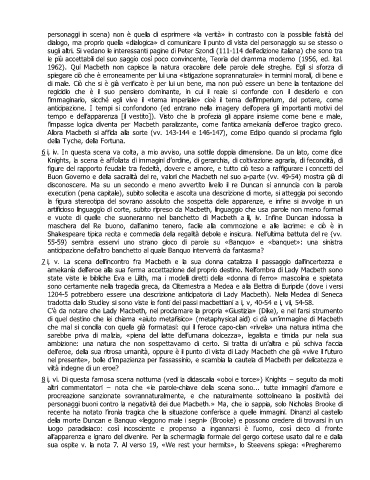Page 2184 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2184
personaggi in scena) non è quella di esprimere «la verità» in contrasto con la possibile falsità del
dialogo, ma proprio quella «dialogica» di comunicare il punto di vista del personaggio su se stesso o
sugli altri. Si vedano le interessanti pagine di Peter Szondi (111-114 dell’edizione italiana) che sono tra
le più accettabili del suo saggio così poco convincente, Teoria del dramma moderno (1956, ed. ital.
1962). Qui Macbeth non capisce la natura oracolare delle parole delle streghe. Egli si sforza di
spiegare ciò che è erroneamente per lui una «istigazione soprannaturale» in termini morali, di bene e
di male. Ciò che si è già verificato è per lui un bene, ma non può essere un bene la tentazione del
regicidio che è il suo pensiero dominante, in cui il reale si confonde con il desiderio e con
l’immaginario, sicché egli vive il «tema imperiale» cioè il tema dell’imperium, del potere, come
anticipazione. I tempi si confondono (ed entrano nella imagery dell’opera gli importanti motivi del
tempo e dell’apparenza [il vestito]). Visto che la profezia gli appare insieme come bene e male,
l’impasse logica diventa per Macbeth paralizzante, come l’antica amekanía dell’eroe tragico greco.
Allora Macbeth si affida alla sorte (vv. 143-144 e 146-147), come Edipo quando si proclama figlio
della Tyche, della Fortuna.
6 i, iv. In questa scena va colta, a mio avviso, una sottile doppia dimensione. Da un lato, come dice
Knights, la scena è affollata di immagini d’ordine, di gerarchia, di coltivazione agraria, di fecondità, di
figure del rapporto feudale tra fedeltà, dovere e amore, e tutto ciò teso a raffigurare i concetti del
Buon Governo e della sacralità del re, valori che Macbeth nel suo a-parte (vv. 49-54) mostra già di
disconoscere. Ma su un secondo e meno avvertito livello il re Duncan si annuncia con la parola
execution (pena capitale), subito sollecita e ascolta una descrizione di morte, si atteggia poi secondo
la figura stereotipa del sovrano assoluto che sospetta delle apparenze, e infine si avvolge in un
artificioso linguaggio di corte, subito ripreso da Macbeth, linguaggio che usa parole non meno formali
e vuote di quelle che suoneranno nel banchetto di Macbeth a iii, iv. Infine Duncan indossa la
maschera del Re buono, dall’animo tenero, facile alla commozione e alle lacrime: e ciò è in
Shakespeare tipica recita e commedia della regalità debole e insicura. Nell’ultima battuta del re (vv.
55-59) sembra esservi uno strano gioco di parole su «Banquo» e «banquet»: una sinistra
anticipazione dell’altro banchetto al quale Banquo interverrà da fantasma?
7 i, v. La scena dell’incontro fra Macbeth e la sua donna catalizza il passaggio dall’incertezza e
amekanía dell’eroe alla sua ferma accettazione del proprio destino. Nell’ombra di Lady Macbeth sono
state viste le bibliche Eva e Lilith, ma i modelli diretti della «donna di ferro» mascolina e spietata
sono certamente nella tragedia greca, da Clitemestra a Medea e alla Elettra di Euripide (dove i versi
1204-5 potrebbero essere una descrizione anticipatoria di Lady Macbeth). Nella Medea di Seneca
tradotta dallo Studley si sono viste le fonti dei passi macbettiani a i, v, 40-54 e i, vii, 54-58.
C’è da notare che Lady Macbeth, nel proclamare la propria «Giustizia» (Dike), e nel farsi strumento
di quel destino che lei chiama «aiuto metafisico» (metaphysical aid) ci dà un’immagine di Macbeth
che mal si concilia con quella già formatasi: qui il feroce capo-clan «rivela» una natura intima che
sarebbe priva di malizia, «piena del latte dell’umana dolcezza», legalista e timida pur nella sua
ambizione: una natura che non sospettavamo di certo. Si tratta di un’altra e più schiva faccia
dell’eroe, della sua ritrosa umanità, oppure è il punto di vista di Lady Macbeth che già «vive il futuro
nel presente», bolle d’impazienza per l’assassinio, e scambia la cautela di Macbeth per delicatezza e
viltà indegne di un eroe?
8 i, vi. Di questa famosa scena notturna (vedi la didascalia «oboi e torce») Knights − seguito da molti
altri commentatori − nota che «le parole-chiave della scena sono... tutte immagini d’amore e
procreazione sanzionate sovrannaturalmente, e che naturalmente sottolineano la positività dei
personaggi buoni contro la negatività dei due Macbeth.» Ma, che io sappia, solo Nicholas Brooke di
recente ha notato l’ironia tragica che la situazione conferisce a quelle immagini. Dinanzi al castello
della morte Duncan e Banquo «leggono male i segni» (Brooke) e possono credere di trovarsi in un
luogo paradisiaco: così incosciente e propenso a ingannarsi è l’uomo, così cieco di fronte
all’apparenza e ignaro del divenire. Per la schermaglia formale del gergo cortese usato dal re e dalla
sua ospite v. la nota 7. Al verso 19, «We rest your hermits», lo Steevens spiega: «Pregheremo