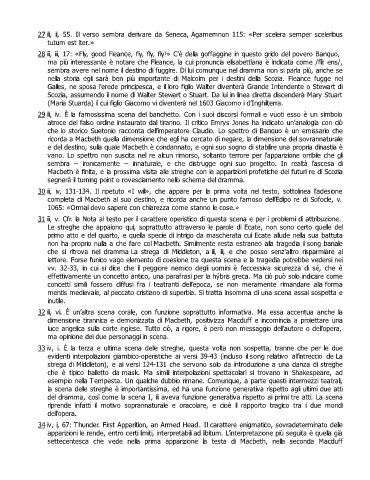Page 2187 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2187
27 iii, ii, 55. Il verso sembra derivare da Seneca, Agamemnon 115: «Per scelera semper sceleribus
tutum est iter.»
28 iii, iii, 17: «Fly, good Fleance, fly, fly, fly!» C’è della goffaggine in questo grido del povero Banquo,
ma più interessante è notare che Fleance, la cui pronuncia elisabettiana è indicata come /flì: ens/,
sembra avere nel nome il destino di fuggire. Di lui comunque nel dramma non si parla più, anche se
nella storia egli sarà ben più importante di Malcolm per i destini della Scozia. Fleance fugge nel
Galles, ne sposa l’erede principesca, e il loro figlio Walter diventerà Grande Intendente o Stewart di
Scozia, assumendo il nome di Walter Stewart o Stuart. Da lui in linea diretta discenderà Mary Stuart
(Maria Stuarda) il cui figlio Giacomo vi diventerà nel 1603 Giacomo i d’Inghilterra.
29 iii, iv. È la famosissima scena del banchetto. Con i suoi discorsi formali e vuoti esso è un simbolo
atroce del falso ordine instaurato dal tiranno. Il critico Emrys Jones ha indicato un’analogia con ciò
che lo storico Suetonio racconta dell’imperatore Claudio. Lo spettro di Banquo è un emissario che
ricorda a Macbeth quella dimensione che egli ha cercato di negare, la dimensione del sovrannaturale
e del destino, sulla quale Macbeth è condannato, e ogni suo sogno di stabilire una propria dinastia è
vano. Lo spettro non suscita nel re alcun rimorso, soltanto terrore per l’apparizione orribile che gli
sembra − ironicamente − innaturale, e che distrugge ogni suo progetto. In realtà l’ascesa di
Macbeth è finita, e la prossima visita alle streghe con le apparizioni profetiche dei futuri re di Scozia
segnerà il turning point o rovesciamento nello schema del dramma.
30 iii, iv, 131-134. Il ripetuto «I will», che appare per la prima volta nel testo, sottolinea l’adesione
completa di Macbeth al suo destino, e ricorda anche un punto famoso dell’Edipo re di Sofocle, v.
1065: «Ormai devo sapere con chiarezza come stanno le cose.»
31 iii, v. Cfr. la Nota al testo per il carattere operistico di questa scena e per i problemi di attribuzione.
Le streghe che appaiono qui, soprattutto attraverso le parole di Ecate, non sono certo quelle del
primo atto e del quarto, e quella specie di intrigo da mascherata cui Ecate allude nella sua battuta
non ha proprio nulla a che fare col Macbeth. Similmente resta estraneo alla tragedia il song banale
che si ritrova nel dramma La strega di Middleton, a iii, iii, e che posso senz’altro risparmiare al
lettore. Forse l’unico vago elemento di coesione tra questa scena e la tragedia potrebbe vedersi nei
vv. 32-33, in cui si dice che il peggiore nemico degli uomini è l’eccessiva sicurezza di sé, che è
effettivamente un concetto antico, una parafrasi per la hýbris greca. Ma ciò può solo indicare come
concetti simili fossero diffusi fra i teatranti dell’epoca, se non meramente rimandare alla forma
mentis medievale, al peccato cristiano di superbia. Si tratta insomma di una scena assai sospetta e
inutile.
32 iii, vi. È un’altra scena corale, con funzione soprattutto informativa. Ma essa accentua anche la
dimensione tirannica e demonizzata di Macbeth, positivizza Macduff e incomincia a proiettare una
luce angelica sulla corte inglese. Tutto ciò, a rigore, è però non messaggio dell’autore o dell’opera,
ma opinione dei due personaggi in scena.
33 iv, i. È la terza e ultima scena delle streghe, questa volta non sospetta, tranne che per le due
evidenti interpolazioni giambico-operistiche ai versi 39-43 (incluso il song relativo all’intreccio de La
strega di Middleton), e ai versi 124-131 che servono solo da introduzione a una danza di streghe
che è tipico balletto da mask. Ma simili interpolazioni spettacolari si trovano in Shakespeare, ad
esempio nella Tempesta. Un qualche dubbio rimane. Comunque, a parte questi intermezzi teatrali,
la scena delle streghe è importantissima, ed ha una funzione generativa rispetto agli ultimi due atti
del dramma, così come la scena I, iii aveva funzione generativa rispetto ai primi tre atti. La scena
riprende infatti il motivo soprannaturale e oracolare, e cioè il rapporto tragico tra i due mondi
dell’opera.
34 iv, i, 67: Thunder. First Apparition, an Armed Head. Il carattere enigmatico, sovradeterminato delle
apparizioni le rende, entro certi limiti, interpretabili ad libitum. L’interpretazione più seguita è quella già
settecentesca che vede nella prima apparizione la testa di Macbeth, nella seconda Macduff