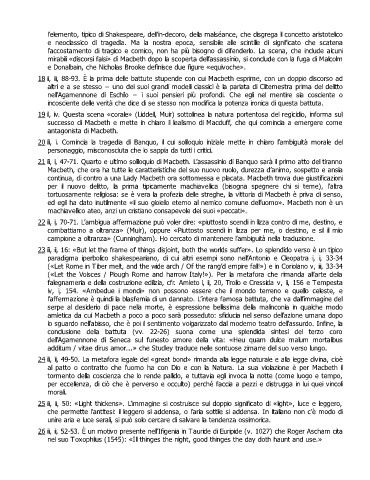Page 2186 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2186
l’elemento, tipico di Shakespeare, dell’in-decoro, della malséance, che disgrega il concetto aristotelico
e neoclassico di tragedia. Ma la nostra epoca, sensibile alle scintille di significato che scatena
l’accostamento di tragico e comico, non ha più bisogno di difenderlo. La scena, che include alcuni
mirabili «discorsi falsi» di Macbeth dopo la scoperta dell’assassinio, si conclude con la fuga di Malcolm
e Donalbain, che Nicholas Brooke definisce due figure «equivoche».
18 ii, iii, 88-93. È la prima delle battute stupende con cui Macbeth esprime, con un doppio discorso ad
altri e a se stesso − uno dei suoi grandi modelli classici è la parlata di Clitemestra prima del delitto
nell’Agamennone di Eschilo − i suoi pensieri più profondi. Che egli nel mentire sia cosciente o
incosciente delle verità che dice di se stesso non modifica la potenza ironica di questa battuta.
19 ii, iv. Questa scena «corale» (Liddell, Muir) sottolinea la natura portentosa del regicidio, informa sul
successo di Macbeth e mette in chiaro il lealismo di Macduff, che qui comincia a emergere come
antagonista di Macbeth.
20 iii, i. Comincia la tragedia di Banquo, il cui soliloquio iniziale mette in chiaro l’ambiguità morale del
personaggio, misconosciuta che io sappia da tutti i critici.
21 iii, i, 47-71. Quarto e ultimo soliloquio di Macbeth. L’assassinio di Banquo sarà il primo atto del tiranno
Macbeth, che ora ha tutte le caratteristiche del suo nuovo ruolo, durezza d’animo, sospetto e ansia
continua, di contro a una Lady Macbeth ora sottomessa e placata. Macbeth trova due giustificazioni
per il nuovo delitto, la prima tipicamente machiavellica (bisogna spegnere chi si teme), l’altra
tortuosamente religiosa: se è vera la profezia delle streghe, la vittoria di Macbeth è priva di senso,
ed egli ha dato inutilmente «il suo gioiello eterno al nemico comune dell’uomo». Macbeth non è un
machiavellico ateo, anzi un cristiano consapevole dei suoi «peccati».
22 iii, i, 70-71. L’ambigua affermazione può voler dire: «piuttosto scendi in lizza contro di me, destino, e
combattiamo a oltranza» (Muir), oppure «Piuttosto scendi in lizza per me, o destino, e sii il mio
campione a oltranza» (Cunningham). Ho cercato di mantenere l’ambiguità nella traduzione.
23 iii, ii, 16: «But let the frame of things disjoint, both the worlds suffer». Lo splendido verso è un tipico
paradigma iperbolico shakespeariano, di cui altri esempi sono nell’Antonio e Cleopatra i, i, 33-34
(«Let Rome in Tiber melt, and the wide arch / Of the rang’d empire fall!») e in Coriolano v, iii, 33-34
(«Let the Volsces / Plough Rome and harrow Italy!»). Per la metafora che rimanda all’arte della
falegnameria e della costruzione edilizia, cfr. Amleto i, ii, 20, Troilo e Cressida v, ii, 156 e Tempesta
iv, i, 154. «Ambedue i mondi» non possono essere che il mondo terreno e quello celeste, e
l’affermazione è quindi la blasfemia di un dannato. L’intera famosa battuta, che va dall’immagine del
serpe al desiderio di pace nella morte, è espressione bellissima della malinconia in qualche modo
amletica da cui Macbeth a poco a poco sarà posseduto: sfiducia nel senso dell’azione umana dopo
lo sguardo nell’abisso, che è poi il sentimento volgarizzato dal moderno teatro dell’assurdo. Infine, la
conclusione della battuta (vv. 22-26) suona come una splendida sintesi del terzo coro
dell’Agamennone di Seneca sul funesto amore della vita: «Heu quam dulce malum mortalibus
additum / vitae dirus amor...» che Studley traduce nelle sontuose zimarre del suo verso lungo.
24 iii, ii, 49-50. La metafora legale del «great bond» rimanda alla legge naturale e alla legge divina, cioè
al patto o contratto che l’uomo ha con Dio e con la Natura. La sua violazione è per Macbeth il
tormento della coscienza che lo rende pallido, e tuttavia egli invoca la notte (come luogo e tempo,
per eccellenza, di ciò che è perverso e occulto) perché faccia a pezzi e distrugga in lui quei vincoli
morali.
25 iii, ii, 50: «Light thickens». L’immagine si costruisce sul doppio significato di «light», luce e leggero,
che permette l’antitesi: il leggero si addensa, o l’aria sottile si addensa. In italiano non c’è modo di
unire aria e luce serali, si può solo cercare di salvare la tendenza ossimorica.
26 iii, ii, 52-53. È un motivo presente nell’Ifigenia in Tauride di Euripide (v. 1027) che Roger Ascham cita
nel suo Toxophilus (1545): «Ill thinges the night, good thinges the day doth haunt and use.»