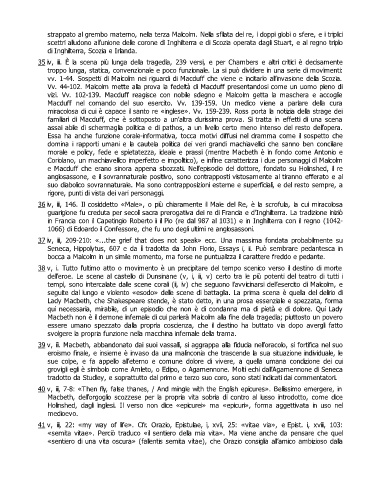Page 2188 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2188
strappato al grembo materno, nella terza Malcolm. Nella sfilata dei re, i doppi globi o sfere, e i triplici
scettri alludono all’unione delle corone di Inghilterra e di Scozia operata dagli Stuart, e al regno triplo
di Inghilterra, Scozia e Irlanda.
35 iv, iii. È la scena più lunga della tragedia, 239 versi, e per Chambers e altri critici è decisamente
troppo lunga, statica, convenzionale e poco funzionale. La si può dividere in una serie di movimenti:
vv. 1-44. Sospetti di Malcolm nei riguardi di Macduff che viene e incitarlo all’invasione della Scozia.
Vv. 44-102. Malcolm mette alla prova la fedeltà di Macduff presentandosi come un uomo pieno di
vizi. Vv. 102-139. Macduff reagisce con nobile sdegno e Malcolm getta la maschera e accoglie
Macduff nel comando del suo esercito. Vv. 139-159. Un medico viene a parlare della cura
miracolosa di cui è capace il santo re «inglese». Vv. 159-239. Ross porta la notizia della strage dei
familiari di Macduff, che è sottoposto a un’altra durissima prova. Si tratta in effetti di una scena
assai abile di schermaglia politica e di pathos, a un livello certo meno intenso del resto dell’opera.
Essa ha anche funzione corale-informativa, tocca motivi diffusi nel dramma come il sospetto che
domina i rapporti umani e la cautela politica dei veri grandi machiavellici che sanno ben conciliare
morale e policy, fede e spietatezza, ideale e prassi (mentre Macbeth è in fondo come Antonio e
Coriolano, un machiavellico imperfetto e impolitico), e infine caratterizza i due personaggi di Malcolm
e Macduff che erano sinora appena sbozzati. Nell’episodio del dottore, fondato su Holinshed, il re
anglosassone, e il sovrannaturale positivo, sono contrapposti vistosamente al tiranno efferato e al
suo diabolico sovrannaturale. Ma sono contrapposizioni esterne e superficiali, e del resto sempre, a
rigore, punti di vista dei vari personaggi.
36 iv, iii, 146. Il cosiddetto «Male», o più chiaramente il Male del Re, è la scrofula, la cui miracolosa
guarigione fu creduta per secoli sacra prerogativa dei re di Francia e d’Inghilterra. La tradizione iniziò
in Francia con il Capetingio Roberto ii il Pio (re dal 987 al 1031) e in Inghilterra con il regno (1042-
1066) di Edoardo il Confessore, che fu uno degli ultimi re anglosassoni.
37 iv, iii, 209-210: «...the grief that does not speak» ecc. Una massima fondata probabilmente su
Seneca, Hippolytus, 607 e da lì tradotta da John Florio, Essays i, ii. Può sembrare pedantesca in
bocca a Malcolm in un simile momento, ma forse ne puntualizza il carattere freddo e pedante.
38 v, i. Tutto l’ultimo atto o movimento è un precipitare del tempo scenico verso il destino di morte
dell’eroe. Le scene al castello di Dunsinane (v, i, iii, v) certo tra le più potenti del teatro di tutti i
tempi, sono intercalate dalle scene corali (ii, iv) che seguono l’avvicinarsi dell’esercito di Malcolm, e
seguite dal lungo e violento «esodo» delle scene di battaglia. La prima scena è quella del delirio di
Lady Macbeth, che Shakespeare stende, è stato detto, in una prosa essenziale e spezzata, forma
qui necessaria, mirabile, di un episodio che non è di condanna ma di pietà e di dolore. Qui Lady
Macbeth non è il demone infernale di cui parlerà Malcolm alla fine della tragedia; piuttosto un povero
essere umano spezzato dalla propria coscienza, che il destino ha buttato via dopo avergli fatto
svolgere la propria funzione nella macchina infernale della trama.
39 v, iii. Macbeth, abbandonato dai suoi vassalli, si aggrappa alla fiducia nell’oracolo, si fortifica nel suo
eroismo finale, e insieme è invaso da una malinconia che trascende la sua situazione individuale, le
sue colpe, e fa appello all’eterno e comune dolore di vivere, a quella umana condizione dei cui
grovigli egli è simbolo come Amleto, o Edipo, o Agamennone. Molti echi dall’Agamennone di Seneca
tradotto da Studley, e soprattutto dal primo e terzo suo coro, sono stati indicati dai commentatori.
40 v, iii, 7-8: «Then fly, false thanes, / And mingle with the English epicures». Bellissimo emergere, in
Macbeth, dell’orgoglio scozzese per la propria vita sobria di contro al lusso introdotto, come dice
Holinshed, dagli inglesi. Il verso non dice «epicurei» ma «epicuri», forma aggettivata in uso nel
medioevo.
41 v, iii, 22: «my way of life». Cfr. Orazio, Epistulae, i, xvii, 25: «vitae via», e Epist. i, xviii, 103:
«semita vitae». Perciò traduco «il sentiero della mia vita». Ma viene anche da pensare che quel
«sentiero di una vita oscura» (fallentis semita vitae), che Orazio consiglia all’amico ambizioso dalla