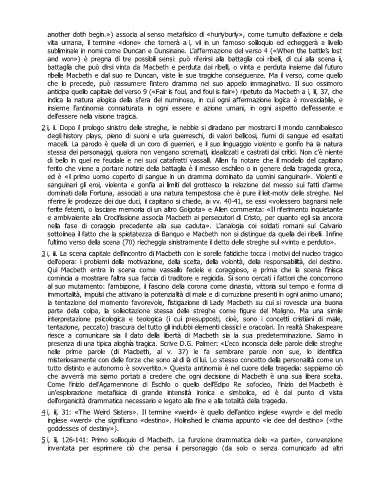Page 2183 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2183
another doth begin.») associa al senso metafisico di «hurlyburly», come tumulto dell’azione e della
vita umana, il termine «done» che tornerà a i, vii in un famoso soliloquio ed echeggerà a livello
subliminale in nomi come Duncan e Dunsinane. L’affermazione del verso 4 («When the battle’s lost
and won») è pregna di tre possibili sensi: può riferirsi alla battaglia coi ribelli, di cui alla scena ii,
battaglia che può dirsi vinta da Macbeth e perduta dai ribelli, o vinta e perduta insieme dal futuro
ribelle Macbeth e dal suo re Duncan, viste le sue tragiche conseguenze. Ma il verso, come quello
che lo precede, può riassumere l’intero dramma nel suo appello immaginativo. Il suo ossimoro
anticipa quello capitale del verso 9 («Fair is foul, and foul is fair») ripetuto da Macbeth a i, iii, 37, che
indica la natura alogica della sfera del numinoso, in cui ogni affermazione logica è rovesciabile, e
insieme l’antinomia connaturata in ogni essere e azione umani, in ogni aspetto dell’essente e
dell’essere nella visione tragica.
2 i, ii. Dopo il prologo sinistro delle streghe, le nebbie si diradano per mostrarci il mondo cannibalesco
degli history plays, pieno di suoni e urla guerreschi, di valori bellicosi, fiumi di sangue ed esaltati
macelli. La parodo è quella di un coro di guerrieri, e il suo linguaggio violento e gonfio ha la natura
stessa dei personaggi, qualora non vengano scremati, idealizzati e castrati dai critici. Non c’è niente
di bello in quel re feudale e nei suoi catafratti vassalli. Allen fa notare che il modello del capitano
ferito che viene a portare notizie della battaglia è il messo eschileo o in genere della tragedia greca,
ed è «il primo uomo coperto di sangue in un dramma dominato da uomini sanguinari». Violenti e
sanguinari gli eroi, violenta e gonfia ai limiti del grottesco la relazione del messo sui fatti d’arme
dominati dalla Fortuna, associati a una natura tempestosa che è pure il leit-motiv delle streghe. Nel
riferire le prodezze dei due duci, il capitano si chiede, ai vv. 40-41, se essi «volessero bagnarsi nelle
ferite fetenti, o lasciare memoria di un altro Golgota» e Allen commenta: «Il riferimento inquietante
e ambivalente alla Crocifissione associa Macbeth ai persecutori di Cristo, per quanto egli sia ancora
nella fase di coraggio precedente alla sua caduta». L’analogia coi soldati romani sul Calvario
sottolinea il fatto che la spietatezza di Banquo e Macbeth non si distingue da quella dei ribelli. Infine
l’ultimo verso della scena (70) riecheggia sinistramente il detto delle streghe sul «vinto e perduto».
3 i, iii. La scena capitale dell’incontro di Macbeth con le sorelle fatidiche tocca i motivi del nucleo tragico
dell’opera: i problemi della motivazione, della scelta, della volontà, della responsabilità, del destino.
Qui Macbeth entra in scena come vassallo fedele e coraggioso, e prima che la scena finisca
comincia a mostrare l’altra sua faccia di traditore e regicida. Si sono cercati i fattori che concorrono
al suo mutamento: l’ambizione, il fascino della corona come dinastia, vittoria sul tempo e forma di
immortalità, impulsi che attivano la potenzialità di male e di corruzione presenti in ogni animo umano;
la tentazione del momento favorevole, l’istigazione di Lady Macbeth su cui si rovescia una buona
parte della colpa, la sollecitazione stessa delle streghe come figure del Maligno. Ma una simile
interpretazione psicologica e teologica (i cui presupposti, cioè, sono i concetti cristiani di male,
tentazione, peccato) trascura del tutto gli indubbi elementi classici e oracolari. In realtà Shakespeare
riesce a comunicare sia il dato della libertà di Macbeth sia la sua predeterminazione. Siamo in
presenza di una tipica aloghía tragica. Scrive D.G. Palmer: «L’eco inconscia delle parole delle streghe
nelle prime parole (di Macbeth, al v. 37) le fa sembrare parole non sue, lo identifica
misteriosamente con delle forze che sono al di là di lui. Lo stesso concetto della personalità come un
tutto distinto e autonomo è sovvertito.» Questa antinomia è nel cuore della tragedia: sappiamo ciò
che avverrà ma siamo portati a credere che ogni decisione di Macbeth è una sua libera scelta.
Come l’inizio dell’Agamennone di Eschilo o quello dell’Edipo Re sofocleo, l’inizio del Macbeth è
un’esplorazione metafisica di grande intensità ironica e simbolica, ed è dal punto di vista
dell’organicità drammatica necessario e legato alla fine e alla totalità della tragedia.
4 i, iii, 31: «The Weird Sisters». Il termine «weird» è quello dell’antico inglese «wyrd» e del medio
inglese «werd» che significano «destino». Holinshed le chiama appunto «le dee del destino» («the
goddesses of destiny»).
5 i, iii, 126-141: Primo soliloquio di Macbeth. La funzione drammatica dello «a parte», convenzione
inventata per esprimere ciò che pensa il personaggio (da solo o senza comunicarlo ad altri