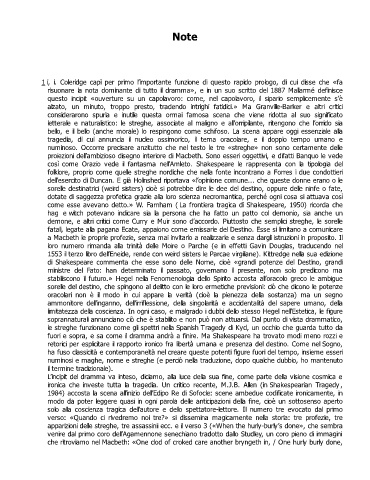Page 2182 - Shakespeare - Vol. 3
P. 2182
Note
1 i, i. Coleridge capì per primo l’importante funzione di questo rapido prologo, di cui disse che «fa
risuonare la nota dominante di tutto il dramma», e in un suo scritto del 1887 Mallarmé definisce
questo incipit «ouverture su un capolavoro: come, nel capolavoro, il sipario semplicemente s’è
alzato, un minuto, troppo presto, tradendo intrighi fatidici.» Ma Granville-Barker e altri critici
considerarono spuria e inutile questa ormai famosa scena che viene ridotta al suo significato
letterale e naturalistico: le streghe, associate al maligno e all’orripilante, ritengono che l’orrido sia
bello, e il bello (anche morale) lo respingono come schifoso. La scena appare oggi essenziale alla
tragedia, di cui annuncia il nucleo ossimorico, il tema oracolare, e il doppio tempo umano e
numinoso. Occorre precisare anzitutto che nel testo le tre «streghe» non sono certamente delle
proiezioni dell’ambizioso disegno interiore di Macbeth. Sono esseri oggettivi, e difatti Banquo le vede
così come Orazio vede il fantasma nell’Amleto. Shakespeare le rappresenta con la tipologia del
folklore, proprio come quelle streghe nordiche che nella fonte incontrano a Forres i due condottieri
dell’esercito di Duncan. E già Holinshed riportava «l’opinione comune... che queste donne erano o le
sorelle destinatrici (weird sisters) cioè si potrebbe dire le dee del destino, oppure delle ninfe o fate,
dotate di saggezza profetica grazie alla loro scienza necromantica, perché ogni cosa si attuava così
come esse avevano detto.» W. Farnham ( La frontiera tragica di Shakespeare, 1950) ricorda che
hag e witch potevano indicare sia la persona che ha fatto un patto col demonio, sia anche un
demone, e altri critici come Curry e Muir sono d’accordo. Piuttosto che semplici streghe, le sorelle
fatali, legate alla pagana Ecate, appaiono come emissarie del Destino. Esse si limitano a comunicare
a Macbeth le proprie profezie, senza mai invitarlo a realizzarle e senza dargli istruzioni in proposito. Il
loro numero rimanda alla trinità delle Moire o Parche (e in effetti Gavin Douglas, traducendo nel
1553 il terzo libro dell’Eneide, rende con weird sisters le Parcae virgiliane). Kittredge nella sua edizione
di Shakespeare commenta che esse sono delle Norne, cioè «grandi potenze del Destino, grandi
ministre del Fato: han determinato il passato, governano il presente, non solo predicono ma
stabiliscono il futuro.» Hegel nella Fenomenologia dello Spirito accosta all’oracolo greco le ambigue
sorelle del destino, che spingono al delitto con le loro ermetiche previsioni: ciò che dicono le potenze
oracolari non è il modo in cui appare la verità (cioè la pienezza della sostanza) ma un segno
ammonitore dell’inganno, dell’irriflessione, della singolarità e accidentalità del sapere umano, della
limitatezza della coscienza. In ogni caso, e malgrado i dubbi dello stesso Hegel nell’Estetica, le figure
soprannaturali annunciano ciò che è stabilito e non può non attuarsi. Dal punto di vista drammatico,
le streghe funzionano come gli spettri nella Spanish Tragedy di Kyd, un occhio che guarda tutto da
fuori e sopra, e sa come il dramma andrà a finire. Ma Shakespeare ha trovato modi meno rozzi e
retorici per esplicitare il rapporto ironico fra libertà umana e presenza del destino. Come nel Sogno,
ha fuso classicità e contemporaneità nel creare queste potenti figure fuori del tempo, insieme esseri
numinosi e maghe, norne e streghe (e perciò nella traduzione, dopo qualche dubbio, ho mantenuto
il termine tradizionale).
L’incipit del dramma va inteso, diciamo, alla luce della sua fine, come parte della visione cosmica e
ironica che investe tutta la tragedia. Un critico recente, M.J.B. Allen (in Shakespearian Tragedy ,
1984) accosta la scena all’inizio dell’Edipo Re di Sofocle: scene ambedue codificate ironicamente, in
modo da poter leggere quasi in ogni parola delle anticipazioni della fine, cioè un sottosenso aperto
solo alla coscienza tragica dell’autore e dello spettatore-lettore. Il numero tre evocato dal primo
verso: «Quando ci rivedremo noi tre?» si dissemina magicamente nella storia: tre profezie, tre
apparizioni delle streghe, tre assassinii ecc. e il verso 3 («When the hurly-burly’s done», che sembra
venire dal primo coro dell’Agamennone senechiano tradotto dallo Studley, un coro pieno di immagini
che ritroviamo nel Macbeth: «One clod of croked care another bryngeth in, / One hurly burly done,