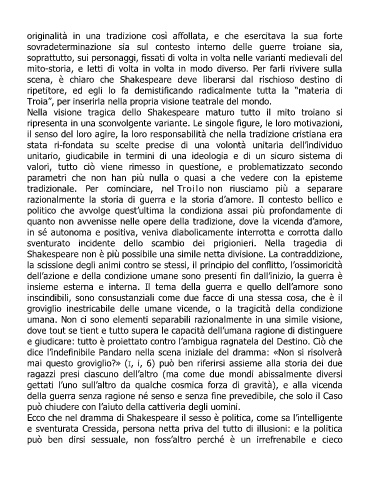Page 2580 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2580
originalità in una tradizione così affollata, e che esercitava la sua forte
sovradeterminazione sia sul contesto interno delle guerre troiane sia,
soprattutto, sui personaggi, fissati di volta in volta nelle varianti medievali del
mito-storia, e letti di volta in volta in modo diverso. Per farli rivivere sulla
scena, è chiaro che Shakespeare deve liberarsi dal rischioso destino di
ripetitore, ed egli lo fa demistificando radicalmente tutta la “materia di
Troia”, per inserirla nella propria visione teatrale del mondo.
Nella visione tragica dello Shakespeare maturo tutto il mito troiano si
ripresenta in una sconvolgente variante. Le singole figure, le loro motivazioni,
il senso del loro agire, la loro responsabilità che nella tradizione cristiana era
stata ri-fondata su scelte precise di una volontà unitaria dell’individuo
unitario, giudicabile in termini di una ideologia e di un sicuro sistema di
valori, tutto ciò viene rimesso in questione, e problematizzato secondo
parametri che non han più nulla o quasi a che vedere con la episteme
tradizionale. Per cominciare, nel Troilo non riusciamo più a separare
razionalmente la storia di guerra e la storia d’amore. Il contesto bellico e
politico che avvolge quest’ultima la condiziona assai più profondamente di
quanto non avvenisse nelle opere della tradizione, dove la vicenda d’amore,
in sé autonoma e positiva, veniva diabolicamente interrotta e corrotta dallo
sventurato incidente dello scambio dei prigionieri. Nella tragedia di
Shakespeare non è più possibile una simile netta divisione. La contraddizione,
la scissione degli animi contro se stessi, il principio del conflitto, l’ossimoricità
dell’azione e della condizione umane sono presenti fin dall’inizio, la guerra è
insieme esterna e interna. Il tema della guerra e quello dell’amore sono
inscindibili, sono consustanziali come due facce di una stessa cosa, che è il
groviglio inestricabile delle umane vicende, o la tragicità della condizione
umana. Non ci sono elementi separabili razionalmente in una simile visione,
dove tout se tient e tutto supera le capacità dell’umana ragione di distinguere
e giudicare: tutto è proiettato contro l’ambigua ragnatela del Destino. Ciò che
dice l’indefinibile Pandaro nella scena iniziale del dramma: «Non si risolverà
mai questo groviglio?» (I, i, 6) può ben riferirsi assieme alla storia dei due
ragazzi presi ciascuno dell’altro (ma come due mondi abissalmente diversi
gettati l’uno sull’altro da qualche cosmica forza di gravità), e alla vicenda
della guerra senza ragione né senso e senza fine prevedibile, che solo il Caso
può chiudere con l’aiuto della cattiveria degli uomini.
Ecco che nel dramma di Shakespeare il sesso è politica, come sa l’intelligente
e sventurata Cressida, persona netta priva del tutto di illusioni: e la politica
può ben dirsi sessuale, non foss’altro perché è un irrefrenabile e cieco