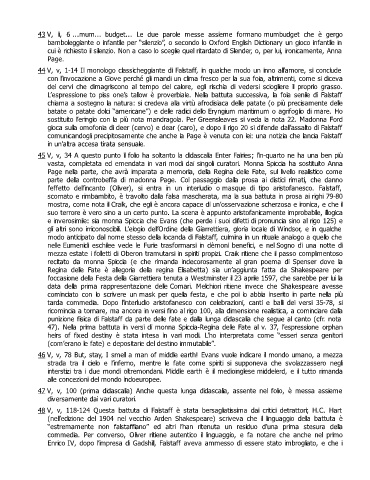Page 2575 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2575
43 V, ii, 6 ...mum... budget... Le due parole messe assieme formano mumbudget che è gergo
bamboleggiante o infantile per “silenzio”, o secondo lo Oxford English Dictionary un gioco infantile in
cui è richiesto il silenzio. Non a caso lo sceglie quel ritardato di Slender, o, per lui, ironicamente, Anna
Page.
44 V, v, 1-14 Il monologo classicheggiante di Falstaff, in qualche modo un inno all’amore, si conclude
con l’invocazione a Giove perché gli mandi un clima fresco per la sua foia, altrimenti, come si diceva
dei cervi che dimagriscono al tempo del calore, egli rischia di vedersi sciogliere il proprio grasso.
L’espressione to piss one’s tallow è proverbiale. Nella battuta successiva, la foia senile di Falstaff
chiama a sostegno la natura: si credeva alla virtù afrodisiaca delle patate (o più precisamente delle
batate o patate dolci “americane”) e delle radici dello Eryngium maritimum o agrifoglio di mare. Ho
sostituito l’eringio con la più nota mandragola. Per Greensleaves si veda la nota 22. Madonna Ford
gioca sulla omofonia di deer (cervo) e dear (caro), e dopo il rigo 20 si difende dall’assalto di Falstaff
comunicandogli precipitosamente che anche la Page è venuta con lei: una notizia che lancia Falstaff
in un’altra accesa tirata sensuale.
45 V, v, 34 A questo punto il folio ha soltanto la didascalia Enter Fairies; l’in-quarto ne ha una ben più
vasta, completata ed emendata in vari modi dai singoli curatori. Monna Spiccia ha sostituito Anna
Page nella parte, che avrà imparata a memoria, della Regina delle Fate, sul livello realistico come
parte della controbeffa di madonna Page. Col passaggio dalla prosa ai distici rimati, che danno
l’effetto dell’incanto (Oliver), si entra in un interludio o masque di tipo aristofanesco. Falstaff,
scornato e rimbambito, è travolto dalla falsa mascherata, ma la sua battuta in prosa ai righi 79-80
mostra, come nota il Craik, che egli è ancora capace di un’osservazione scherzosa e ironica, e che il
suo terrore è vero sino a un certo punto. La scena è appunto aristofanicamente improbabile, illogica
e inverosimile: sia monna Spiccia che Evans (che perde i suoi difetti di pronuncia sino al rigo 125) e
gli altri sono irriconoscibili. L’elogio dell’Ordine della Giarrettiera, gloria locale di Windsor, e in qualche
modo anticipato dal nome stesso della locanda di Falstaff, culmina in un rituale analogo a quello che
nelle Eumenidi eschilee vede le Furie trasformarsi in dèmoni benefici, e nel Sogno di una notte di
mezza estate i folletti di Oberon tramutarsi in spiriti propizi. Craik ritiene che il passo complimentoso
recitato da monna Spiccia (e che rimanda indecorosamente al gran poema di Spenser dove la
Regina delle Fate è allegoria della regina Elisabetta) sia un’aggiunta fatta da Shakespeare per
l’occasione della Festa della Giarrettiera tenuta a Westminster il 23 aprile 1597, che sarebbe per lui la
data della prima rappresentazione delle Comari. Melchiori ritiene invece che Shakespeare avesse
cominciato con lo scrivere un mask per quella festa, e che poi lo abbia inserito in parte nella più
tarda commedia. Dopo l’interludio aristofanesco con celebrazioni, canti e balli dei versi 35-78, si
ricomincia a tornare, ma ancora in versi fino al rigo 100, alla dimensione realistica, a cominciare dalla
punizione fisica di Falstaff da parte delle fate e dalla lunga didascalia che segue al canto (cfr. nota
47). Nella prima battuta in versi di monna Spiccia-Regina delle Fate al v. 37, l’espressione orphan
heirs of fixed destiny è stata intesa in vari modi. L’ho interpretata come “esseri senza genitori
(com’erano le fate) e depositarie del destino immutabile”.
46 V, v, 78 But, stay, I smell a man of middle earth! Evans vuole indicare il mondo umano, a mezza
strada tra il cielo e l’inferno, mentre le fate come spiriti si supponeva che svolazzassero negli
interstizi tra i due mondi oltremondani. Middle earth è il medioinglese middelerd, e il tutto rimanda
alle concezioni del mondo indoeuropee.
47 V, v, 100 (prima didascalia) Anche questa lunga didascalia, assente nel folio, è messa assieme
diversamente dai vari curatori.
48 V, v, 118-124 Questa battuta di Falstaff è stata bersagliatissima dai critici detrattori; H.C. Hart
(nell’edizione del 1904 nel vecchio Arden Shakespeare) scriveva che il linguaggio della battuta è
“estremamente non falstaffiano” ed altri l’han ritenuta un residuo d’una prima stesura della
commedia. Per converso, Oliver ritiene autentico il linguaggio, e fa notare che anche nel primo
Enrico IV, dopo l’impresa di Gadshill, Falstaff aveva ammesso di essere stato imbrogliato, e che i