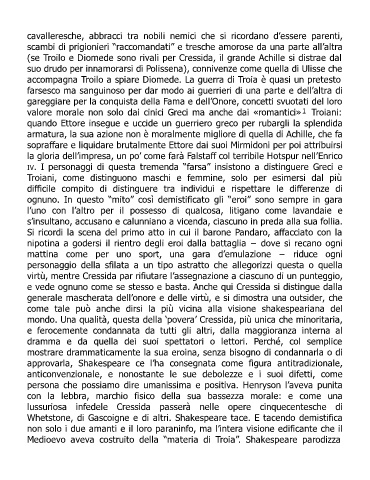Page 2584 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2584
cavalleresche, abbracci tra nobili nemici che si ricordano d’essere parenti,
scambi di prigionieri “raccomandati” e tresche amorose da una parte all’altra
(se Troilo e Diomede sono rivali per Cressida, il grande Achille si distrae dal
suo drudo per innamorarsi di Polissena), connivenze come quella di Ulisse che
accompagna Troilo a spiare Diomede. La guerra di Troia è quasi un pretesto
farsesco ma sanguinoso per dar modo ai guerrieri di una parte e dell’altra di
gareggiare per la conquista della Fama e dell’Onore, concetti svuotati del loro
1
valore morale non solo dai cinici Greci ma anche dai «romantici» Troiani:
quando Ettore insegue e uccide un guerriero greco per rubargli la splendida
armatura, la sua azione non è moralmente migliore di quella di Achille, che fa
sopraffare e liquidare brutalmente Ettore dai suoi Mirmidoni per poi attribuirsi
la gloria dell’impresa, un po’ come farà Falstaff col terribile Hotspur nell’Enrico
IV. I personaggi di questa tremenda “farsa” insistono a distinguere Greci e
Troiani, come distinguono maschi e femmine, solo per esimersi dal più
difficile compito di distinguere tra individui e rispettare le differenze di
ognuno. In questo “mito” così demistificato gli “eroi” sono sempre in gara
l’uno con l’altro per il possesso di qualcosa, litigano come lavandaie e
s’insultano, accusano e calunniano a vicenda, ciascuno in preda alla sua follia.
Si ricordi la scena del primo atto in cui il barone Pandaro, affacciato con la
nipotina a godersi il rientro degli eroi dalla battaglia − dove si recano ogni
mattina come per uno sport, una gara d’emulazione − riduce ogni
personaggio della sfilata a un tipo astratto che allegorizzi questa o quella
virtù, mentre Cressida par rifiutare l’assegnazione a ciascuno di un punteggio,
e vede ognuno come se stesso e basta. Anche qui Cressida si distingue dalla
generale mascherata dell’onore e delle virtù, e si dimostra una outsider, che
come tale può anche dirsi la più vicina alla visione shakespeariana del
mondo. Una qualità, questa della ‘povera’ Cressida, più unica che minoritaria,
e ferocemente condannata da tutti gli altri, dalla maggioranza interna al
dramma e da quella dei suoi spettatori o lettori. Perché, col semplice
mostrare drammaticamente la sua eroina, senza bisogno di condannarla o di
approvarla, Shakespeare ce l’ha consegnata come figura antitradizionale,
anticonvenzionale, e nonostante le sue debolezze e i suoi difetti, come
persona che possiamo dire umanissima e positiva. Henryson l’aveva punita
con la lebbra, marchio fisico della sua bassezza morale: e come una
lussuriosa infedele Cressida passerà nelle opere cinquecentesche di
Whetstone, di Gascoigne e di altri. Shakespeare tace. E tacendo demistifica
non solo i due amanti e il loro paraninfo, ma l’intera visione edificante che il
Medioevo aveva costruito della “materia di Troia”. Shakespeare parodizza