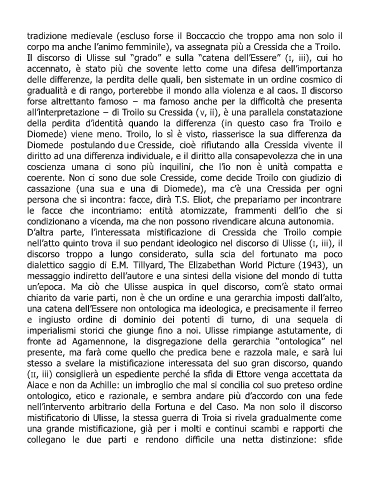Page 2583 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2583
tradizione medievale (escluso forse il Boccaccio che troppo ama non solo il
corpo ma anche l’animo femminile), va assegnata più a Cressida che a Troilo.
Il discorso di Ulisse sul “grado” e sulla “catena dell’Essere” (I, iii), cui ho
accennato, è stato più che sovente letto come una difesa dell’importanza
delle differenze, la perdita delle quali, ben sistemate in un ordine cosmico di
gradualità e di rango, porterebbe il mondo alla violenza e al caos. Il discorso
forse altrettanto famoso − ma famoso anche per la difficoltà che presenta
all’interpretazione − di Troilo su Cressida ( V, ii), è una parallela constatazione
della perdita d’identità quando la differenza (in questo caso fra Troilo e
Diomede) viene meno. Troilo, lo sì è visto, riasserisce la sua differenza da
Diomede postulando due Cresside, cioè rifiutando alla Cressida vivente il
diritto ad una differenza individuale, e il diritto alla consapevolezza che in una
coscienza umana ci sono più inquilini, che l’io non è unità compatta e
coerente. Non ci sono due sole Cresside, come decide Troilo con giudizio di
cassazione (una sua e una di Diomede), ma c’è una Cressida per ogni
persona che si incontra: facce, dirà T.S. Eliot, che prepariamo per incontrare
le facce che incontriamo: entità atomizzate, frammenti dell’io che si
condizionano a vicenda, ma che non possono rivendicare alcuna autonomia.
D’altra parte, l’interessata mistificazione di Cressida che Troilo compie
nell’atto quinto trova il suo pendant ideologico nel discorso di Ulisse (I, iii), il
discorso troppo a lungo considerato, sulla scia del fortunato ma poco
dialettico saggio di E.M. Tillyard, The Elizabethan World Picture (1943), un
messaggio indiretto dell’autore e una sintesi della visione del mondo di tutta
un’epoca. Ma ciò che Ulisse auspica in quel discorso, com’è stato ormai
chiarito da varie parti, non è che un ordine e una gerarchia imposti dall’alto,
una catena dell’Essere non ontologica ma ideologica, e precisamente il ferreo
e ingiusto ordine di dominio dei potenti di turno, di una sequela di
imperialismi storici che giunge fino a noi. Ulisse rimpiange astutamente, di
fronte ad Agamennone, la disgregazione della gerarchia “ontologica” nel
presente, ma farà come quello che predica bene e razzola male, e sarà lui
stesso a svelare la mistificazione interessata del suo gran discorso, quando
(II, iii) consiglierà un espediente perché la sfida di Ettore venga accettata da
Aiace e non da Achille: un imbroglio che mal si concilia col suo preteso ordine
ontologico, etico e razionale, e sembra andare più d’accordo con una fede
nell’intervento arbitrario della Fortuna e del Caso. Ma non solo il discorso
mistificatorio di Ulisse, la stessa guerra di Troia si rivela gradualmente come
una grande mistificazione, già per i molti e continui scambi e rapporti che
collegano le due parti e rendono difficile una netta distinzione: sfide