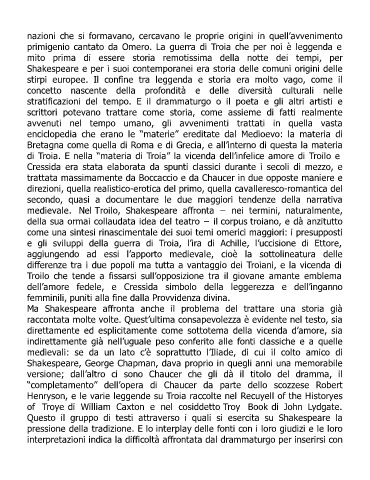Page 2579 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2579
nazioni che si formavano, cercavano le proprie origini in quell’avvenimento
primigenio cantato da Omero. La guerra di Troia che per noi è leggenda e
mito prima di essere storia remotissima della notte dei tempi, per
Shakespeare e per i suoi contemporanei era storia delle comuni origini delle
stirpi europee. Il confine tra leggenda e storia era molto vago, come il
concetto nascente della profondità e delle diversità culturali nelle
stratificazioni del tempo. E il drammaturgo o il poeta e gli altri artisti e
scrittori potevano trattare come storia, come assieme di fatti realmente
avvenuti nel tempo umano, gli avvenimenti trattati in quella vasta
enciclopedia che erano le “materie” ereditate dal Medioevo: la materia di
Bretagna come quella di Roma e di Grecia, e all’interno di questa la materia
di Troia. E nella “materia di Troia” la vicenda dell’infelice amore di Troilo e
Cressida era stata elaborata da spunti classici durante i secoli di mezzo, e
trattata massimamente da Boccaccio e da Chaucer in due opposte maniere e
direzioni, quella realistico-erotica del primo, quella cavalleresco-romantica del
secondo, quasi a documentare le due maggiori tendenze della narrativa
medievale. Nel Troilo, Shakespeare affronta − nei termini, naturalmente,
della sua ormai collaudata idea del teatro − il corpus troiano, e dà anzitutto
come una sintesi rinascimentale dei suoi temi omerici maggiori: i presupposti
e gli sviluppi della guerra di Troia, l’ira di Achille, l’uccisione di Ettore,
aggiungendo ad essi l’apporto medievale, cioè la sottolineatura delle
differenze tra i due popoli ma tutta a vantaggio dei Troiani, e la vicenda di
Troilo che tende a fissarsi sull’opposizione tra il giovane amante emblema
dell’amore fedele, e Cressida simbolo della leggerezza e dell’inganno
femminili, puniti alla fine dalla Provvidenza divina.
Ma Shakespeare affronta anche il problema del trattare una storia già
raccontata molte volte. Quest’ultima consapevolezza è evidente nel testo, sia
direttamente ed esplicitamente come sottotema della vicenda d’amore, sia
indirettamente già nell’uguale peso conferito alle fonti classiche e a quelle
medievali: se da un lato c’è soprattutto l’Iliade, di cui il colto amico di
Shakespeare, George Chapman, dava proprio in quegli anni una memorabile
versione; dall’altro ci sono Chaucer che gli dà il titolo del dramma, il
“completamento” dell’opera di Chaucer da parte dello scozzese Robert
Henryson, e le varie leggende su Troia raccolte nel Recuyell of the Historyes
of Troye di William Caxton e nel cosiddetto Troy Book di John Lydgate.
Questo il gruppo di testi attraverso i quali si esercita su Shakespeare la
pressione della tradizione. E lo interplay delle fonti con i loro giudizi e le loro
interpretazioni indica la difficoltà affrontata dal drammaturgo per inserirsi con