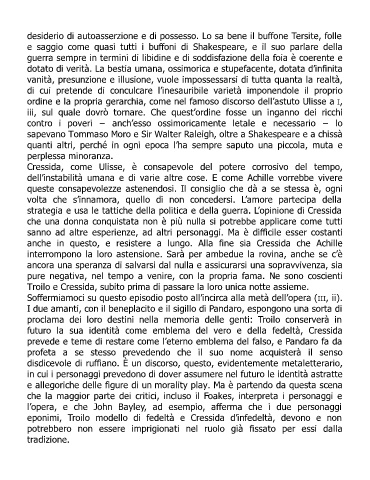Page 2581 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2581
desiderio di autoasserzione e di possesso. Lo sa bene il buffone Tersite, folle
e saggio come quasi tutti i buffoni di Shakespeare, e il suo parlare della
guerra sempre in termini di libidine e di soddisfazione della foia è coerente e
dotato di verità. La bestia umana, ossimorica e stupefacente, dotata d’infinita
vanità, presunzione e illusione, vuole impossessarsi di tutta quanta la realtà,
di cui pretende di conculcare l’inesauribile varietà imponendole il proprio
ordine e la propria gerarchia, come nel famoso discorso dell’astuto Ulisse a I,
iii, sul quale dovrò tornare. Che quest’ordine fosse un inganno dei ricchi
contro i poveri − anch’esso ossimoricamente letale e necessario − lo
sapevano Tommaso Moro e Sir Walter Raleigh, oltre a Shakespeare e a chissà
quanti altri, perché in ogni epoca l’ha sempre saputo una piccola, muta e
perplessa minoranza.
Cressida, come Ulisse, è consapevole del potere corrosivo del tempo,
dell’instabilità umana e di varie altre cose. E come Achille vorrebbe vivere
queste consapevolezze astenendosi. Il consiglio che dà a se stessa è, ogni
volta che s’innamora, quello di non concedersi. L’amore partecipa della
strategia e usa le tattiche della politica e della guerra. L’opinione di Cressida
che una donna conquistata non è più nulla si potrebbe applicare come tutti
sanno ad altre esperienze, ad altri personaggi. Ma è difficile esser costanti
anche in questo, e resistere a lungo. Alla fine sia Cressida che Achille
interrompono la loro astensione. Sarà per ambedue la rovina, anche se c’è
ancora una speranza di salvarsi dal nulla e assicurarsi una sopravvivenza, sia
pure negativa, nel tempo a venire, con la propria fama. Ne sono coscienti
Troilo e Cressida, subito prima di passare la loro unica notte assieme.
Soffermiamoci su questo episodio posto all’incirca alla metà dell’opera (III, ii).
I due amanti, con il beneplacito e il sigillo di Pandaro, espongono una sorta di
proclama dei loro destini nella memoria delle genti: Troilo conserverà in
futuro la sua identità come emblema del vero e della fedeltà, Cressida
prevede e teme di restare come l’eterno emblema del falso, e Pandaro fa da
profeta a se stesso prevedendo che il suo nome acquisterà il senso
disdicevole di ruffiano. È un discorso, questo, evidentemente metaletterario,
in cui i personaggi prevedono di dover assumere nel futuro le identità astratte
e allegoriche delle figure di un morality play. Ma è partendo da questa scena
che la maggior parte dei critici, incluso il Foakes, interpreta i personaggi e
l’opera, e che John Bayley, ad esempio, afferma che i due personaggi
eponimi, Troilo modello di fedeltà e Cressida d’infedeltà, devono e non
potrebbero non essere imprigionati nel ruolo già fissato per essi dalla
tradizione.