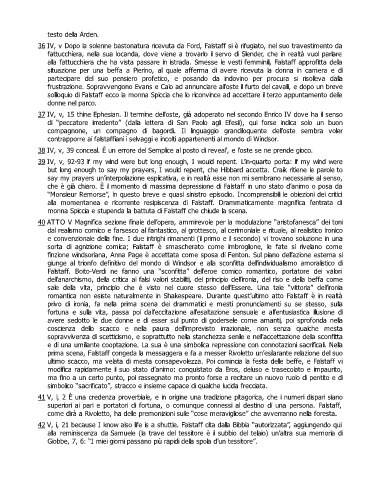Page 2574 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2574
testo della Arden.
36 IV, v Dopo la solenne bastonatura ricevuta da Ford, Falstaff si è rifugiato, nel suo travestimento da
fattucchiera, nella sua locanda, dove viene a trovarlo il servo di Slender, che in realtà vuol parlare
alla fattucchiera che ha vista passare in istrada. Smesse le vesti femminili, Falstaff approfitta della
situazione per una beffa a Pierino, al quale afferma di avere ricevuta la donna in camera e di
partecipare del suo pensiero profetico, e posando da indovino per procura si risolleva dalla
frustrazione. Sopravvengono Evans e Caio ad annunciare all’oste il furto dei cavalli, e dopo un breve
soliloquio di Falstaff ecco la monna Spiccia che lo riconvince ad accettare il terzo appuntamento delle
donne nel parco.
37 IV, v, 15 thine Ephesian. Il termine dell’oste, già adoperato nel secondo Enrico IV dove ha il senso
di “peccatore irredento” (dalla lettera di San Paolo agli Efesii), qui forse indica solo un buon
compagnone, un compagno di bagordi. Il linguaggio grandiloquente dell’oste sembra voler
contrapporre ai falstaffiani i selvaggi e incolti appartenenti al mondo di Windsor.
38 IV, v, 39 conceal. È un errore del Semplice al posto di reveal’, e l’oste se ne prende gioco.
39 IV, v, 92-93 if my wind were but long enough, I would repent. L’in-quarto porta: if my wind were
but long enough to say my prayers, I would repent, che Hibbard accetta. Craik ritiene le parole to
say my prayers un’interpolazione esplicativa, e in realtà esse non mi sembrano necessarie al senso,
che è già chiaro. È il momento di massima depressione di Falstaff in uno stato d’animo o posa da
“Monsieur Remorse”, in questo breve e quasi sinistro episodio. Incomprensibili le obiezioni dei critici
alla momentanea e ricorrente resipiscenza di Falstaff. Drammaticamente magnifica l’entrata di
monna Spiccia e stupenda la battuta di Falstaff che chiude la scena.
40 ATTO V Magnifica sezione finale dell’opera, ammirevole per la modulazione “aristofanesca” dei toni
dal realismo comico e farsesco al fantastico, al grottesco, al cerimoniale e rituale, al realistico ironico
e convenzionale della fine. I due intrighi rimanenti (il primo e il secondo) vi trovano soluzione in una
sorta di agnizione comica; Falstaff è smascherato come imbroglione, le fate si rivelano come
finzione windsoriana, Anna Page è accettata come sposa di Fenton. Sul piano dell’azione esterna si
giunge al trionfo definitivo del mondo di Windsor e alla sconfitta dell’individualismo amoralistico di
Falstaff. Boito-Verdi ne fanno una “sconfitta” dell’eroe comico romantico, portatore dei valori
dell’anarchismo, della critica ai falsi valori stabiliti, del principio dell’ironia, del riso e della beffa come
sale della vita, principio che è visto nel cuore stesso dell’Essere. Una tale “vittoria” dell’ironia
romantica non esiste naturalmente in Shakespeare. Durante quest’ultimo atto Falstaff è in realtà
privo di ironia, fa nella prima scena dei drammatici e mesti pronunciamenti su se stesso, sulla
fortuna e sulla vita, passa poi dall’eccitazione all’esaltazione sensuale e all’entusiastica illusione di
avere sedotto le due donne e di esser sul punto di godersele come amanti, poi sprofonda nella
coscienza dello scacco e nella paura dell’imprevisto irrazionale, non senza qualche mesta
sopravvivenza di scetticismo, e soprattutto nella stanchezza senile e nell’accettazione della sconfitta
e di una umiliante cooptazione. La sua è una simbolica repressione con connotazioni sacrificali. Nella
prima scena, Falstaff congeda la messaggera e fa a messer Rivoletto un’esilarante relazione del suo
ultimo scacco, ma velata di mesta consapevolezza. Poi comincia la festa delle beffe, e Falstaff vi
modifica rapidamente il suo stato d’animo: conquistato da Eros, deluso e trasecolato e impaurito,
ma fino a un certo punto, poi rassegnato ma pronto forse a recitare un nuovo ruolo di pentito e di
simbolico “sacrificato”, stracco e insieme capace di qualche lucida frecciata.
41 V, i, 2 È una credenza proverbiale, e in origine una tradizione pitagorica, che i numeri dispari siano
superiori ai pari e portatori di fortuna, o comunque connessi al destino di una persona. Falstaff,
come dirà a Rivoletto, ha delle premonizioni sulle “cose meravigliose” che avverranno nella foresta.
42 V, i, 21 because I know also life is a shuttle. Falstaff cita dalla Bibbia “autorizzata”, aggiungendo qui
alla reminiscenza da Samuele (la trave del tessitore è il subbio del telaio) un’altra sua memoria di
Giobbe, 7, 6: “I miei giorni passano più rapidi della spola d’un tessitore”.