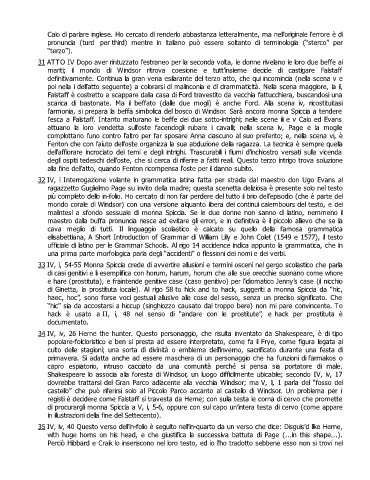Page 2573 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2573
Caio di parlare inglese. Ho cercato di renderlo abbastanza letteralmente, ma nell’originale l’errore è di
pronuncia (turd per third) mentre in italiano può essere soltanto di terminologia (“sterco” per
“terzo”).
31 ATTO IV Dopo aver rintuzzato l’estraneo per la seconda volta, le donne rivelano le loro due beffe ai
mariti; il mondo di Windsor ritrova coesione e tutt’insieme decide di castigare Falstaff
definitivamente. Continua la gran vena esilarante del terzo atto, che qui incomincia (nella scena v e
poi nella i dell’atto seguente) a colorarsi di malinconia e di drammaticità. Nella scena maggiore, la ii,
Falstaff è costretto a scappare dalla casa di Ford travestito da vecchia fattucchiera, buscandosi una
scarica di bastonate. Ma il beffato (dalle due mogli) è anche Ford. Alla scena iv, ricostituitasi
l’armonia, si prepara la beffa simbolica del bosco di Windsor. Sarà ancora monna Spiccia a tendere
l’esca a Falstaff. Intanto maturano le beffe dei due sotto-intrighi; nelle scene iii e v Caio ed Evans
attuano la loro vendetta sull’oste facendogli rubare i cavalli; nella scena iv, Page e la moglie
complottano l’uno contro l’altro per far sposare Anna ciascuno al suo preferito; e, nella scena vi, è
Fenton che con l’aiuto dell’oste organizza la sua abduzione della ragazza. La tecnica è sempre quella
dell’affiorare incrociato dei temi e degli intrighi. Trascurabili i fiumi d’inchiostro versati sulla vicenda
degli ospiti tedeschi dell’oste, che si cerca di riferire a fatti reali. Questo terzo intrigo trova soluzione
alla fine dell’atto, quando Fenton ricompensa l’oste per il danno subito.
32 IV, i Interrogazione volante in grammatica latina fatta per strada dal maestro don Ugo Evans al
ragazzetto Guglielmo Page su invito della madre; questa scenetta deliziosa è presente solo nel testo
più completo dello in-folio. Ho cercato di non far perdere del tutto il brio dell’episodio (che è parte del
mondo corale di Windsor) con una versione alquanto libera dei continui calembours del testo, e dei
malintesi a sfondo sessuale di monna Spiccia. Se le due donne non sanno di latino, nemmeno il
maestro dalla buffa pronuncia riesce ad evitare gli errori, e in definitiva è il piccolo allievo che se la
cava meglio di tutti. Il linguaggio scolastico è calcato su quello della famosa grammatica
elisabettiana, A Short Introduction of Grammar di William Lilly e John Colet (1549 e 1577), il testo
ufficiale di latino per le Grammar Schools. Al rigo 14 accidence indica appunto la grammatica, che in
una prima parte morfologica parla degli “accidenti” o flessioni dei nomi e dei verbi.
33 IV, i, 54-55 Monna Spiccia crede di avvertire allusioni e termini osceni nel gergo scolastico che parla
di casi genitivi e li esemplifica con horum, harum, horum che alle sue orecchie suonano come whore
e hare (prostituta), e fraintende genitive case (caso genitivo) per l’idiomatico Jenny’s case (il nicchio
di Ginetta, la prostituta locale). Al rigo 58 to hick and to hack, suggeriti a monna Spiccia da “hic,
haec, hoc”, sono forse voci gestuali allusive alle cose del sesso, senza un preciso significato. Che
“hic” sia da accostarsi a hiccup (singhiozzo causato dal troppo bere) non mi pare convincente. To
hack è usato a II, i, 48 nel senso di “andare con le prostitute”, e hack per prostituta è
documentato.
34 IV, iv, 26 Herne the hunter. Questo personaggio, che risulta inventato da Shakespeare, è di tipo
popolare-folcloristico e ben si presta ad essere interpretato, come fa il Frye, come figura legata al
culto delle stagioni; una sorta di divinità o emblema dell’inverno, sacrificato durante una festa di
primavera. Si adatta anche ad essere maschera di un personaggio che ha funzioni di farmakos o
capro espiatorio, intruso cacciato da una comunità perché si pensa sia portatore di male.
Shakespeare lo associa alla foresta di Windsor, un luogo difficilmente ubicabile; secondo IV, iv, 17
dovrebbe trattarsi del Gran Parco adiacente alla vecchia Windsor; ma V, ii, 1 parla del “fosso del
castello” che può riferirsi solo al Piccolo Parco accanto al castello di Windsor. Un problema per i
registi è decidere come Falstaff si travesta da Herne; con sulla testa le corna di cervo che promette
di procurargli monna Spiccia a V, i, 5-6, oppure con sul capo un’intera testa di cervo (come appare
in illustrazioni della fine del Settecento).
35 IV, iv, 40 Questo verso dell’in-folio è seguito nell’in-quarto da un verso che dice: Disguis’d like Herne,
with huge horns on his head, e che giustifica la successiva battuta di Page (...in this shape...).
Perciò Hibbard e Craik lo inseriscono nel loro testo, ed io l’ho tradotto sebbene esso non si trovi nel