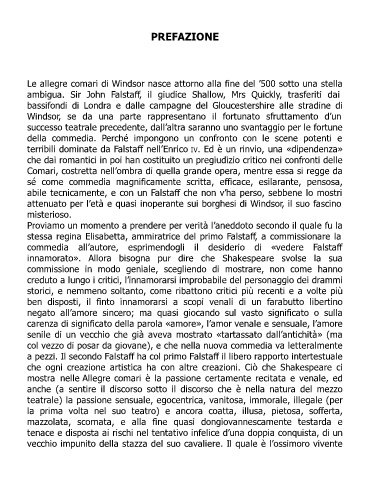Page 2295 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2295
PREFAZIONE
Le allegre comari di Windsor nasce attorno alla fine del ’500 sotto una stella
ambigua. Sir John Falstaff, il giudice Shallow, Mrs Quickly, trasferiti dai
bassifondi di Londra e dalle campagne del Gloucestershire alle stradine di
Windsor, se da una parte rappresentano il fortunato sfruttamento d’un
successo teatrale precedente, dall’altra saranno uno svantaggio per le fortune
della commedia. Perché impongono un confronto con le scene potenti e
terribili dominate da Falstaff nell’Enrico IV. Ed è un rinvio, una «dipendenza»
che dai romantici in poi han costituito un pregiudizio critico nei confronti delle
Comari, costretta nell’ombra di quella grande opera, mentre essa si regge da
sé come commedia magnificamente scritta, efficace, esilarante, pensosa,
abile tecnicamente, e con un Falstaff che non v’ha perso, sebbene lo mostri
attenuato per l’età e quasi inoperante sui borghesi di Windsor, il suo fascino
misterioso.
Proviamo un momento a prendere per verità l’aneddoto secondo il quale fu la
stessa regina Elisabetta, ammiratrice del primo Falstaff, a commissionare la
commedia all’autore, esprimendogli il desiderio di «vedere Falstaff
innamorato». Allora bisogna pur dire che Shakespeare svolse la sua
commissione in modo geniale, scegliendo di mostrare, non come hanno
creduto a lungo i critici, l’innamorarsi improbabile del personaggio dei drammi
storici, e nemmeno soltanto, come ribattono critici più recenti e a volte più
ben disposti, il finto innamorarsi a scopi venali di un farabutto libertino
negato all’amore sincero; ma quasi giocando sul vasto significato o sulla
carenza di significato della parola «amore», l’amor venale e sensuale, l’amore
senile di un vecchio che già aveva mostrato «tartassato dall’antichità» (ma
col vezzo di posar da giovane), e che nella nuova commedia va letteralmente
a pezzi. Il secondo Falstaff ha col primo Falstaff il libero rapporto intertestuale
che ogni creazione artistica ha con altre creazioni. Ciò che Shakespeare ci
mostra nelle Allegre comari è la passione certamente recitata e venale, ed
anche (a sentire il discorso sotto il discorso che è nella natura del mezzo
teatrale) la passione sensuale, egocentrica, vanitosa, immorale, illegale (per
la prima volta nel suo teatro) e ancora coatta, illusa, pietosa, sofferta,
mazzolata, scornata, e alla fine quasi dongiovannescamente testarda e
tenace e disposta ai rischi nel tentativo infelice d’una doppia conquista, di un
vecchio impunito della stazza del suo cavaliere. Il quale è l’ossimoro vivente