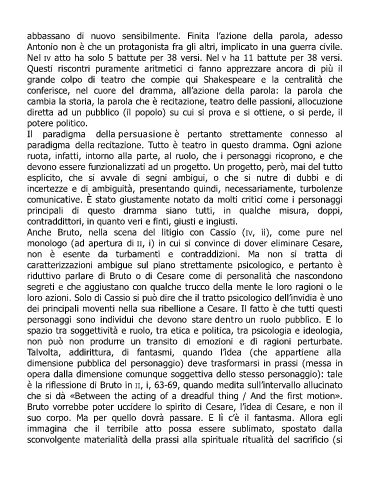Page 2020 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2020
abbassano di nuovo sensibilmente. Finita l’azione della parola, adesso
Antonio non è che un protagonista fra gli altri, implicato in una guerra civile.
Nel IV atto ha solo 5 battute per 38 versi. Nel V ha 11 battute per 38 versi.
Questi riscontri puramente aritmetici ci fanno apprezzare ancora di più il
grande colpo di teatro che compie qui Shakespeare e la centralità che
conferisce, nel cuore del dramma, all’azione della parola: la parola che
cambia la storia, la parola che è recitazione, teatro delle passioni, allocuzione
diretta ad un pubblico (il popolo) su cui si prova e si ottiene, o si perde, il
potere politico.
Il paradigma della persuasione è pertanto strettamente connesso al
paradigma della recitazione. Tutto è teatro in questo dramma. Ogni azione
ruota, infatti, intorno alla parte, al ruolo, che i personaggi ricoprono, e che
devono essere funzionalizzati ad un progetto. Un progetto, però, mai del tutto
esplicito, che si avvale di segni ambigui, o che si nutre di dubbi e di
incertezze e di ambiguità, presentando quindi, necessariamente, turbolenze
comunicative. È stato giustamente notato da molti critici come i personaggi
principali di questo dramma siano tutti, in qualche misura, doppi,
contraddittori, in quanto veri e finti, giusti e ingiusti.
Anche Bruto, nella scena del litigio con Cassio (IV, ii), come pure nel
monologo (ad apertura di II, i) in cui si convince di dover eliminare Cesare,
non è esente da turbamenti e contraddizioni. Ma non si tratta di
caratterizzazioni ambigue sul piano strettamente psicologico, e pertanto è
riduttivo parlare di Bruto o di Cesare come di personalità che nascondono
segreti e che aggiustano con qualche trucco della mente le loro ragioni o le
loro azioni. Solo di Cassio si può dire che il tratto psicologico dell’invidia è uno
dei principali moventi nella sua ribellione a Cesare. Il fatto è che tutti questi
personaggi sono individui che devono stare dentro un ruolo pubblico. E lo
spazio tra soggettività e ruolo, tra etica e politica, tra psicologia e ideologia,
non può non produrre un transito di emozioni e di ragioni perturbate.
Talvolta, addirittura, di fantasmi, quando l’idea (che appartiene alla
dimensione pubblica del personaggio) deve trasformarsi in prassi (messa in
opera dalla dimensione comunque soggettiva dello stesso personaggio): tale
è la riflessione di Bruto in II, i, 63-69, quando medita sull’intervallo allucinato
che si dà «Between the acting of a dreadful thing / And the first motion».
Bruto vorrebbe poter uccidere lo spirito di Cesare, l’idea di Cesare, e non il
suo corpo. Ma per quello dovrà passare. E lì c’è il fantasma. Allora egli
immagina che il terribile atto possa essere sublimato, spostato dalla
sconvolgente materialità della prassi alla spirituale ritualità del sacrificio (si