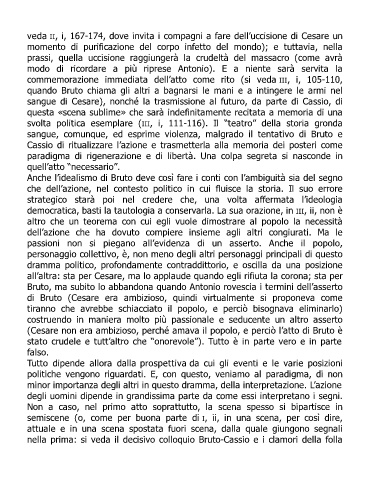Page 2021 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2021
veda II, i, 167-174, dove invita i compagni a fare dell’uccisione di Cesare un
momento di purificazione del corpo infetto del mondo); e tuttavia, nella
prassi, quella uccisione raggiungerà la crudeltà del massacro (come avrà
modo di ricordare a più riprese Antonio). E a niente sarà servita la
commemorazione immediata dell’atto come rito (si veda III, i, 105-110,
quando Bruto chiama gli altri a bagnarsi le mani e a intingere le armi nel
sangue di Cesare), nonché la trasmissione al futuro, da parte di Cassio, di
questa «scena sublime» che sarà indefinitamente recitata a memoria di una
svolta politica esemplare (III, i, 111-116). Il “teatro” della storia gronda
sangue, comunque, ed esprime violenza, malgrado il tentativo di Bruto e
Cassio di ritualizzare l’azione e trasmetterla alla memoria dei posteri come
paradigma di rigenerazione e di libertà. Una colpa segreta si nasconde in
quell’atto “necessario”.
Anche l’idealismo di Bruto deve così fare i conti con l’ambiguità sia del segno
che dell’azione, nel contesto politico in cui fluisce la storia. Il suo errore
strategico starà poi nel credere che, una volta affermata l’ideologia
democratica, basti la tautologia a conservarla. La sua orazione, in III, ii, non è
altro che un teorema con cui egli vuole dimostrare al popolo la necessità
dell’azione che ha dovuto compiere insieme agli altri congiurati. Ma le
passioni non si piegano all’evidenza di un asserto. Anche il popolo,
personaggio collettivo, è, non meno degli altri personaggi principali di questo
dramma politico, profondamente contraddittorio, e oscilla da una posizione
all’altra: sta per Cesare, ma lo applaude quando egli rifiuta la corona; sta per
Bruto, ma subito lo abbandona quando Antonio rovescia i termini dell’asserto
di Bruto (Cesare era ambizioso, quindi virtualmente si proponeva come
tiranno che avrebbe schiacciato il popolo, e perciò bisognava eliminarlo)
costruendo in maniera molto più passionale e seducente un altro asserto
(Cesare non era ambizioso, perché amava il popolo, e perciò l’atto di Bruto è
stato crudele e tutt’altro che “onorevole”). Tutto è in parte vero e in parte
falso.
Tutto dipende allora dalla prospettiva da cui gli eventi e le varie posizioni
politiche vengono riguardati. E, con questo, veniamo al paradigma, di non
minor importanza degli altri in questo dramma, della interpretazione. L’azione
degli uomini dipende in grandissima parte da come essi interpretano i segni.
Non a caso, nel primo atto soprattutto, la scena spesso si bipartisce in
semiscene (o, come per buona parte di I, ii, in una scena, per così dire,
attuale e in una scena spostata fuori scena, dalla quale giungono segnali
nella prima: si veda il decisivo colloquio Bruto-Cassio e i clamori della folla