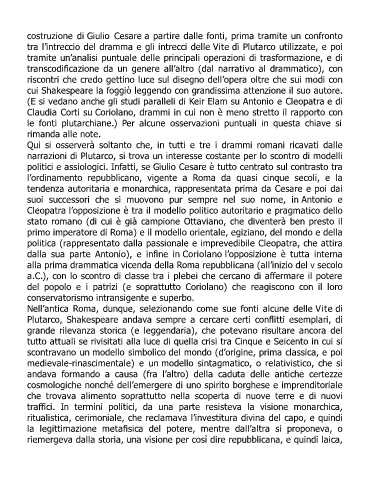Page 2015 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2015
costruzione di Giulio Cesare a partire dalle fonti, prima tramite un confronto
tra l’intreccio del dramma e gli intrecci delle Vite di Plutarco utilizzate, e poi
tramite un’analisi puntuale delle principali operazioni di trasformazione, e di
transcodificazione da un genere all’altro (dal narrativo al drammatico), con
riscontri che credo gettino luce sul disegno dell’opera oltre che sui modi con
cui Shakespeare la foggiò leggendo con grandissima attenzione il suo autore.
(E si vedano anche gli studi paralleli di Keir Elam su Antonio e Cleopatra e di
Claudia Corti su Coriolano, drammi in cui non è meno stretto il rapporto con
le fonti plutarchiane.) Per alcune osservazioni puntuali in questa chiave si
rimanda alle note.
Qui si osserverà soltanto che, in tutti e tre i drammi romani ricavati dalle
narrazioni di Plutarco, si trova un interesse costante per lo scontro di modelli
politici e assiologici. Infatti, se Giulio Cesare è tutto centrato sul contrasto tra
l’ordinamento repubblicano, vigente a Roma da quasi cinque secoli, e la
tendenza autoritaria e monarchica, rappresentata prima da Cesare e poi dai
suoi successori che si muovono pur sempre nel suo nome, in Antonio e
Cleopatra l’opposizione è tra il modello politico autoritario e pragmatico dello
stato romano (di cui è già campione Ottaviano, che diventerà ben presto il
primo imperatore di Roma) e il modello orientale, egiziano, del mondo e della
politica (rappresentato dalla passionale e imprevedibile Cleopatra, che attira
dalla sua parte Antonio), e infine in Coriolano l’opposizione è tutta interna
alla prima drammatica vicenda della Roma repubblicana (all’inizio del V secolo
a.C.), con lo scontro di classe tra i plebei che cercano di affermare il potere
del popolo e i patrizi (e soprattutto Coriolano) che reagiscono con il loro
conservatorismo intransigente e superbo.
Nell’antica Roma, dunque, selezionando come sue fonti alcune delle Vite di
Plutarco, Shakespeare andava sempre a cercare certi conflitti esemplari, di
grande rilevanza storica (e leggendaria), che potevano risultare ancora del
tutto attuali se rivisitati alla luce di quella crisi tra Cinque e Seicento in cui si
scontravano un modello simbolico del mondo (d’origine, prima classica, e poi
medievale-rinascimentale) e un modello sintagmatico, o relativistico, che si
andava formando a causa (fra l’altro) della caduta delle antiche certezze
cosmologiche nonché dell’emergere di uno spirito borghese e imprenditoriale
che trovava alimento soprattutto nella scoperta di nuove terre e di nuovi
traffici. In termini politici, da una parte resisteva la visione monarchica,
ritualistica, cerimoniale, che reclamava l’investitura divina del capo, e quindi
la legittimazione metafisica del potere, mentre dall’altra si proponeva, o
riemergeva dalla storia, una visione per così dire repubblicana, e quindi laica,