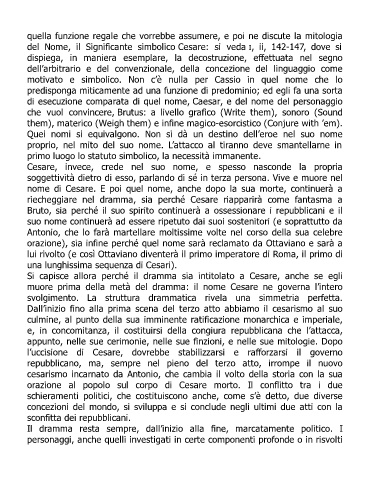Page 2017 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2017
quella funzione regale che vorrebbe assumere, e poi ne discute la mitologia
del Nome, il Significante simbolico Cesare: si veda I, ii, 142-147, dove si
dispiega, in maniera esemplare, la decostruzione, effettuata nel segno
dell’arbitrario e del convenzionale, della concezione del linguaggio come
motivato e simbolico. Non c’è nulla per Cassio in quel nome che lo
predisponga miticamente ad una funzione di predominio; ed egli fa una sorta
di esecuzione comparata di quel nome, Caesar, e del nome del personaggio
che vuol convincere, Brutus: a livello grafico (Write them), sonoro (Sound
them), materico (Weigh them) e infine magico-esorcistico (Conjure with ’em).
Quei nomi si equivalgono. Non si dà un destino dell’eroe nel suo nome
proprio, nel mito del suo nome. L’attacco al tiranno deve smantellarne in
primo luogo lo statuto simbolico, la necessità immanente.
Cesare, invece, crede nel suo nome, e spesso nasconde la propria
soggettività dietro di esso, parlando di sé in terza persona. Vive e muore nel
nome di Cesare. E poi quel nome, anche dopo la sua morte, continuerà a
riecheggiare nel dramma, sia perché Cesare riapparirà come fantasma a
Bruto, sia perché il suo spirito continuerà a ossessionare i repubblicani e il
suo nome continuerà ad essere ripetuto dai suoi sostenitori (e soprattutto da
Antonio, che lo farà martellare moltissime volte nel corso della sua celebre
orazione), sia infine perché quel nome sarà reclamato da Ottaviano e sarà a
lui rivolto (e così Ottaviano diventerà il primo imperatore di Roma, il primo di
una lunghissima sequenza di Cesari).
Si capisce allora perché il dramma sia intitolato a Cesare, anche se egli
muore prima della metà del dramma: il nome Cesare ne governa l’intero
svolgimento. La struttura drammatica rivela una simmetria perfetta.
Dall’inizio fino alla prima scena del terzo atto abbiamo il cesarismo al suo
culmine, al punto della sua imminente ratificazione monarchica e imperiale,
e, in concomitanza, il costituirsi della congiura repubblicana che l’attacca,
appunto, nelle sue cerimonie, nelle sue finzioni, e nelle sue mitologie. Dopo
l’uccisione di Cesare, dovrebbe stabilizzarsi e rafforzarsi il governo
repubblicano, ma, sempre nel pieno del terzo atto, irrompe il nuovo
cesarismo incarnato da Antonio, che cambia il volto della storia con la sua
orazione al popolo sul corpo di Cesare morto. Il conflitto tra i due
schieramenti politici, che costituiscono anche, come s’è detto, due diverse
concezioni del mondo, si sviluppa e si conclude negli ultimi due atti con la
sconfitta dei repubblicani.
Il dramma resta sempre, dall’inizio alla fine, marcatamente politico. I
personaggi, anche quelli investigati in certe componenti profonde o in risvolti