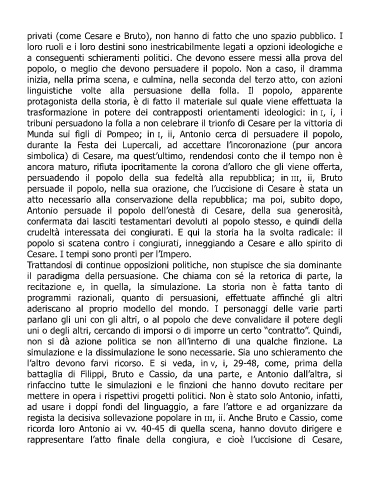Page 2018 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2018
privati (come Cesare e Bruto), non hanno di fatto che uno spazio pubblico. I
loro ruoli e i loro destini sono inestricabilmente legati a opzioni ideologiche e
a conseguenti schieramenti politici. Che devono essere messi alla prova del
popolo, o meglio che devono persuadere il popolo. Non a caso, il dramma
inizia, nella prima scena, e culmina, nella seconda del terzo atto, con azioni
linguistiche volte alla persuasione della folla. Il popolo, apparente
protagonista della storia, è di fatto il materiale sul quale viene effettuata la
trasformazione in potere dei contrapposti orientamenti ideologici: in I, i, i
tribuni persuadono la folla a non celebrare il trionfo di Cesare per la vittoria di
Munda sui figli di Pompeo; in I, ii, Antonio cerca di persuadere il popolo,
durante la Festa dei Lupercali, ad accettare l’incoronazione (pur ancora
simbolica) di Cesare, ma quest’ultimo, rendendosi conto che il tempo non è
ancora maturo, rifiuta ipocritamente la corona d’alloro che gli viene offerta,
persuadendo il popolo della sua fedeltà alla repubblica; in III, ii, Bruto
persuade il popolo, nella sua orazione, che l’uccisione di Cesare è stata un
atto necessario alla conservazione della repubblica; ma poi, subito dopo,
Antonio persuade il popolo dell’onestà di Cesare, della sua generosità,
confermata dai lasciti testamentari devoluti al popolo stesso, e quindi della
crudeltà interessata dei congiurati. E qui la storia ha la svolta radicale: il
popolo si scatena contro i congiurati, inneggiando a Cesare e allo spirito di
Cesare. I tempi sono pronti per l’Impero.
Trattandosi di continue opposizioni politiche, non stupisce che sia dominante
il paradigma della persuasione. Che chiama con sé la retorica di parte, la
recitazione e, in quella, la simulazione. La storia non è fatta tanto di
programmi razionali, quanto di persuasioni, effettuate affinché gli altri
aderiscano al proprio modello del mondo. I personaggi delle varie parti
parlano gli uni con gli altri, o al popolo che deve convalidare il potere degli
uni o degli altri, cercando di imporsi o di imporre un certo “contratto”. Quindi,
non si dà azione politica se non all’interno di una qualche finzione. La
simulazione e la dissimulazione le sono necessarie. Sia uno schieramento che
l’altro devono farvi ricorso. E si veda, in V, i, 29-48, come, prima della
battaglia di Filippi, Bruto e Cassio, da una parte, e Antonio dall’altra, si
rinfaccino tutte le simulazioni e le finzioni che hanno dovuto recitare per
mettere in opera i rispettivi progetti politici. Non è stato solo Antonio, infatti,
ad usare i doppi fondi del linguaggio, a fare l’attore e ad organizzare da
regista la decisiva sollevazione popolare in III, ii. Anche Bruto e Cassio, come
ricorda loro Antonio ai vv. 40-45 di quella scena, hanno dovuto dirigere e
rappresentare l’atto finale della congiura, e cioè l’uccisione di Cesare,