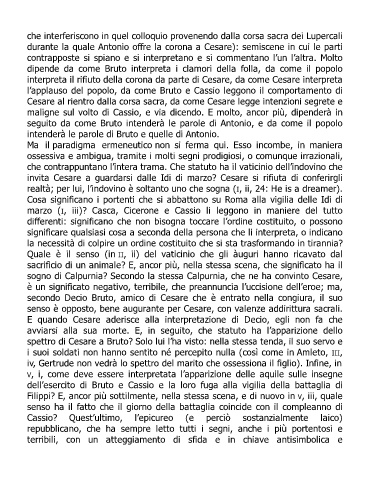Page 2022 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2022
che interferiscono in quel colloquio provenendo dalla corsa sacra dei Lupercali
durante la quale Antonio offre la corona a Cesare): semiscene in cui le parti
contrapposte si spiano e si interpretano e si commentano l’un l’altra. Molto
dipende da come Bruto interpreta i clamori della folla, da come il popolo
interpreta il rifiuto della corona da parte di Cesare, da come Cesare interpreta
l’applauso del popolo, da come Bruto e Cassio leggono il comportamento di
Cesare al rientro dalla corsa sacra, da come Cesare legge intenzioni segrete e
maligne sul volto di Cassio, e via dicendo. E molto, ancor più, dipenderà in
seguito da come Bruto intenderà le parole di Antonio, e da come il popolo
intenderà le parole di Bruto e quelle di Antonio.
Ma il paradigma ermeneutico non si ferma qui. Esso incombe, in maniera
ossessiva e ambigua, tramite i molti segni prodigiosi, o comunque irrazionali,
che contrappuntano l’intera trama. Che statuto ha il vaticinio dell’indovino che
invita Cesare a guardarsi dalle Idi di marzo? Cesare si rifiuta di conferirgli
realtà; per lui, l’indovino è soltanto uno che sogna (I, ii, 24: He is a dreamer).
Cosa significano i portenti che si abbattono su Roma alla vigilia delle Idi di
marzo (I, iii)? Casca, Cicerone e Cassio li leggono in maniere del tutto
differenti: significano che non bisogna toccare l’ordine costituito, o possono
significare qualsiasi cosa a seconda della persona che li interpreta, o indicano
la necessità di colpire un ordine costituito che si sta trasformando in tirannia?
Quale è il senso (in II, ii) del vaticinio che gli àuguri hanno ricavato dal
sacrificio di un animale? E, ancor più, nella stessa scena, che significato ha il
sogno di Calpurnia? Secondo la stessa Calpurnia, che ne ha convinto Cesare,
è un significato negativo, terribile, che preannuncia l’uccisione dell’eroe; ma,
secondo Decio Bruto, amico di Cesare che è entrato nella congiura, il suo
senso è opposto, bene augurante per Cesare, con valenze addirittura sacrali.
E quando Cesare aderisce alla interpretazione di Decio, egli non fa che
avviarsi alla sua morte. E, in seguito, che statuto ha l’apparizione dello
spettro di Cesare a Bruto? Solo lui l’ha visto: nella stessa tenda, il suo servo e
i suoi soldati non hanno sentito né percepito nulla (così come in Amleto, III,
iv, Gertrude non vedrà lo spettro del marito che ossessiona il figlio). Infine, in
V, i, come deve essere interpretata l’apparizione delle aquile sulle insegne
dell’esercito di Bruto e Cassio e la loro fuga alla vigilia della battaglia di
Filippi? E, ancor più sottilmente, nella stessa scena, e di nuovo in V, iii, quale
senso ha il fatto che il giorno della battaglia coincide con il compleanno di
Cassio? Quest’ultimo, l’epicureo (e perciò sostanzialmente laico)
repubblicano, che ha sempre letto tutti i segni, anche i più portentosi e
terribili, con un atteggiamento di sfida e in chiave antisimbolica e