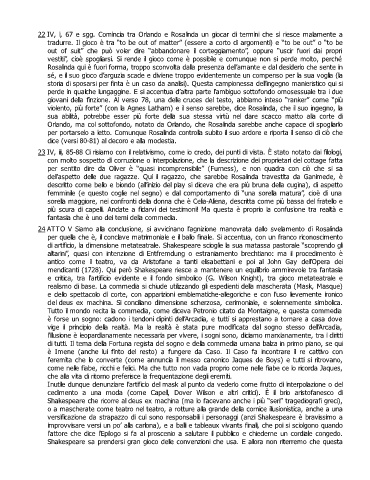Page 2011 - Shakespeare - Vol. 2
P. 2011
22 IV, i, 67 e sgg. Comincia tra Orlando e Rosalinda un giocar di termini che si riesce malamente a
tradurre. Il gioco è tra “to be out of matter” (essere a corto di argomenti) e “to be out” o “to be
out of suit” che può voler dire “abbandonare il corteggiamento”, oppure “uscir fuori dai propri
vestiti”, cioè spogliarsi. Si rende il gioco come è possibile e comunque non si perde molto, perché
Rosalinda qui è fuori forma, troppo sconvolta dalla presenza dell’amante e dal desiderio che sente in
sé, e il suo gioco d’arguzia scade e diviene troppo evidentemente un compenso per la sua voglia (la
storia di sposarsi per finta è un caso da analisi). Questa campionessa dell’ingegno manieristico qui si
perde in qualche lungaggine. E si accentua d’altra parte l’ambiguo sottofondo omosessuale tra i due
giovani della finzione. Al verso 78, una delle cruces del testo, abbiamo inteso “ranker” come “più
violento, più forte” (con la Agnes Latham) e il senso sarebbe, dice Rosalinda, che il suo ingegno, la
sua abilità, potrebbe esser più forte della sua stessa virtù nel dare scacco matto alla corte di
Orlando, ma col sottofondo, notato da Orlando, che Rosalinda sarebbe anche capace di spogliarlo
per portarselo a letto. Comunque Rosalinda controlla subito il suo ardore e riporta il senso di ciò che
dice (versi 80-81) al decoro e alla modestia.
23 IV, iii, 85-88 Ci risiamo con il relativismo, come io credo, dei punti di vista. È stato notato dai filologi,
con molto sospetto di corruzione o interpolazione, che la descrizione dei proprietari del cottage fatta
per sentito dire da Oliver è “quasi incomprensibile” (Furness), e non quadra con ciò che si sa
dell’aspetto delle due ragazze. Qui il ragazzo, che sarebbe Rosalinda travestita da Ganimede, è
descritto come bello e biondo (all’inizio del play si diceva che era più bruna della cugina), di aspetto
femminile (e questo coglie nel segno) e dal comportamento di “una sorella matura”, cioè di una
sorella maggiore, nei confronti della donna che è Celia-Aliena, descritta come più bassa del fratello e
più scura di capelli. Andate a fidarvi dei testimoni! Ma questa è proprio la confusione tra realtà e
fantasia che è uno dei temi della commedia.
24 ATTO V Siamo alla conclusione, si avvicinano l’agnizione manovrata dallo svelamento di Rosalinda
per quella che è, il conclave matrimoniale e il ballo finale. Si accentua, con un franco riconoscimento
di artificio, la dimensione metateatrale. Shakespeare scioglie la sua matassa pastorale “scoprendo gli
altarini”, quasi con intenzione di Entfremdung o estraniamento brechtiano: ma il procedimento è
antico come il teatro, va da Aristofane a tanti elisabettiani e poi al John Gay dell’Opera dei
mendicanti (1728). Qui però Shakespeare riesce a mantenere un equilibrio ammirevole tra fantasia
e critica, tra l’artificio evidente e il fondo simbolico (G. Wilson Knight), tra gioco metateatrale e
realismo di base. La commedia si chiude utilizzando gli espedienti della mascherata (Mask, Masque)
e dello spettacolo di corte, con apparizioni emblematiche-allegoriche e con l’uso lievemente ironico
del deus ex machina. Si conciliano dimensione scherzosa, cerimoniale, e solennemente simbolica.
Tutto il mondo recita la commedia, come diceva Petronio citato da Montaigne, e questa commedia
è forse un sogno: cadono i tendoni dipinti dell’Arcadia, e tutti si apprestano a tornare a casa dove
vige il principio della realtà. Ma la realtà è stata pure modificata dal sogno stesso dell’Arcadia,
l’illusione è leopardianamente necessaria per vivere, i sogni sono, diciamo marxianamente, tra i diritti
di tutti. Il tema della Fortuna regista del sogno e della commedia umana balza in primo piano, se qui
è Imene (anche lui finto del resto) a fungere da Caso. Il Caso fa incontrare il re cattivo con
l’eremita che lo converte (come annuncia il messo canonico Jaques de Boys) e tutti si ritrovano,
come nelle fiabe, ricchi e felici. Ma che tutto non vada proprio come nelle fiabe ce lo ricorda Jaques,
che alla vita di ritorno preferisce la frequentazione degli eremiti.
Inutile dunque denunziare l’artificio del mask al punto da vederlo come frutto di interpolazione o del
cedimento a una moda (come Capell, Dover Wilson e altri critici). È il brio aristofanesco di
Shakespeare che ricorre al deus ex machina (ma lo facevano anche i più “seri” tragediografi greci),
o a mascherate come teatro nel teatro, a rotture alla grande della cornice illusionistica, anche a una
versificazione da strapazzo di cui sono responsabili i personaggi (anzi Shakespeare è bravissimo a
improvvisare versi un po’ alla carlona), e a balli e tableaux vivants finali, che poi si sciolgono quando
l’attore che dice l’Epilogo si fa al proscenio a salutare il pubblico e chiederne un cordiale congedo.
Shakespeare sa prendersi gran gioco delle convenzioni che usa. E allora non riterremo che questa