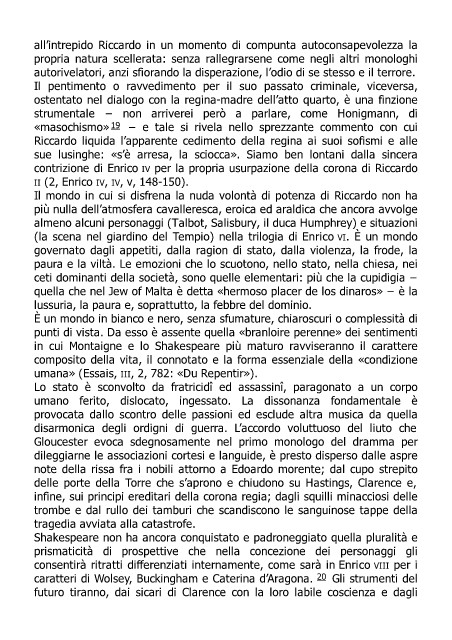Page 930 - Shakespeare - Vol. 1
P. 930
all’intrepido Riccardo in un momento di compunta autoconsapevolezza la
propria natura scellerata: senza rallegrarsene come negli altri monologhi
autorivelatori, anzi sfiorando la disperazione, l’odio di se stesso e il terrore.
Il pentimento o ravvedimento per il suo passato criminale, viceversa,
ostentato nel dialogo con la regina-madre dell’atto quarto, è una finzione
strumentale - non arriverei però a parlare, come Honigmann, di
«masochismo» 19 - e tale si rivela nello sprezzante commento con cui
Riccardo liquida l’apparente cedimento della regina ai suoi sofismi e alle
sue lusinghe: «s’è arresa, la sciocca». Siamo ben lontani dalla sincera
contrizione di Enrico IV per la propria usurpazione della corona di Riccardo
II (2, Enrico IV, IV, v, 148-150).
Il mondo in cui si disfrena la nuda volontà di potenza di Riccardo non ha
più nulla dell’atmosfera cavalleresca, eroica ed araldica che ancora avvolge
almeno alcuni personaggi (Talbot, Salisbury, il duca Humphrey) e situazioni
(la scena nel giardino del Tempio) nella trilogia di Enrico VI. È un mondo
governato dagli appetiti, dalla ragion di stato, dalla violenza, la frode, la
paura e la viltà. Le emozioni che lo scuotono, nello stato, nella chiesa, nei
ceti dominanti della società, sono quelle elementari: più che la cupidigia -
quella che nel Jew of Malta è detta «hermoso placer de los dinaros» - è la
lussuria, la paura e, soprattutto, la febbre del dominio.
È un mondo in bianco e nero, senza sfumature, chiaroscuri o complessità di
punti di vista. Da esso è assente quella «branloire perenne» dei sentimenti
in cui Montaigne e lo Shakespeare più maturo ravviseranno il carattere
composito della vita, il connotato e la forma essenziale della «condizione
umana» (Essais, III, 2, 782: «Du Repentir»).
Lo stato è sconvolto da fratricidî ed assassinî, paragonato a un corpo
umano ferito, dislocato, ingessato. La dissonanza fondamentale è
provocata dallo scontro delle passioni ed esclude altra musica da quella
disarmonica degli ordigni di guerra. L’accordo voluttuoso del liuto che
Gloucester evoca sdegnosamente nel primo monologo del dramma per
dileggiarne le associazioni cortesi e languide, è presto disperso dalle aspre
note della rissa fra i nobili attorno a Edoardo morente; dal cupo strepito
delle porte della Torre che s’aprono e chiudono su Hastings, Clarence e,
infine, sui principi ereditari della corona regia; dagli squilli minacciosi delle
trombe e dal rullo dei tamburi che scandiscono le sanguinose tappe della
tragedia avviata alla catastrofe.
Shakespeare non ha ancora conquistato e padroneggiato quella pluralità e
prismaticità di prospettive che nella concezione dei personaggi gli
consentirà ritratti differenziati internamente, come sarà in Enrico VIII per i
caratteri di Wolsey, Buckingham e Caterina d’Aragona. 20 Gli strumenti del
futuro tiranno, dai sicari di Clarence con la loro labile coscienza e dagli