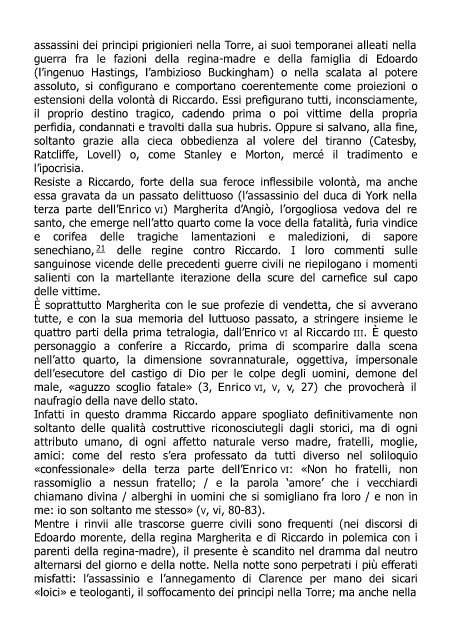Page 931 - Shakespeare - Vol. 1
P. 931
assassini dei principi prigionieri nella Torre, ai suoi temporanei alleati nella
guerra fra le fazioni della regina-madre e della famiglia di Edoardo
(l’ingenuo Hastings, l’ambizioso Buckingham) o nella scalata al potere
assoluto, si configurano e comportano coerentemente come proiezioni o
estensioni della volontà di Riccardo. Essi prefigurano tutti, inconsciamente,
il proprio destino tragico, cadendo prima o poi vittime della propria
perfidia, condannati e travolti dalla sua hubris. Oppure si salvano, alla fine,
soltanto grazie alla cieca obbedienza al volere del tiranno (Catesby,
Ratcliffe, Lovell) o, come Stanley e Morton, mercé il tradimento e
l’ipocrisia.
Resiste a Riccardo, forte della sua feroce inflessibile volontà, ma anche
essa gravata da un passato delittuoso (l’assassinio del duca di York nella
terza parte dell’Enrico VI) Margherita d’Angiò, l’orgogliosa vedova del re
santo, che emerge nell’atto quarto come la voce della fatalità, furia vindice
e corifea delle tragiche lamentazioni e maledizioni, di sapore
senechiano, 21 delle regine contro Riccardo. I loro commenti sulle
sanguinose vicende delle precedenti guerre civili ne riepilogano i momenti
salienti con la martellante iterazione della scure del carnefice sul capo
delle vittime.
È soprattutto Margherita con le sue profezie di vendetta, che si avverano
tutte, e con la sua memoria del luttuoso passato, a stringere insieme le
quattro parti della prima tetralogia, dall’Enrico VI al Riccardo III. È questo
personaggio a conferire a Riccardo, prima di scomparire dalla scena
nell’atto quarto, la dimensione sovrannaturale, oggettiva, impersonale
dell’esecutore del castigo di Dio per le colpe degli uomini, demone del
male, «aguzzo scoglio fatale» (3, Enrico VI, V, v, 27) che provocherà il
naufragio della nave dello stato.
Infatti in questo dramma Riccardo appare spogliato definitivamente non
soltanto delle qualità costruttive riconosciutegli dagli storici, ma di ogni
attributo umano, di ogni affetto naturale verso madre, fratelli, moglie,
amici: come del resto s’era professato da tutti diverso nel soliloquio
«confessionale» della terza parte dell’Enrico VI: «Non ho fratelli, non
rassomiglio a nessun fratello; / e la parola ‘amore’ che i vecchiardi
chiamano divina / alberghi in uomini che si somigliano fra loro / e non in
me: io son soltanto me stesso» (V, vi, 80-83).
Mentre i rinvii alle trascorse guerre civili sono frequenti (nei discorsi di
Edoardo morente, della regina Margherita e di Riccardo in polemica con i
parenti della regina-madre), il presente è scandito nel dramma dal neutro
alternarsi del giorno e della notte. Nella notte sono perpetrati i più efferati
misfatti: l’assassinio e l’annegamento di Clarence per mano dei sicari
«loici» e teologanti, il soffocamento dei principi nella Torre; ma anche nella