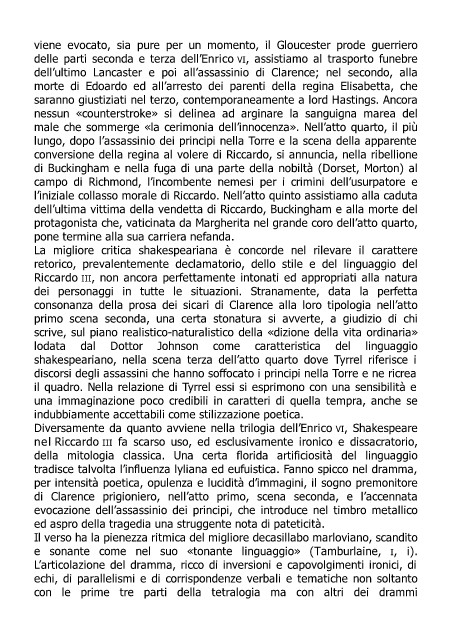Page 933 - Shakespeare - Vol. 1
P. 933
viene evocato, sia pure per un momento, il Gloucester prode guerriero
delle parti seconda e terza dell’Enrico VI, assistiamo al trasporto funebre
dell’ultimo Lancaster e poi all’assassinio di Clarence; nel secondo, alla
morte di Edoardo ed all’arresto dei parenti della regina Elisabetta, che
saranno giustiziati nel terzo, contemporaneamente a lord Hastings. Ancora
nessun «counterstroke» si delinea ad arginare la sanguigna marea del
male che sommerge «la cerimonia dell’innocenza». Nell’atto quarto, il più
lungo, dopo l’assassinio dei principi nella Torre e la scena della apparente
conversione della regina al volere di Riccardo, si annuncia, nella ribellione
di Buckingham e nella fuga di una parte della nobiltà (Dorset, Morton) al
campo di Richmond, l’incombente nemesi per i crimini dell’usurpatore e
l’iniziale collasso morale di Riccardo. Nell’atto quinto assistiamo alla caduta
dell’ultima vittima della vendetta di Riccardo, Buckingham e alla morte del
protagonista che, vaticinata da Margherita nel grande coro dell’atto quarto,
pone termine alla sua carriera nefanda.
La migliore critica shakespeariana è concorde nel rilevare il carattere
retorico, prevalentemente declamatorio, dello stile e del linguaggio del
Riccardo III, non ancora perfettamente intonati ed appropriati alla natura
dei personaggi in tutte le situazioni. Stranamente, data la perfetta
consonanza della prosa dei sicari di Clarence alla loro tipologia nell’atto
primo scena seconda, una certa stonatura si avverte, a giudizio di chi
scrive, sul piano realistico-naturalistico della «dizione della vita ordinaria»
lodata dal Dottor Johnson come caratteristica del linguaggio
shakespeariano, nella scena terza dell’atto quarto dove Tyrrel riferisce i
discorsi degli assassini che hanno soffocato i principi nella Torre e ne ricrea
il quadro. Nella relazione di Tyrrel essi si esprimono con una sensibilità e
una immaginazione poco credibili in caratteri di quella tempra, anche se
indubbiamente accettabili come stilizzazione poetica.
Diversamente da quanto avviene nella trilogia dell’Enrico VI, Shakespeare
ne l Riccardo III fa scarso uso, ed esclusivamente ironico e dissacratorio,
della mitologia classica. Una certa florida artificiosità del linguaggio
tradisce talvolta l’influenza lyliana ed eufuistica. Fanno spicco nel dramma,
per intensità poetica, opulenza e lucidità d’immagini, il sogno premonitore
di Clarence prigioniero, nell’atto primo, scena seconda, e l’accennata
evocazione dell’assassinio dei principi, che introduce nel timbro metallico
ed aspro della tragedia una struggente nota di pateticità.
Il verso ha la pienezza ritmica del migliore decasillabo marloviano, scandito
e sonante come nel suo «tonante linguaggio» (Tamburlaine, I, i).
L’articolazione del dramma, ricco di inversioni e capovolgimenti ironici, di
echi, di parallelismi e di corrispondenze verbali e tematiche non soltanto
con le prime tre parti della tetralogia ma con altri dei drammi