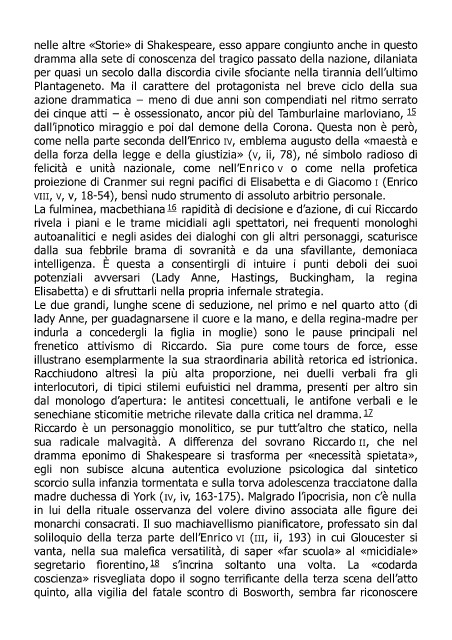Page 929 - Shakespeare - Vol. 1
P. 929
nelle altre «Storie» di Shakespeare, esso appare congiunto anche in questo
dramma alla sete di conoscenza del tragico passato della nazione, dilaniata
per quasi un secolo dalla discordia civile sfociante nella tirannia dell’ultimo
Plantageneto. Ma il carattere del protagonista nel breve ciclo della sua
azione drammatica - meno di due anni son compendiati nel ritmo serrato
dei cinque atti - è ossessionato, ancor più del Tamburlaine marloviano, 15
dall’ipnotico miraggio e poi dal demone della Corona. Questa non è però,
come nella parte seconda dell’Enrico IV, emblema augusto della «maestà e
della forza della legge e della giustizia» (V, ii, 78), né simbolo radioso di
felicità e unità nazionale, come nell’Enri co V o come nella profetica
proiezione di Cranmer sui regni pacifici di Elisabetta e di Giacomo I (Enrico
VIII, V, v, 18-54), bensì nudo strumento di assoluto arbitrio personale.
La fulminea, macbethiana 16 rapidità di decisione e d’azione, di cui Riccardo
rivela i piani e le trame micidiali agli spettatori, nei frequenti monologhi
autoanalitici e negli asides dei dialoghi con gli altri personaggi, scaturisce
dalla sua febbrile brama di sovranità e da una sfavillante, demoniaca
intelligenza. È questa a consentirgli di intuire i punti deboli dei suoi
potenziali avversari (Lady Anne, Hastings, Buckingham, la regina
Elisabetta) e di sfruttarli nella propria infernale strategia.
Le due grandi, lunghe scene di seduzione, nel primo e nel quarto atto (di
lady Anne, per guadagnarsene il cuore e la mano, e della regina-madre per
indurla a concedergli la figlia in moglie) sono le pause principali nel
frenetico attivismo di Riccardo. Sia pure come tours de force, esse
illustrano esemplarmente la sua straordinaria abilità retorica ed istrionica.
Racchiudono altresì la più alta proporzione, nei duelli verbali fra gli
interlocutori, di tipici stilemi eufuistici nel dramma, presenti per altro sin
dal monologo d’apertura: le antitesi concettuali, le antifone verbali e le
senechiane sticomitie metriche rilevate dalla critica nel dramma. 17
Riccardo è un personaggio monolitico, se pur tutt’altro che statico, nella
sua radicale malvagità. A differenza del sovrano Riccardo II, che nel
dramma eponimo di Shakespeare si trasforma per «necessità spietata»,
egli non subisce alcuna autentica evoluzione psicologica dal sintetico
scorcio sulla infanzia tormentata e sulla torva adolescenza tracciatone dalla
madre duchessa di York (IV, iv, 163-175). Malgrado l’ipocrisia, non c’è nulla
in lui della rituale osservanza del volere divino associata alle figure dei
monarchi consacrati. Il suo machiavellismo pianificatore, professato sin dal
soliloquio della terza parte dell’Enrico VI (III, ii, 193) in cui Gloucester si
vanta, nella sua malefica versatilità, di saper «far scuola» al «micidiale»
segretario fiorentino, 18 s’incrina soltanto una volta. La «codarda
coscienza» risvegliata dopo il sogno terrificante della terza scena dell’atto
quinto, alla vigilia del fatale scontro di Bosworth, sembra far riconoscere