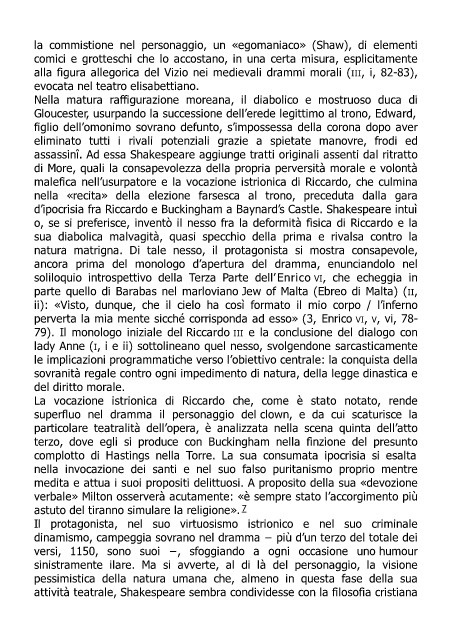Page 927 - Shakespeare - Vol. 1
P. 927
la commistione nel personaggio, un «egomaniaco» (Shaw), di elementi
comici e grotteschi che lo accostano, in una certa misura, esplicitamente
alla figura allegorica del Vizio nei medievali drammi morali (III, i, 82-83),
evocata nel teatro elisabettiano.
Nella matura raffigurazione moreana, il diabolico e mostruoso duca di
Gloucester, usurpando la successione dell’erede legittimo al trono, Edward,
figlio dell’omonimo sovrano defunto, s’impossessa della corona dopo aver
eliminato tutti i rivali potenziali grazie a spietate manovre, frodi ed
assassinî. Ad essa Shakespeare aggiunge tratti originali assenti dal ritratto
di More, quali la consapevolezza della propria perversità morale e volontà
malefica nell’usurpatore e la vocazione istrionica di Riccardo, che culmina
nella «recita» della elezione farsesca al trono, preceduta dalla gara
d’ipocrisia fra Riccardo e Buckingham a Baynard’s Castle. Shakespeare intuì
o, se si preferisce, inventò il nesso fra la deformità fisica di Riccardo e la
sua diabolica malvagità, quasi specchio della prima e rivalsa contro la
natura matrigna. Di tale nesso, il protagonista si mostra consapevole,
ancora prima del monologo d’apertura del dramma, enunciandolo nel
soliloquio introspettivo della Terza Parte dell’ Enrico VI, che echeggia in
parte quello di Barabas nel marloviano Jew of Malta (Ebreo di Malta) (II,
ii): «Visto, dunque, che il cielo ha così formato il mio corpo / l’inferno
perverta la mia mente sicché corrisponda ad esso» (3, Enrico VI, V, vi, 78-
79). Il monologo iniziale del Riccardo III e la conclusione del dialogo con
lady Anne (I, i e ii) sottolineano quel nesso, svolgendone sarcasticamente
le implicazioni programmatiche verso l’obiettivo centrale: la conquista della
sovranità regale contro ogni impedimento di natura, della legge dinastica e
del diritto morale.
La vocazione istrionica di Riccardo che, come è stato notato, rende
superfluo nel dramma il personaggio del clown, e da cui scaturisce la
particolare teatralità dell’opera, è analizzata nella scena quinta dell’atto
terzo, dove egli si produce con Buckingham nella finzione del presunto
complotto di Hastings nella Torre. La sua consumata ipocrisia si esalta
nella invocazione dei santi e nel suo falso puritanismo proprio mentre
medita e attua i suoi propositi delittuosi. A proposito della sua «devozione
verbale» Milton osserverà acutamente: «è sempre stato l’accorgimento più
astuto del tiranno simulare la religione». 7
Il protagonista, nel suo virtuosismo istrionico e nel suo criminale
dinamismo, campeggia sovrano nel dramma - più d’un terzo del totale dei
versi, 1150, sono suoi -, sfoggiando a ogni occasione uno humour
sinistramente ilare. Ma si avverte, al di là del personaggio, la visione
pessimistica della natura umana che, almeno in questa fase della sua
attività teatrale, Shakespeare sembra condividesse con la filosofia cristiana