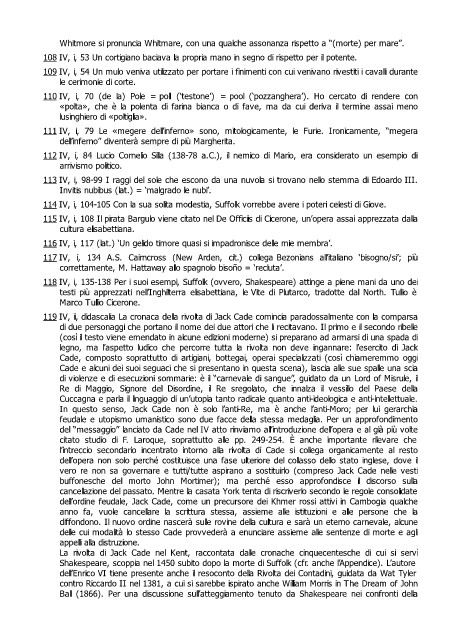Page 624 - Shakespeare - Vol. 1
P. 624
Whitmore si pronuncia Whitmare, con una qualche assonanza rispetto a “(morte) per mare”.
108 IV, i, 53 Un cortigiano baciava la propria mano in segno di rispetto per il potente.
109 IV, i, 54 Un mulo veniva utilizzato per portare i finimenti con cui venivano rivestiti i cavalli durante
le cerimonie di corte.
110 IV, i, 70 (de la) Pole = poll (‘testone’) = pool (‘pozzanghera’). Ho cercato di rendere con
«polta», che è la polenta di farina bianca o di fave, ma da cui deriva il termine assai meno
lusinghiero di «poltiglia».
111 IV, i, 79 Le «megere dell’inferno» sono, mitologicamente, le Furie. Ironicamente, “megera
dell’inferno” diventerà sempre di più Margherita.
112 IV, i, 84 Lucio Cornelio Silla (138-78 a.C.), il nemico di Mario, era considerato un esempio di
arrivismo politico.
113 IV, i, 98-99 I raggi del sole che escono da una nuvola si trovano nello stemma di Edoardo III.
Invitis nubibus (lat.) = ‘malgrado le nubi’.
114 IV, i, 104-105 Con la sua solita modestia, Suffolk vorrebbe avere i poteri celesti di Giove.
115 IV, i, 108 Il pirata Bargulo viene citato nel De Officiis di Cicerone, un’opera assai apprezzata dalla
cultura elisabettiana.
116 IV, i, 117 (lat.) ‘Un gelido timore quasi si impadronisce delle mie membra’.
117 IV, i, 134 A.S. Cairncross (New Arden, cit.) collega Bezonians all’italiano ‘bisogno/si’; più
correttamente, M. Hattaway allo spagnolo bisoño = ‘recluta’.
118 IV, i, 135-138 Per i suoi esempi, Suffolk (ovvero, Shakespeare) attinge a piene mani da uno dei
testi più apprezzati nell’Inghilterra elisabettiana, le Vite di Plutarco, tradotte dal North. Tullio è
Marco Tullio Cicerone.
119 IV, ii, didascalia La cronaca della rivolta di Jack Cade comincia paradossalmente con la comparsa
di due personaggi che portano il nome dei due attori che li recitavano. Il primo e il secondo ribelle
(così il testo viene emendato in alcune edizioni moderne) si preparano ad armarsi di una spada di
legno, ma l’aspetto ludico che percorre tutta la rivolta non deve ingannare: l’esercito di Jack
Cade, composto soprattutto di artigiani, bottegai, operai specializzati (così chiameremmo oggi
Cade e alcuni dei suoi seguaci che si presentano in questa scena), lascia alle sue spalle una scia
di violenze e di esecuzioni sommarie: è il “carnevale di sangue”, guidato da un Lord of Misrule, il
Re di Maggio, Signore del Disordine, il Re sregolato, che innalza il vessillo del Paese della
Cuccagna e parla il linguaggio di un’utopia tanto radicale quanto anti-ideologica e anti-intellettuale.
In questo senso, Jack Cade non è solo l’anti-Re, ma è anche l’anti-Moro; per lui gerarchia
feudale e utopismo umanistico sono due facce della stessa medaglia. Per un approfondimento
del “messaggio” lanciato da Cade nel IV atto rinviamo all’introduzione dell’opera e al già più volte
citato studio di F. Laroque, soprattutto alle pp. 249-254. È anche importante rilevare che
l’intreccio secondario incentrato intorno alla rivolta di Cade si collega organicamente al resto
dell’opera non solo perché costituisce una fase ulteriore del collasso dello stato inglese, dove il
vero re non sa governare e tutti/tutte aspirano a sostituirlo (compreso Jack Cade nelle vesti
buffonesche del morto John Mortimer); ma perché esso approfondisce il discorso sulla
cancellazione del passato. Mentre la casata York tenta di riscriverlo secondo le regole consolidate
dell’ordine feudale, Jack Cade, come un precursore dei Khmer rossi attivi in Cambogia qualche
anno fa, vuole cancellare la scrittura stessa, assieme alle istituzioni e alle persone che la
diffondono. Il nuovo ordine nascerà sulle rovine della cultura e sarà un eterno carnevale, alcune
delle cui modalità lo stesso Cade provvederà a enunciare assieme alle sentenze di morte e agli
appelli alla distruzione.
La rivolta di Jack Cade nel Kent, raccontata dalle cronache cinquecentesche di cui si servì
Shakespeare, scoppia nel 1450 subito dopo la morte di Suffolk (cfr. anche l’Appendice). L’autore
dell’Enrico VI tiene presente anche il resoconto della Rivolta dei Contadini, guidata da Wat Tyler
contro Riccardo II nel 1381, a cui si sarebbe ispirato anche William Morris in The Dream of John
Ball (1866). Per una discussione sull’atteggiamento tenuto da Shakespeare nei confronti della