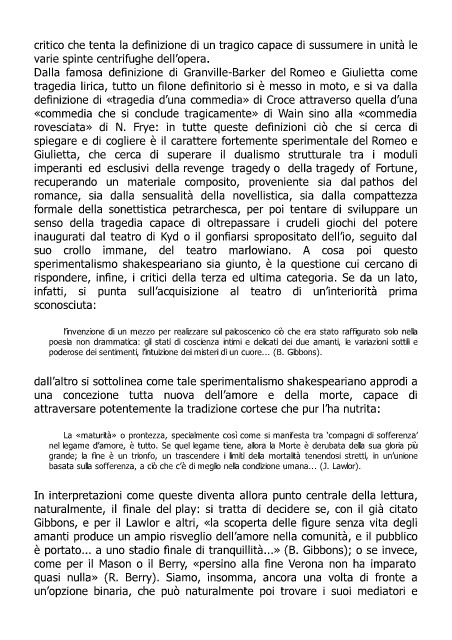Page 2984 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2984
critico che tenta la definizione di un tragico capace di sussumere in unità le
varie spinte centrifughe dell’opera.
Dalla famosa definizione di Granville-Barker del Romeo e Giulietta come
tragedia lirica, tutto un filone definitorio si è messo in moto, e si va dalla
definizione di «tragedia d’una commedia» di Croce attraverso quella d’una
«commedia che si conclude tragicamente» di Wain sino alla «commedia
rovesciata» di N. Frye: in tutte queste definizioni ciò che si cerca di
spiegare e di cogliere è il carattere fortemente sperimentale del Romeo e
Giulietta, che cerca di superare il dualismo strutturale tra i moduli
imperanti ed esclusivi della revenge tragedy o della tragedy of Fortune,
recuperando un materiale composito, proveniente sia dal pathos del
romance, sia dalla sensualità della novellistica, sia dalla compattezza
formale della sonettistica petrarchesca, per poi tentare di sviluppare un
senso della tragedia capace di oltrepassare i crudeli giochi del potere
inaugurati dal teatro di Kyd o il gonfiarsi spropositato dell’io, seguito dal
suo crollo immane, del teatro marlowiano. A cosa poi questo
sperimentalismo shakespeariano sia giunto, è la questione cui cercano di
rispondere, infine, i critici della terza ed ultima categoria. Se da un lato,
infatti, si punta sull’acquisizione al teatro di un’interiorità prima
sconosciuta:
l’invenzione di un mezzo per realizzare sul palcoscenico ciò che era stato raffigurato solo nella
poesia non drammatica: gli stati di coscienza intimi e delicati dei due amanti, le variazioni sottili e
poderose dei sentimenti, l’intuizione dei misteri di un cuore... (B. Gibbons).
dall’altro si sottolinea come tale sperimentalismo shakespeariano approdi a
una concezione tutta nuova dell’amore e della morte, capace di
attraversare potentemente la tradizione cortese che pur l’ha nutrita:
La «maturità» o prontezza, specialmente così come si manifesta tra ‘compagni di sofferenza’
nel legame d’amore, è tutto. Se quel legame tiene, allora la Morte è derubata della sua gloria più
grande; la fine è un trionfo, un trascendere i limiti della mortalità tenendosi stretti, in un’unione
basata sulla sofferenza, a ciò che c’è di meglio nella condizione umana... (J. Lawlor).
In interpretazioni come queste diventa allora punto centrale della lettura,
naturalmente, il finale del play: si tratta di decidere se, con il già citato
Gibbons, e per il Lawlor e altri, «la scoperta delle figure senza vita degli
amanti produce un ampio risveglio dell’amore nella comunità, e il pubblico
è portato... a uno stadio finale di tranquillità...» (B. Gibbons); o se invece,
come per il Mason o il Berry, «persino alla fine Verona non ha imparato
quasi nulla» (R. Berry). Siamo, insomma, ancora una volta di fronte a
un’opzione binaria, che può naturalmente poi trovare i suoi mediatori e