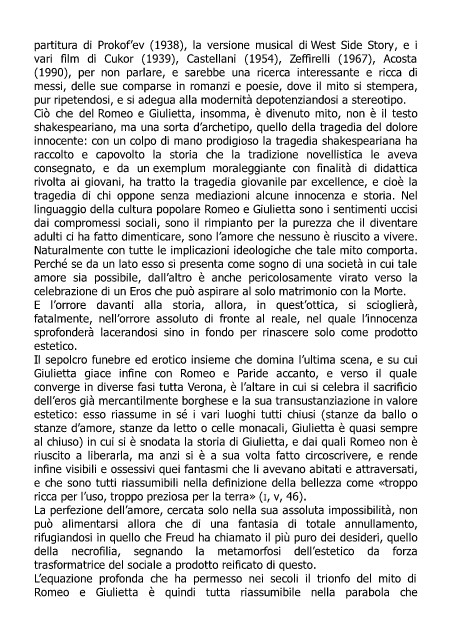Page 2986 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2986
partitura di Prokof’ev (1938), la versione musical di West Side Story, e i
vari film di Cukor (1939), Castellani (1954), Zeffirelli (1967), Acosta
(1990), per non parlare, e sarebbe una ricerca interessante e ricca di
messi, delle sue comparse in romanzi e poesie, dove il mito si stempera,
pur ripetendosi, e si adegua alla modernità depotenziandosi a stereotipo.
Ciò che del Romeo e Giulietta, insomma, è divenuto mito, non è il testo
shakespeariano, ma una sorta d’archetipo, quello della tragedia del dolore
innocente: con un colpo di mano prodigioso la tragedia shakespeariana ha
raccolto e capovolto la storia che la tradizione novellistica le aveva
consegnato, e da un exemplum moraleggiante con finalità di didattica
rivolta ai giovani, ha tratto la tragedia giovanile par excellence, e cioè la
tragedia di chi oppone senza mediazioni alcune innocenza e storia. Nel
linguaggio della cultura popolare Romeo e Giulietta sono i sentimenti uccisi
dai compromessi sociali, sono il rimpianto per la purezza che il diventare
adulti ci ha fatto dimenticare, sono l’amore che nessuno è riuscito a vivere.
Naturalmente con tutte le implicazioni ideologiche che tale mito comporta.
Perché se da un lato esso si presenta come sogno di una società in cui tale
amore sia possibile, dall’altro è anche pericolosamente virato verso la
celebrazione di un Eros che può aspirare al solo matrimonio con la Morte.
E l’orrore davanti alla storia, allora, in quest’ottica, si scioglierà,
fatalmente, nell’orrore assoluto di fronte al reale, nel quale l’innocenza
sprofonderà lacerandosi sino in fondo per rinascere solo come prodotto
estetico.
Il sepolcro funebre ed erotico insieme che domina l’ultima scena, e su cui
Giulietta giace infine con Romeo e Paride accanto, e verso il quale
converge in diverse fasi tutta Verona, è l’altare in cui si celebra il sacrificio
dell’eros già mercantilmente borghese e la sua transustanziazione in valore
estetico: esso riassume in sé i vari luoghi tutti chiusi (stanze da ballo o
stanze d’amore, stanze da letto o celle monacali, Giulietta è quasi sempre
al chiuso) in cui si è snodata la storia di Giulietta, e dai quali Romeo non è
riuscito a liberarla, ma anzi si è a sua volta fatto circoscrivere, e rende
infine visibili e ossessivi quei fantasmi che li avevano abitati e attraversati,
e che sono tutti riassumibili nella definizione della bellezza come «troppo
ricca per l’uso, troppo preziosa per la terra» (I, v, 46).
La perfezione dell’amore, cercata solo nella sua assoluta impossibilità, non
può alimentarsi allora che di una fantasia di totale annullamento,
rifugiandosi in quello che Freud ha chiamato il più puro dei desideri, quello
della necrofilia, segnando la metamorfosi dell’estetico da forza
trasformatrice del sociale a prodotto reificato di questo.
L’equazione profonda che ha permesso nei secoli il trionfo del mito di
Romeo e Giulietta è quindi tutta riassumibile nella parabola che