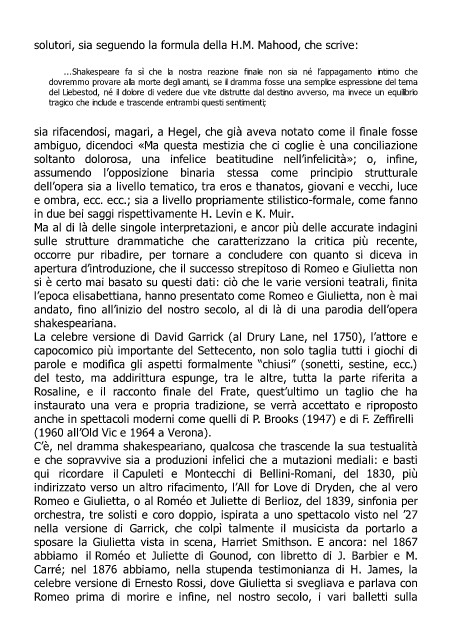Page 2985 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2985
solutori, sia seguendo la formula della H.M. Mahood, che scrive:
...Shakespeare fa sì che la nostra reazione finale non sia né l’appagamento intimo che
dovremmo provare alla morte degli amanti, se il dramma fosse una semplice espressione del tema
del Liebestod, né il dolore di vedere due vite distrutte dal destino avverso, ma invece un equilibrio
tragico che include e trascende entrambi questi sentimenti;
sia rifacendosi, magari, a Hegel, che già aveva notato come il finale fosse
ambiguo, dicendoci «Ma questa mestizia che ci coglie è una conciliazione
soltanto dolorosa, una infelice beatitudine nell’infelicità»; o, infine,
assumendo l’opposizione binaria stessa come principio strutturale
dell’opera sia a livello tematico, tra eros e thanatos, giovani e vecchi, luce
e ombra, ecc. ecc.; sia a livello propriamente stilistico-formale, come fanno
in due bei saggi rispettivamente H. Levin e K. Muir.
Ma al di là delle singole interpretazioni, e ancor più delle accurate indagini
sulle strutture drammatiche che caratterizzano la critica più recente,
occorre pur ribadire, per tornare a concludere con quanto si diceva in
apertura d’introduzione, che il successo strepitoso di Romeo e Giulietta non
si è certo mai basato su questi dati: ciò che le varie versioni teatrali, finita
l’epoca elisabettiana, hanno presentato come Romeo e Giulietta, non è mai
andato, fino all’inizio del nostro secolo, al di là di una parodia dell’opera
shakespeariana.
La celebre versione di David Garrick (al Drury Lane, nel 1750), l’attore e
capocomico più importante del Settecento, non solo taglia tutti i giochi di
parole e modifica gli aspetti formalmente “chiusi” (sonetti, sestine, ecc.)
del testo, ma addirittura espunge, tra le altre, tutta la parte riferita a
Rosaline, e il racconto finale del Frate, quest’ultimo un taglio che ha
instaurato una vera e propria tradizione, se verrà accettato e riproposto
anche in spettacoli moderni come quelli di P. Brooks (1947) e di F. Zeffirelli
(1960 all’Old Vic e 1964 a Verona).
C’è, nel dramma shakespeariano, qualcosa che trascende la sua testualità
e che sopravvive sia a produzioni infelici che a mutazioni mediali: e basti
qui ricordare il Capuleti e Montecchi di Bellini-Romani, del 1830, più
indirizzato verso un altro rifacimento, l’All for Love di Dryden, che al vero
Romeo e Giulietta, o al Roméo et Juliette di Berlioz, del 1839, sinfonia per
orchestra, tre solisti e coro doppio, ispirata a uno spettacolo visto nel ’27
nella versione di Garrick, che colpì talmente il musicista da portarlo a
sposare la Giulietta vista in scena, Harriet Smithson. E ancora: nel 1867
abbiamo il Roméo et Juliette di Gounod, con libretto di J. Barbier e M.
Carré; nel 1876 abbiamo, nella stupenda testimonianza di H. James, la
celebre versione di Ernesto Rossi, dove Giulietta si svegliava e parlava con
Romeo prima di morire e infine, nel nostro secolo, i vari balletti sulla