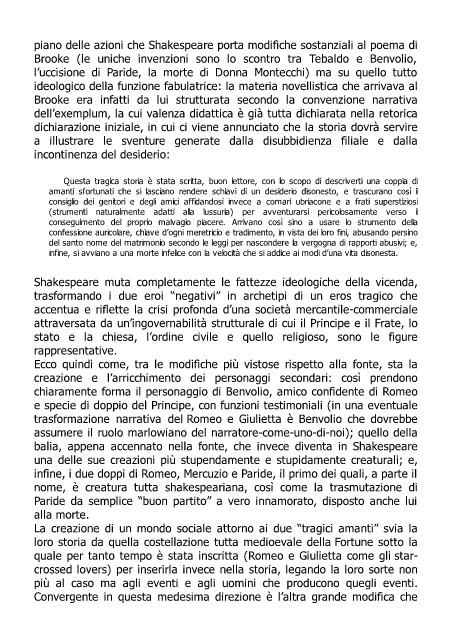Page 2981 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2981
piano delle azioni che Shakespeare porta modifiche sostanziali al poema di
Brooke (le uniche invenzioni sono lo scontro tra Tebaldo e Benvolio,
l’uccisione di Paride, la morte di Donna Montecchi) ma su quello tutto
ideologico della funzione fabulatrice: la materia novellistica che arrivava al
Brooke era infatti da lui strutturata secondo la convenzione narrativa
dell’exemplum, la cui valenza didattica è già tutta dichiarata nella retorica
dichiarazione iniziale, in cui ci viene annunciato che la storia dovrà servire
a illustrare le sventure generate dalla disubbidienza filiale e dalla
incontinenza del desiderio:
Questa tragica storia è stata scritta, buon lettore, con lo scopo di descriverti una coppia di
amanti sfortunati che si lasciano rendere schiavi di un desiderio disonesto, e trascurano così il
consiglio dei genitori e degli amici affidandosi invece a comari ubriacone e a frati superstiziosi
(strumenti naturalmente adatti alla lussuria) per avventurarsi pericolosamente verso il
conseguimento del proprio malvagio piacere. Arrivano così sino a usare lo strumento della
confessione auricolare, chiave d’ogni meretricio e tradimento, in vista dei loro fini, abusando persino
del santo nome del matrimonio secondo le leggi per nascondere la vergogna di rapporti abusivi; e,
infine, si avviano a una morte infelice con la velocità che si addice ai modi d’una vita disonesta.
Shakespeare muta completamente le fattezze ideologiche della vicenda,
trasformando i due eroi “negativi” in archetipi di un eros tragico che
accentua e riflette la crisi profonda d’una società mercantile-commerciale
attraversata da un’ingovernabilità strutturale di cui il Principe e il Frate, lo
stato e la chiesa, l’ordine civile e quello religioso, sono le figure
rappresentative.
Ecco quindi come, tra le modifiche più vistose rispetto alla fonte, sta la
creazione e l’arricchimento dei personaggi secondari: così prendono
chiaramente forma il personaggio di Benvolio, amico confidente di Romeo
e specie di doppio del Principe, con funzioni testimoniali (in una eventuale
trasformazione narrativa del Romeo e Giulietta è Benvolio che dovrebbe
assumere il ruolo marlowiano del narratore-come-uno-di-noi); quello della
balia, appena accennato nella fonte, che invece diventa in Shakespeare
una delle sue creazioni più stupendamente e stupidamente creaturali; e,
infine, i due doppi di Romeo, Mercuzio e Paride, il primo dei quali, a parte il
nome, è creatura tutta shakespeariana, così come la trasmutazione di
Paride da semplice “buon partito” a vero innamorato, disposto anche lui
alla morte.
La creazione di un mondo sociale attorno ai due “tragici amanti” svia la
loro storia da quella costellazione tutta medioevale della Fortune sotto la
quale per tanto tempo è stata inscritta (Romeo e Giulietta come gli star-
crossed lovers) per inserirla invece nella storia, legando la loro sorte non
più al caso ma agli eventi e agli uomini che producono quegli eventi.
Convergente in questa medesima direzione è l’altra grande modifica che