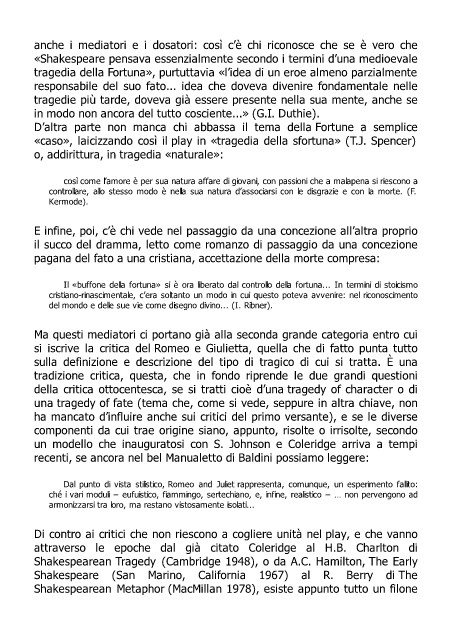Page 2983 - Shakespeare - Vol. 1
P. 2983
anche i mediatori e i dosatori: così c’è chi riconosce che se è vero che
«Shakespeare pensava essenzialmente secondo i termini d’una medioevale
tragedia della Fortuna», purtuttavia «l’idea di un eroe almeno parzialmente
responsabile del suo fato... idea che doveva divenire fondamentale nelle
tragedie più tarde, doveva già essere presente nella sua mente, anche se
in modo non ancora del tutto cosciente...» (G.I. Duthie).
D’altra parte non manca chi abbassa il tema della Fortune a semplice
«caso», laicizzando così il play in «tragedia della sfortuna» (T.J. Spencer)
o, addirittura, in tragedia «naturale»:
così come l’amore è per sua natura affare di giovani, con passioni che a malapena si riescono a
controllare, allo stesso modo è nella sua natura d’associarsi con le disgrazie e con la morte. (F.
Kermode).
E infine, poi, c’è chi vede nel passaggio da una concezione all’altra proprio
il succo del dramma, letto come romanzo di passaggio da una concezione
pagana del fato a una cristiana, accettazione della morte compresa:
Il «buffone della fortuna» si è ora liberato dal controllo della fortuna... In termini di stoicismo
cristiano-rinascimentale, c’era soltanto un modo in cui questo poteva avvenire: nel riconoscimento
del mondo e delle sue vie come disegno divino... (I. Ribner).
Ma questi mediatori ci portano già alla seconda grande categoria entro cui
si iscrive la critica del Romeo e Giulietta, quella che di fatto punta tutto
sulla definizione e descrizione del tipo di tragico di cui si tratta. È una
tradizione critica, questa, che in fondo riprende le due grandi questioni
della critica ottocentesca, se si tratti cioè d’una tragedy of character o di
una tragedy of fate (tema che, come si vede, seppure in altra chiave, non
ha mancato d’influire anche sui critici del primo versante), e se le diverse
componenti da cui trae origine siano, appunto, risolte o irrisolte, secondo
un modello che inauguratosi con S. Johnson e Coleridge arriva a tempi
recenti, se ancora nel bel Manualetto di Baldini possiamo leggere:
Dal punto di vista stilistico, Romeo and Juliet rappresenta, comunque, un esperimento fallito:
ché i vari moduli - eufuistico, fiammingo, sertechiano, e, infine, realistico - … non pervengono ad
armonizzarsi tra loro, ma restano vistosamente isolati...
Di contro ai critici che non riescono a cogliere unità nel play, e che vanno
attraverso le epoche dal già citato Coleridge al H.B. Charlton di
Shakespearean Tragedy (Cambridge 1948), o da A.C. Hamilton, The Early
Shakespeare (San Marino, California 1967) al R. Berry di The
Shakespearean Metaphor (MacMillan 1978), esiste appunto tutto un filone